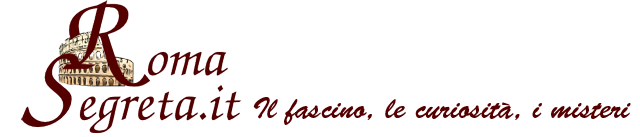Via de’ Ciancaleoni collega Via Urbana a Via Panisperna con un inconsueto andamento a “L” e prende il nome dalla famiglia Ciancaleoni, antica famiglia baronale romana che qui possedeva un palazzetto, oggi con ingresso al civico 45 (nella foto sopra).

L’edificio, costruito nel Cinquecento sui resti di edifici medioevali dei Ciancaleoni, presenta due grandi portali ad arco con portone ligneo ornato da due battiporta con protomi leonine (nella foto 1): lo stemma di famiglia, infatti, era costituito da un leone rampante.

Via de’ Ciancaleoni, nella Pianta di Roma del 1748 di Giovanni Battista Nolli denominata Vicolo di Ciancaleone, è collegata alla sottostante Via dei Capocci tramite una bella scalinata (nella foto 2) lungo la quale si può notare la base medioevale del palazzo costituita da una muratura a scarpa.
In occasione delle indagini archeologiche svoltesi negli anni 1969-1970 e 2007 nei piani interrati e seminterrati dei palazzi di Via de’ Ciancaleoni 45 e di Via Cimarra 37 sono state individuate due domus di età tardo-repubblicana, alle quali si affiancava a sud probabilmente una terza e che, per le loro dimensioni e lo stato di conservazione delle strutture, rappresentano una testimonianza importante dell’edilizia privata signorile del periodo. Quest’area del Colle Viminale fu infatti interessata da un piano urbanistico ben preciso che prevedeva la realizzazione di due terrazzamenti, uno inferiore accessibile dal Vicus Patricius ed uno superiore accessibile da un altro asse stradale che correva presso la sommità del colle. I terrazzamenti erano costituiti in gran parte da dimore signorili realizzate una accanto all’altra, digradanti verso sud, disposte ortogonalmente rispetto agli assi stradali e costruite in un lasso di tempo piuttosto vicino, tra la prima e la seconda metà del I secolo a.C. Sembra che dopo una fase di crollo e spoliazione delle strutture a piano terra, il piano interrato sia stato completamente abbandonato fino al riutilizzo, forse tra il XVII ed il XVIII secolo, di una parte degli ambienti come lavatoi.
Una triste storia nella Roma del Settecento è legata alla famiglia Ciancaleoni, in particolare a Fulvia Ciancaleoni, una ragazza nata da un’avventura di Fabrizio Ciancaleoni con una giovane popolana e riconosciuta come figlia soltanto in punto di morte. Il destino volle che la ragazza venisse affidata alle cure di Liberia Savelli, promessa sposa del giovane e nobile Paluzzo Astalli. Il ragazzo vide per la prima volta Fulvia a casa di Liberia ed immediatamente se ne innamorò. Non si sa se Liberia si accorse di tale sentimento ma per qualche tempo Paluzzo non vide più Fulvia che usciva di rado e rimaneva chiusa nella sua camera sotto stretta sorveglianza della domestica Prudenzia. I due si incontrarono però una domenica nella Chiesa del Gesù, a Messa, e riuscirono anche a scambiarsi qualche parola. La domenica successiva tornarono ad incontrarsi senza che Prudenzia apparentemente se ne accorgesse.
Poi accadde che Liberia si ammalò e così Paluzzo, frequentando più spesso la casa della fidanzata, ebbe l’occasione di avvicinare Fulvia e baciarla, suggellando il loro amore.
Ma Liberia guarì e probabilmente Prudenzia le rivelò ciò che stava accadendo. La Savelli non disse nulla e continuò a sorridere a Paluzzo quando questi si recava a visitarla. Trascorsero parecchi giorni senza che il giovane riuscisse a vedere Fulvia. La cercò due domeniche di seguito alla Chiesa del Gesù, ma inutilmente. Ed allora una mattina chiese a Liberia se avesse notizie di Fulvia: questa gli rispose che la ragazza si era rinchiusa spontaneamente nel Monastero delle Oblate a Tor de’ Specchi. Paluzzo comprese immediatamente che l’artefice fosse Liberia e ne nacque una furiosa lite che probabilmente sancì la rottura del loro fidanzamento. Paluzzo, innamorato pazzo, pensò soltanto a come tirare fuori Fulvia dal monastero e sposarla.
Era l’ultimo giorno di Carnevale quando il facchino di Ripa Grande soprannominato Sfrappone, ovvero il millantatore, il contafrottole, risalì in barca il Tevere con un grosso baule che gli era stato consegnato dal nobile Fiorello Capocci, amico intimo di Paluzzo. Giunto a Ripetta, Sfrappone s’incamminò con il grosso baule sulle spalle per consegnarlo all’indirizzo indicato, ma quel giorno a Roma si svolgeva la Corsa dei Barberi ed il destino volle che un cavallo colpì alla testa il facchino che rimase a terra esanime. Qualcuno tentò inutilmente di rialzarlo mentre qualcun altro spinse il baule dentro il vano di un portone.
Il giorno seguente due gendarmi videro il baule sul quale, sopra un cartoncino, vi era scritto: “A Fulvia Ciancaleoni, Monastero delle Oblate a Tor de’ Specchi. Contiene biancheria che invia Liberia Savelli”. Il baule fu consegnato al Monastero e Fulvia, sorpresa, lo aprì immediatamente: all’interno, tra biancheria varia, giaceva il cadavere di Paluzzo Astalli, il quale aveva progettato di penetrare nel Monastero in tale modo, così da creare uno scandalo che non poteva essere che soffocato con le nozze fra i due giovani. Purtroppo, il lungo tempo di permanenza all’interno del baule gli fu fatale: Fulvia, impazzita dal dolore, rimase tra la vita e la morte per molto tempo ma poi, rassegnata, prese i voti e divenne sposa non di Paluzzo ma di Dio.