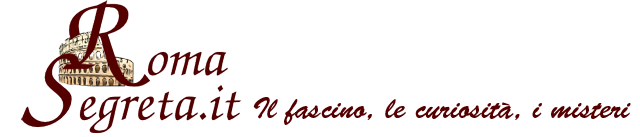La storia dei toponimi di Via del Corso è alquanto complessa a causa di vari eventi. Ai tempi di Augusto la via si chiamava Via Lata, mentre già dal Medioevo si chiamava Via Lata il tratto che dal Campidoglio giungeva a Piazza Colonna, mentre la parte restante, fino ed oltre la Porta del Popolo, era la Via Flaminia. Nel 1466 Papa Paolo II, il veneziano Pietro Barbo, stabilì le regole delle corse dei cavalli e volle che le feste del Carnevale si svolgessero lungo questa strada (mentre, fino ad allora, si svolgevano al Monte Testaccio), dall’Arco di Portogallo fin sotto Palazzo Venezia nel quale risiedeva: il toponimo, allora, cambiò in Via del Corso, con evidente allusione alle corse. Queste avevano come partecipanti gli ebrei, costretti a correre dentro i sacchi, i nani ed i buffoni tra i lazzi osceni del popolino. Si svolgevano anche le corse dei ragazzi, degli asini, dei bufali, ma, soprattutto, era attesa la corsa dei cavalli detti “barberi”, perché provenienti dalla Barberia (una vasta regione dell’Africa settentrionale), anche se i più appartenevano alle scuderie delle famiglie patrizie romane. Le povere bestie correvano “scosse”, cioè senza fantino, sollecitate da pece bollente sparsa nella parte posteriore o da palle con aculei assicurate alla groppa, fino a Piazza Venezia, dove andavano a sbattere contro grossi tendoni tirati attraverso una via, appunto chiamata Via della Ripresa dei Barberi (demolita alla fine del secolo scorso in occasione della costruzione del Vittoriano), dove, pronti, i loro proprietari o gli stallieri li riprendevano in custodia. Questo spettacolo carnevalesco fu abolito nel 1883 dal governo italiano, in seguito ad un incidente mortale occorso ad un ragazzo che, nell’attraversare la strada, fu travolto dai cavalli sotto gli occhi della regina Margherita. Dopo la Corsa dei Barberi del martedì grasso, e quindi alla chiusura del Carnevale, il popolo straripava nel Corso al grido univoco: Mor’ammazzato chi nun porta er mòccolo!. Era un gioco frenetico, un’esaltazione quasi selvaggia, una battaglia, dove ognuno cercava di soffiare e di spegnere il “mòccolo” (ossia qualsiasi cosa che bruciasse, fiammelle, torce, candelabri) del vicino, l’ultimo divertimento che salutava la fine del Carnevale. Sotto Pio IX, nella sera dell’Epifania del 1854, il Corso venne illuminato a gas per la prima volta. Si emanarono, poi, provvedimenti per trasferire in altro luogo i macellai, i tripparoli, i fegatai, i friggitori, i pollaroli, al fine di salvaguardare la decenza della via destinata al pubblico passeggio. Si aprirono, allora, negozi di confezioni e di alta moda, librerie, antiquari e gioiellieri. Nell’ultimo Ottocento era di rito la “trottata” al Corso, una sfilata di carrozze nelle quali sedevano nobili donne con elegantissimi abiti. All’indomani dell’assassinio del re Umberto I, avvenuto a Monza il 30 luglio 1900, la via fu battezzata “Corso Umberto I“; nel 1944, in seguito alla rinuncia di Vittorio Emanuele III alle prerogative sovrane, si ebbe il Corso del Popolo, ma due anni dopo si ritornò al vecchio toponimo quattrocentesco di Via del Corso.
La via è condivisa da quattro rioni: da Piazza del Popolo fino all’incrocio con Via Frattina appartiene al rione Campo Marzio; da Via Frattina fino all’incrocio con Via delle Muratte per il lato destro e Via del Caravita per il lato sinistro appartiene al rione Colonna; da qui fino a Piazza Venezia, per il lato destro appartiene al rione Pigna, mentre per il lato sinistro appartiene al rione Trevi.

Prendiamo ora in considerazione la zona di appartenenza al rione Pigna. Di fronte alla chiesa di S.Marcello, tra Via Alessandro Specchi e Via Lata, al civico 307 di Via del Corso si trova il Palazzo De Carolis (nella foto 1), costruito per il ricco commerciante Livio De Carolis di Profi, nonché Generale delle Poste Pontificie, su disegno di Alessandro Specchi tra il 1714 ed il 1724, fondendo alcune case della famiglia Grifoni e del Conte. Nel 1750, alla morte del De Carolis, il palazzo fu acquistato dalla Compagnia di Gesù, nel 1794 passò al marchese Giuseppe Simonetti e nel 1830 ai Boncompagni-Ludovisi, principi di Piombino, che provvidero a far restaurare il complesso. Nel 1908 fu acquistato dal Banco di Roma (oggi Banca di Roma) che affidò a Pio Piacentini il compito di rinnovare l’edificio: in particolare fu trasformato il cortile in salone per gli uffici aperti al pubblico e le scuderie in ambienti per gli uffici. La facciata è imponente e maestosa con triplice ordine di finestre a timpano arcuato o triangolare o decorate con conchiglie, mentre il cornicione a mensole reca elementi dello stemma dei Boncompagni-Ludovisi (il mezzo drago e tre sbarre). Il portone, sul quale domina una testa femminile e lo stemma della Banca di Roma, è ornato con quattro colonne doriche sorreggenti un ampio balcone. Il breve vestibolo immette in un piccolo cortile con fontana, in una parete del quale, all’altezza della seconda finestra del secondo piano, una lapide ovale è posta nel punto dove, nel 1849, durante l’assedio di Roma, arrivò una cannonata: il testo dice “Un colpo di cannone francese lanciò una palla in questo luogo il giorno 20 giugno 1849 alle ore 3 e 3/4 antimeridiane, del calibro da 24”.

La Fontana del Facchino (nella foto 2), realizzata nel 1580 per la Corporazione degli Acquaroli dal pittore fiorentino Jacopino del Conte ad ornamento della sua casa di Via del Corso, rappresenta un facchino, in particolare un acquarolo (o acquaricciaro) nel tradizionale costume riconosciuto della Corporazione, anche se una relazione di Luigi Vanvitelli del 1751 attribuisce l’opera a Michelangelo Buonarroti. Nel 1724 la casa di Jacopino del Conte venne demolita per la costruzione di Palazzo De Carolis, come sopra menzionato, e così la fontana, alimentata dall’Acqua Vergine, andò ad ornare la facciata del nuovo palazzo. Nel 1872, probabilmente per motivi di viabilità o per proteggerla dagli urti delle carrozze e dalle sassate dei ragazzi, fu trasferita nell’attuale sede di via Lata, lungo il lato destro del palazzo stesso. La fontana presenta un busto d’uomo col berretto, il volto sfigurato, con le maniche rimboccate e con un caratello fra le mani da cui versa acqua e si ritiene che raffiguri il facchino Abbondio Rizio, amante del vino, secondo l’epigrafe dettata dall’abate Godard, scomparsa quando la fontana fu trasportata dal Corso in via Lata. Era scritta in latino e diceva: “Ad Abbondio Rizio, coronato (facchino) sul pubblico selciato, valentissimo nel legar fardelli. Portò quanto peso volle, visse quanto poté; però un giorno, mentre portava un barile di vino in spalla e dentro il corpo, contro sua voglia morì”. La locuzione “in publicis stillicidiis coronato” (ovvero “coronato sul pubblico selciato”) si riferisce al fatto che, secondo un rito associativo, gli anziani della Corporazione usavano portare per le osterie il nuovo iscritto e gli facevano battere le natiche sul selciato pubblico, a significare che prendeva possesso del suo ruolo. Secondo il popolino raffigurava Martin Lutero, per altri M.Antonio De Dominicis, un intrigante gesuita imprigionato da Paolo V in Castel S.Angelo ed ivi avvelenatosi. La scelta del luogo si giustifica con la presenza in questa zona di numerose abitazioni e botteghe di acquaroli che di notte (per evitare le tasse) riempivano le botticelle con l’acqua del Tevere o della vicina Fontana di Trevi e di giorno la vendevano per strada o direttamente per le case. Questo mestiere durò circa fino alla fine del Cinquecento, quando cioè i pontefici ripristinarono gli antichi Acquedotti romani, rifornendo così abbondantemente la città di acqua. Il Facchino è anche una delle statue parlanti di Roma (insieme a i suoi colleghi Pasquino, Madama Lucrezia, Marforio, l’Abate Luigi ed il Babuino) alle quali venivano addossati epigrammi salaci contro le autorità papali o i personaggi più in vista dell’epoca.

A fianco del suddetto Palazzo De Carolis si trova la chiesa di S.Maria in via Lata (nella foto 3), fondata sotto Sergio I alla fine del VII secolo, ampliata nel secolo XI, completamente ricostruita nel Quattrocento e rimaneggiata nel Seicento. La magnifica facciata, opera di Pietro da Cortona, risale al 1662 e presenta un portico centrale, costituito da colonne corinzie, sormontato da una loggia pure a colonne con capitelli compositi; infine, al culmine della facciata è situato un frontone sormontato da una croce e da vasi fiammeggianti in pietra. L’interno, rinnovato in occasione dell’Anno Santo del 1650 da Cosimo Fanzago, presenta tre navate divise da 13 colonne rivestite di diaspro siciliano con capitelli ionici ed ospita il bellissimo altare maggiore, opera di Gian Lorenzo Bernini, con la “Madonna Advocata” attribuita a S.Luca. Inoltre vi sono le tombe di Giuseppe Napoleone Bonaparte e di Zenaide Bonaparte. Nei sotterranei vi sono conservati i reperti dell’antica basilica, costituita da sei vani, cinque dei quali furono recuperati da Pietro da Cortona ed affrescati: in questi ambienti, secondo la leggenda, vi avrebbero dimorato sia S.Paolo che S.Luca. In passato la chiesa era collegata con l’antistante Palazzo Odescalchi con un arco denominato “Arcus Novus“, eretto nel 303-304 da Diocleziano, in occasione del ventennale del suo governo. L’arco, decorato con rilievi reimpiegati da un grande altare di epoca claudia (probabilmente l’ara Pietatis), era chiamato anche Arco maggiore de via Lata e su di esso fu costruita la Torre degli Aldemari: fu distrutto al tempo di Innocenzo VIII (1491) per rinnovare la chiesa di S.Maria in via Lata.

Il tardo Barocco con punte di rococò caratterizza il grandioso Palazzo Doria-Pamphilj (nella foto 4), risultanza di palazzi eretti in diverse epoche. Le origini dell’edificio risalgono al 1505 quando il cardinale Fazio Santoro, titolare della chiesa di S.Maria in via Lata, acquistò una parte del terreno dove sorse l’intero complesso insieme ad alcune costruzioni, tra le quali la casa del primo cardinale del titolo di S.Maria in via Lata, Niccolò Acciapacci, il quale l’aveva fatta costruire nel Quattrocento e dove avevano abitato i porporati successori di quel titolo. Il cardinale Santoro fece demolire quella casa e ne fece costruire una più grande distribuita intorno a un grande cortile rettangolare a colonne, ancora esistente ed attribuito al Bramante. La costruzione non era ancora ultimata che papa Giulio II impose al Santoro di “donare” il palazzo a suo nipote Francesco Maria I della Rovere, una donazione che causò la morte per crepacuore del proprietario. Con l’acquisto di altre case limitrofe, i della Rovere ampliarono il palazzo e fecero costruire il portico, poi trasformato nei secoli successivi con due file di otto colonne per racchiudere il lato occidentale del giardino detto “dei melangoli”. Nel 1601 il palazzo fu acquistato da Pietro Aldobrandini con i soldi di papa Clemente VIII, suo zio: questi elevarono le due ali del cortile più grande e costruirono sul lato sud un’altana con tanto di emblema araldico della famiglia con la stella ad otto punte. Nel 1647 l’edificio passò ai Pamphilj, in seguito al matrimonio di Camillo Pamphilj, nipote di Papa Innocenzo X, con Olimpia Aldobrandini, che portò appunto in dote il palazzo. I Pamphilj si trasferirono così in questo palazzo perché quello di Piazza Navona fu regalato da Papa Innocenzo X ad Olimpia Maidalchini, la famigerata Pimpaccia. Camillo Pamphilj nel 1734 incaricò l’architetto Gabriele Valvassori di costruire la magnifica facciata tardobarocca che ancora oggi ammiriamo, nonché la splendida facciata su Piazza del Collegio Romano. La facciata su Via del Corso è inquadrata da cinque fasce bugnate verticali con tre portali (dal civico 303 al 305), di cui quello centrale adorno di quattro colonne con capitelli formati da gigli araldici; i tre piani presentano finestre architravate sormontate da finestrelle con timpano mistilineo al primo, finestre a timpano mistilineo con balconi a balaustra al secondo, finestre con cornice mistilinea al terzo, un sontuoso balcone centrale di travertino e due logge laterali curve e un cornicione con decorazioni di gigli e colombe col ramo di ulivo nel becco (stemma dei Pamphilj). Il palazzo, con l’estinzione dei Pamphilj, divenne proprietà dei Doria-Pamphilj.
Ad angolo di Via del Corso con Piazza Venezia si trova Palazzo Bonaparte (nella foto sotto il titolo), costruito per la famiglia d’Aste nel 1660 da Giovanni Antonio De Rossi, sull’area precedentemente occupata da due palazzetti rinascimentali originariamente proprietà di Giovanni Capoccia de’ Capoccini, poi dei Bonaventura ed infine dei d’Aste. Nel 1760 il palazzo fu acquistato dai marchesi Rinuccini di Firenze, poi nel 1818 da Letizia Ramolino, madre di Napoleone I, la quale vi dimorò fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio 1836. Nel 1905 l’edificio fu acquistato dai Misciatelli e poi nel 1972 divenne proprietà de “Le Assicurazioni d’Italia”. Sulla facciata barocca spiccano i vari piani, la cui disposizione è ben proporzionata; qui, tra finestre architravate e inferriate, con sottostanti finestrelle, si apre il portale ottocentesco, rifacimento di quello originario del De Rossi, sul quale poggiava un balcone: oggi lo sovrasta invece una finestra con lo stemma dei Bonaparte (l’aquila napoleonica), posto sopra il timpano curvo ornato da conchiglie. Al secondo piano le finestre presentano un timpano triangolare con lati curvi decorati con le teste di leone, stemma dei d’Aste. Il terzo piano presenta tre finestre con terrazzino in ferro alternate a due finestre quadrate. Un terrazzo a balaustra corona il palazzo e circonda un’altana a tre arcate su cui è scritto il nome “Bonaparte”. L’appartamento nobile era composto di nove saloni nei quali le pitture, le decorazioni a stucchi, le belle porte dipinte recano l’impronta dello stile settecentesco. Dal salone d’angolo, le cui finestre guardano su Via del Corso e su Piazza Venezia, si passa ad una loggia coperta dalla quale madama Letizia, divenuta cieca, si faceva descrivere il traffico e chiedeva alla dama di compagnia Rosa Mellini se i passanti alzassero lo sguardo verso l’abitazione della madre dell’imperatore.
> Vedi Cartoline di Roma