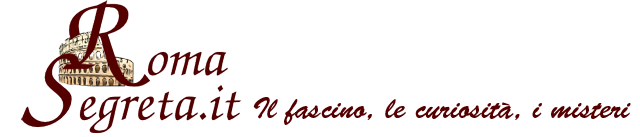A Monsignor
TOMMASO AZZOCCHI
CAMERIER D’ONORE E CAPPELLANO SECRETO
DELLA SANTITÀ DI PIO IX F. P.
Ho scritto de’ costumi del Popolo Romano non per avere grazia dai Romani, ma perchè mi parea che cotesto Popolo fosse mal conosciuto dal più de’ nostri, e bistrattato da molti forestieri che scrissero di lui, e scrivono tuttavia, senza averlo mai praticato.
L’antico Novelliere del secolo XIII diceva — Li cittadini di Roma sono mollo sdegnosi , grandi e popolari — e in queste tre singolari prerogative si sono mantenuti sino al dì d’oggi, nè per mutamento che facciano ne’ modi, nelle maniere e nelle usanze loro non cangeranno mai d’indole e di natura. Chi legge il mio libro accorgerassi, che le tre qualità sovrammentovate campeggiano nel 1860 come nel 1200.
Lo sdegno li rende subiti all’ira; la grandezza li fa generosi e magnanimi; la popolarità liberi, franchi e di lor senno. Forse, con tutto il gridare che fanno alcuni astiosi scrittori contro la tirannia pretesca, voi non troverete in tulta Italia un popolo più indipendente che il popol di Roma. Qui la libertà individuale e il diritto di proprietà è rispettato dal Governo e dal Municipio come cosa sacrata; nè per dirizzare una via si abbatterà la casipola del poverello, ov’egli non acconsenta; nè gli si torrà l’orticello per farne piazza; nè gli si darà multa per avere versato un po’ di acqua dalla finestra, o attaccato il suo cavallo all’inferriata da via; o disteso sui davanzali il suo bucato; nè gli si vieterà di sonar la cetera e cantare la notte una sua serenata; nè alle fanciulle di ballonzolare in ottobre nella contrada, o starvi a crocchio coll’arcolaio. Parlo dei quartieri popolani; perocché nel centro di Roma avvi tulle quelle convenevolezze che la presente civiltà addomanda; nè in questo la cede a qual siasi più ordinata e nobil Metropoli, se anco in alcuni particolari non le vince tulle.
Monsignore, io dedico a Voi questo mio lavorietto siccome una ricordanza di molti costumi, che ora, per izza de’ guastatori dell’antico, brigasi con ogni arte di far ismettere a questo popolo singolare, gridandosi a gola: che per isvivare l’oro della plebe romana dalla vecchia mondiglia, egli è di necessità usare lo svivatoio degli orefici, e passarlo gagliardamente per riforbirla e brunirla che luccichi e folgoreggi della Civiltà Universale. Rinciviliscanla pure cotesta nobil plebe; purché non a costo di quella Fede ingenita, ch’è il più bel tesoro e la più bella gloria di Roma.
Voi sì, Monsignore, che siete sì buon maestro in fatto di lingua, vorrei che adoperaste l’isvivatoio per ripulire alquanto il mio stile, che il più delle volte m’esce così sgovernato, che sente della fretta ond’io scrivo quando mi sopraggiunge l’ora di consegnare l’Articolo al Direttore della Civiltà Cattolica.
Voi, così stretto amico del mio dolce maestro il P. Antonio Cesari, non mi darete del profano perchè talora uso alcuni bei modi della voce viva. tolti dì bocca al popolo fiorentino, e non ancor registrati ne’ Vocabolarii; ma sì perchè mi può esser caduta dalla penna talora alcuna voce, o dizione che odori alquanto di forestiero Se v’abbatteste in alcuna d’esse, datele in viso senza pietà, ch’io ve ne sarò tenutissimo; dacché son persuaso, ch’egli non sia mai soverchio lo scrupoleggiare, ove trattisi della purezza e proprietà dello scrivere. Sicché, Monsignore, fate un po’ di bucato a questi miei cenci; e continuate a volermi di quel buon bene, che per umanità e gentilezza vostra da tanti anni mi addimostrate.
Iddio v’abbondi in ogni grazia.
Dalla Casa degli Scrittori della Civiltà Cattolica
presso il Vaticano, il dì 1.° gennaio 1860.
Antonio Bresciani
d. c. d. G.
INTRODUZIONE
La villa Borghese fuori di porta Flaminia è tutto insieme una gran possessione e un luogo di maravigliose delizie. Ell’è sì grande che spiccandosi dalla porta anzidetta costeggia il monte Pincio e ascende quasi insino agli orti Sallustiani, gittandosi poi largamente verso i monti Parioli, ove qui e là con miti erte salendo, si spande e signoreggia dall’alto la valle tiberina e le vaghe pendici di monte Mario. Quanto poi alle delizie noi crediamo che in tutta la sua ampiezza essa accolga i poggetti e le praterie di villa Panfili, i campi di villa Altieri, i giardini di villa Albani, i leggiadri boschetti di villa Torlonia, le prodicelle fiorite di villa Massimi e le cupe ombre degli alberi annosi di villa Lodovisi. Nella villa Borghese vedi fontane di larghissime polle, e schizzi e cascatelle, e sprazzi e ruscelletti, e fiumicelli e vivai, e pelaghetti ricinti d’erbe e di fiori, intorno ai quali crescono i pioppi, si specchiano i salici, ombreggiano i platani, gli uccelli cantano, i cigni nuotano, i sandalini remeggiano. Vedi torrazzi ruinosi, torricelle da vedetta, castellette del medio evo, ponti, acquedotti, anfiteatri, uccelliere, parchi, pascione di cavalli, chiudende di mannerini ispani, masserie di vacche, cascine daburro, case villerecce e nobili palagi pieni d’ogni singolarità di pitture a fresco, di fregi, d’arazzi antichi, di quadri a pennello de’ grandi maestri, sicchè ella è in tutto una villa degna di Re e Imperatori.
Tuttavia ciò che la rende più magnifica e illustre, e attrae le genti a vederla non è soltanto la frequenza delle carrozze, il brio delle cavalcate, l’immensa folla de’ cittadini e de’ forestieri che vengono a godere il rezzo di quelle ombre, la feschezza e limpidezza di quelle fontane, la lunghezza di quei viali, la varietà di quelle prospettive, la gaiezza di quei diporti e l’amenità di quei prati, di quei giardini e di quei boschi; ma sì bene lo stupendo museo ch’essa racchiude nel sontuoso palazzo detto del Cardinale.
Questo si leva sublime in mezzo al verde tappeto d’un prato circondato d’allori, a cui metton capo di molte vie spalleggiate a dilungo di cipressine e di mortelle, che a quando a quando sono interrotte da bianchi cippi e piedestalli, su cui posano statue, busti e vasi antichi di greco e romano scalpello. L’aggirano tutto intorno panconcelli dipinti e sedili di marmo che salgono dalle zolle fiorite, e ai canti avvi fontanelle e schizzetti d’acque luccicanti che ricascano come gemme brillantissime, sicchè il di fuori ti alletta invitandoti ad entrare fra quelle maravigliose bellezze. Il palagio è quadro, e di bella e ricca architettura: al primo ingresso t’accoglie un gran salone, che apre l’adito alle fughe di quelle camere, ognuna delle quali ti rapisce l’anima e tutta la richiama sugli occhi. Ogni camera è alta, sfogata e piena di luce: le sue volte e le sue pareti dipinte a vaghissimi freschi sono di vantaggio ornate di stucchi dorati, di cornici ad intaglio, di sogliari e di sovrapporte del più bel diaspro di Sicilia, di broccatello, di pavonazzetto, di bianco e nero d’Africa tirati a tanta lucidezza che sembrati oro brunito. I pavimenti poi, strati dei più ricchi marmi, sono commessi a così vaghi compartimenti e a tanto pulimento condotti, che passeggiandovi sopra ti vedi addoppiato; e l’occhio, il quale da tutte le parti è abbagliato, non sa ove si posare senza novello stupore.
Ma la sontuosità di queste in vero stanze reali è vinta di gran lunga dai tesori delle antiche arti che si contengono in esse. Imperocchè, oltre lo splendore delle statue greche e de’ busti, sono accolti in quelle i marmi più sovrani che avesse potuto cavare dalle miniere orientali e africane l’avidità e squisitezza romana ad ornamento dei suoi palazzi e delle sue ville, e a comodità della vita. Non v’ha forse privato museo in Europa che tanta rarità e copia ne contenga come il palagio di Villa Borghese. Ivi le tavole che son lungo le pareti e in mezzo alle stanze hanno per mensa lastroni di granitello, di serpentino, di porfido, di breccia d’Egitto, di ossidiana nerissima, di agata borracinata rossobruna; di legno agatizzato turchino, verde, rossiccio e a sfumature grigiognole, di verde antico, di persichetto e di molato africano. Altre sono a commessi di corniole; di prasme; d’onici di Siberia; di calcedoni violetti, brizzolati, cilestrini; di sardonici rossi, gialli e verdognoli; d’ametiste gemmate; di spinelli; d’agate diasprine; di lazzoli azzurroni a leccature d’oro; di diaspri d’ogni vena; di talchi punteggiati a verde moscone, a verde mare, a verde canna; di lumachelle; di quarziti; di pergmatiti; d’ofioliti; di malachiti; di vermiglie; d’onichette; di nicchilioni dorati; di berilli; di gariandri e di cent’altre pietre durissime, e della natura e preziosità delle gemme. Tutti poi cotesti marmi si combaciano, si congiungono, si frammettono con tanta puntualità di giugnimenti, che non ne puoi scernere le commettiture; di che ti paiono un sol marmo variegato e mischio a vive chiazze e macchio di colori cristallini e ingemmati.
Le figurazioni de’ vasi antichi, posti su per le mensole, sono svariatissime e ricercatissime; perocchè altri ne vedi di rosso antico ad anfora ed a canopo schietti, o baccellai, o con bei girari d’ellera intorno: altri di porfido spruzzolato di piastrellini di minio e d’incarnato o, ch’è più raro, di verde; altri sono lebeti di giallo antico, di basalto e di fluorite antica; altri son idrie d’alabastro fiorito, d’alabastro lumacato, d’alabastro ciliegino, d’alabastro schietto, o venato, o a onde; altri di corallina, di pario, di pentelieo, di nero africano, o di serpentino rubicondo, cilestro, e verde acceso e verde cupo. V’ha certo gran tazze a labbro quadrato col fondo a conca, le quali posano sovra piedestalli condotti con tanta grazia a nodelli, a treccette e puttini, che l’artifizioso trascende l’eccellenza della materia, essendo quasi tutte di rosso antico, di giallo antico, di nero antico, di breccia corallina , di breccia dorata, di breccia polizonia, di breccia smeraldina, d’agata, di sardonico, di calcedonio e di giacinto, che sono una vaghezza a vedere. Agli angoli delle camere e da lato agli usci son rizzate colonne d’altri finissimi marmi antichi, e sopravi busti di Consoli e Imperatori: qui vedi poste arche a bassi rilievi, e pile di fontane e a uso di bagni, tutte di granitone, di porfido, di basalto, di rossetto con labbra ben dechinate, con forme svelte e avvenenti, con bei rilievi di teste di leoni e di liopardi ai pispini, e con granfie pilose aguzze alla posatura.
Noi non toccammo il millesimo di quanto è ivi dentro di ragguardevole, di maestoso, di gentile, d’ottimo ed eccellente; ma tutto ciò è di vantaggio ravvivato dalle brigate de’ Romani e più de’ forestieri, che vengono a bearsi di quelle inestimabili accolte d’ogni bellezza d’arte e di materia. Il più piacevole a vedere tuttavia si è l’aria di cotesti forestieri, che calati da’ paesi tramontani, e venutici per mare, si trovan balzati d’improvviso in Roma, e cadon loro sott’occhio nelle ville de’ nostri signori di quelle cose che appena posson vedere, e in molto minor numero, nelle reggie de’ loro Monarchi. All’entrare in coteste gallerie spalancano tanto d’occhi , e corrono intorno avidamente, come se le statue, i busti e le dipinture volessero loro fuggire dinanzi. Vedresti certe persone lunghe lunghe, intirizzite, maghere, allampanate, con basettoni pettinati a sbiescio, con in capo certi cappellotti flosci e del colore di caffè e latte, in occhiali o in occhialin d’oro a molletta, col mento volto in su, con certi nasi affilati e rossi in punta, o con certi nasetti rincagnati che guardano la stella polare, colla bocca aperta e certe filiere di denti lunghi e bianchi come le nacchere: i più in certi soprabiti che piangono loro indosso e ricascano dalle spalle, con iscarpe a suola doppia, sopravi due borzacchini color di nocciuola coi bottoncini di madreperla. Le loro donne mingherline, asciutte e vestite di bigio piombo con certi cappelli in capo a catinella rovescia, o a faldoncini riboccati, dai quali pende una trinetta scura che le svisa, entrano a salterelli, e piantano subito sopra quei nasini due cannochialetti d’avorio guardando attorno, e crollandosi e brandendosi tutte, urtando spesso gli astanti così sgarbate, così attose, che il fatto loro è un fastidio.
Da un altro lato vedi invece cotali ometti piccoli, tarchiati, massicci e rubicondi, con due o tre soggiogale sotto il mento, col capo in zucca, lucido e tutto intorno coperto da certi biocoletti di capegli increspati dal pettine, i quali nell’alzare il cappello si rubellano al parrucchiere, e ricascano a serpentelli che diguazzano e si convolgono al vento. Quelle due dita di collo sono per lo più rinchiuse in una cravatta a crenolino che pare una gorgiera del medio evo, e nell’entrare mandano innanzi una peccia tondo-acuta, che ti ha l’aria di un otre vestito di velluto. Ora costoro, non so per quale bizzarra ventura, ci vengono per lo più porgendo il braccio a certe donnone che ti sembrano Giunoni, e se ne pavoneggiano, e vanno pettoruti e in contegni come i gallinacci che squassando i bargigli fanno la ruota.
Il bello poi è a vedere giovani pittori e scultori entrare con aria brava siccome chi viene in casa sua, e vedi loro in capo cappellacci alla sgherra, o cappelline guancite che pendono in sull’orecchio, e sotto vi scappa un zazzerone scarmigliato o a riccioletti che danzano loro in sulle spalle all’alternare dei passi: chi è in mustacchi biondi, quale in neri, chi halli a punta, chi arruffati, o pettinati all’ingiù che copron la bocca: altri sono a moschetta sul mento come Guido Reni, altri in mezza barba come il Coreggio, altri in barbone come Leonardo da Vinci e il Tiziano; colui aggrotta il ciglio, stringe e sporge le labbra; quest’altro ha un’ariona indolente e distratta, quello sbircia le statue vive e le va passando a rassegna. Intanto è uno andare, un venire, un soffermarsi, un tirar oltre continuo. Le Francesi esclamano: C’est délicieux! c’est charmant! Le Inglesi schiacciano fra i denti un beautiful! Le Tedesche mormorano chetamente: oh pràchtig! Sehr schòn! Le Polacche escono con enfasi: to bardzo piekno! Che tutte sono esclamazioni di maraviglia: Quant’è bello! quant’è magnifico! che prestigio! che delizia! Era l’ultimo giovedì d’ottobre, e il nostro don Alessandro mansionario di san Pietro con un suo buon amico d’Amelia era venuto al museo di Villa Borghese, ove accoglieansi di molti forestieri che già erano calati a Roma per passarvi la vernata. Ciascuno conosce don Alessandro: uomo complesso, attempato, esperto e di retto e squisito giudizio nelle cose, come ce n’ebbe dato buona prova nell’Ebreo di Verona. Mentre egli adunque interteneasi in una sala, ove mostrava all’amico un vaso d’alabastro molto artifizioso e con intagli di bellissima grazia, accostossi un oltramontano che dava il braccio a un giovane pittore lombardo, e baloccavasi con un’aria distratta fra quelle inestimabili rarità. Egli era protestante e stato già parecchie volte in Roma e dimoratovi a lungo, ma di Roma (come avviene a’ forestieri i quali non usano coi cittadini) sapeva soltanto ciò che avea udito dire ai Ciceroni di piazza; ciò che avea scorto sulle Guide scritte nei suoi paesi; ciò che avea letto in certi viaggiatori fantastici o maligni, e ciò ch’egli avea veduto co’ suoi occhi preoccupati dalle opinioni della sua educazione, i quali con sentimenti antigiudicati veggono le cose sotto falsi rispetti.
Costui, senza porsi mente attorno e parlando all’avventata, disse al pittore: Cotesti sciocchi Romani hanno tanto pellegrine cose a vedere, e non v’è pericolo che si disagino mai una volta per venirle ammirare; se non fossimo noi forestieri, le loro gallerie, i loro gabinetti, i loro musei e le loro pinacoteche sarieno deserte, piene di ragnatele, e nido di vespe e di sorei.
Don Alessandro colle sue mani conserte dietro le reni, alza gli occhi in faccia a costoro, e veduto il pittore, antica sua conoscenza, cui avea più volte commesso qualche opera di momento — Oh Carluccio, disse con un sorriso sardonico, di’ a questo bel zitello, ch’io sono Romano e lo colgo in bugia — Carlo abbassò gli occhi e arrossì alquanto dì quel suo malcreato compagno; ma don Alessandro ch’è uomo severo e in un piacevole assai , voltosi al forestiere disse: Signor mio, i Romani, vedete, nascono in mezzo a coteste meraviglie, e se ne pascono gli occhi e la mente sino dalla puerizia, ond’essi attingono quel senso dilicato del bello, che li fa giudicare così dirittamente e sottilmente degli oggetti d’arte. Io venni a questo palazzo d’ Alcina ch’ero putto tant’alto, e mio padre mi facea notare le destrezze, gli artifìcii, le leggiadrie dei disegni e delle fogge di cotesti vasi antichi; e nelle statue mi mostrava le proporzioni, le arie, le movenze, i sembianti, le fattezze, lepassioni, le guardature, gli atteggiamenti, le pose, la grazia, la fierezza e tutti, gli avvisi che si richieggono nello statuare cosi rispetto ai volti, come ai panneggiamenti; e quanto al decoro, alla maestà, all’avvenenza, all’armonia che dee spirare dal concetto dello scultore, e dal soggetto che imprende a rappresentare.
E come son venuto quivi le cento volte, così fui nella Villa Albani ad avvezzar l’occhio alle greche bellezze che sono in quella a tanta dovizia. Noi Romani abbiamo le nostre stagioni, e v’è quella da ir a vedere il Museo Vaticano, e il Museo Capitolino , e la Villa de’ Medici , e la Galleria Borghese nel suo palazzo urbano, e la Galleria Doria, e la Galleria Corsini, e la Farnesina. Anzi sappiate che persino i più belli oggetti antichi, i quali non s’aprono al pubblico, noi troviam modo e tempo da vederli parecchie volte per la cortesia e gentilezza de’ principi romani che ne fan copia volentieri a’ loro concittadini. Quante volte da garzoncello non fui a vedere le tele stupende, e le statue greche, e gli affreschi maravigliosi che fregiano i palazzi de’ nostri patrizii, che racchiudon tesori incredibili di tutte le arti belle antiche e moderne? E cosi qual dico di me, tal dico degli altri cittadini romani. Quei musei, quelle pinacoteche e quelle gallerie che molti di voi altri, nei vostri soggiorni di Roma venite al più un paio di volte a vedere, spesso correndo come cani bracchi, noi le vedemmo da bambini , portativi in braccio dalle madri nostre e sin dalle balie, e poscia, fatti grandi, dai maestri e dai padri; laonde quelle prime impressioni ci rimangono indelebili nell’animo, le rinfreschiamo nell’adolescenza e nella virilità, e le gustiamo nella vecchiaia. Il forestiere a quei detti rimase non so se più della franchezza e lealtà di don Alessandro ammirato, o dall’evidenza delle sue ragioni pago e persuaso; so bene che per l’una e l’altra cagione fu sì preso del Mansionario, che domandatogliene scusa , gli diè la mano e gliela strinse molto amorevolmente, dicendo: Mi disdico appieno della mia sguaiataggine; e imparerò d’ora innanzi a spogliarmi di molte false opinioni, che ho attinte dall’altrui ignoranza, dall’altrui malevolenza.
Allora don Alessandro gli disse molto piacevolmente: Signor mio, l’indole, i costumi e le consuetudini del popolo romano si differenziano grandemente da quelle di ogn’altro popolo d’Italia; egli ha una impronta tutta sua, e chi lo giudicasse da certe esteriori apparenze male il conoscerebbe; perocchè egli v’è in lui un misto di grande e di meschino, di sublime e d’abietto, di generoso e d’ignobile, d’attivo e di poltro, di feroce e di mite , di scioperato , di bizzarro, di sgovernato e superbo, ch’è cosa al tutto singolare; ma sotto quelle proprietà indefinibili vi trovate sempre il popolo cattolico per eccellenza, il quale serba viva e incontaminata quella FEDE ROMANA, che sì altamente in esso commendava san Paolo. E avvegnachè da vent’anni in qua si cerchi ogni via di schiantargliela dal cuore, vi prometto che perderanno la prova: meneran di gran guasto in parecchi, ma il vero popolo romano sarà sempre desso, e non muta; e tu Carluccio , che da tanti anni hai tua dimora in Roma, puoi attestarlo. Come si domanda qui il signore?
– Edmondo, rispose il giovane lombardo, ed è nobil uomo, amico e conoscitore delle belle arti, ch’egli promuove assai colle sue ricchezze favorendo gli artisti.
— Io, riprese il forestiere, voglio passarvi buono quanto mi asserite del popolo romano; ma io vi supplico di concedermi che s’egli ha la Fede, che voi mi dite, è la mostra ben poco: e con tutto ch’io sia protestante ho avuto più d’una volta occasione di recarmi a scandalo i suoi portamenti in ciò ch’è osservanza delle pratiche della Chiesa romana; siccome il digiuno e il maghero delle vostre quaresime, delle vostre vigilie e de’ giorni comandati, ch’io nelle case, in cui presi alloggio e in sugli alberghi, ov’io torno ogni giorno pel desinare, veggo farsi grasso nè più nè meno come a Londra, all’Aia e a Berlino.
— S’egli è per cotesto, potrei rispondervi, signor Edmondo, che ne sono in gran parte cagione gli oltramontani che ci scendono ogni anno in Roma a migliaia, e sviano di molti col loro esempio: se non che non è ora il momento d’entrare in questi meriti: ciò che rileva al presente si è di sceverare nel popolo romano la pula dal frumento, e l’oro dalla mondiglia, col formarsene un’idea giusta e adeguata.
— Io chiamo Romani, disse Edmondo, quelli che hanno domicilio in Roma.
— Non basta. Egli si vuol fare di molte distinzioni, ch’io reputo necessarie, e a voi torneranno di gran chiarimento in molte occorrenze. Primieramente considerate che dal novembre a quasi tutto l’aprile voi dovete noverare dai venticinque ai trentamila forestieri, i quali ci vengono per godere la mitezza dei verni di Roma, la serenità del suo cielo, la delizia delle sue ville sempre verdi, l’amenità dei suoi poggi, la magnificenza de’ suoi templi e de’ suoi palagi, le memorie della sua antica grandezza , le ruine dei suoi fori e de’ suoi teatri , l’inestimabile dovizia ivi accolta delle arti greche, etrusche e romane; le maraviglie del secolo di Leon X nelle architetture del Bramante, nelle sculture del Bonarotti, nelle dipinture di Rafaello , nelle munificenze di Giulio II, di Paolo III, di Sisto V. Molti de’ Cattolici vi si conducono per le auguste cerimonie del Natale di Nostro Signore, della Quaresima e della Pasqua; ma la maggior parte de’ forestieri ci viene a diletto , e i più sono protestanti di tutte le Confessioni, come voi solete appellarli. Un terzo almeno di tanti forestieri (fra’ quali avvi di nobilissime e ricchissime famiglie) hanno seco alcun servitore, e tutta cotesta gran brigata di signori e fanti vivono su per gli alberghi, e vonno fare buon vitto e delicato; laonde il maghero alloggia fra i Certosini , e non alle tavole delle albergherie. Aggiugnete che tutta cotesta gente vuol darsi vita e tempo, e cavarsi ogni capriccio; nè v’è diporto ov’essi non ne colgano il fiore: assai di costoro sono smogliati e, per que’ cinque o sei mesi del loro soggiorno in Roma, vivono a scotto nelle case private, facendo grasso il venerdì, il sabbato e le vigilie; chi gli accoglie sono comunemente genti ordinarie, vedove di decani de’ Cardinali ; create de’ principi romani che godono soldo, serventi di qualche Prelato , cui morendo lasciò il mobile e un po’ di legato vitalizio; zitelle pensionarle, o simil gente, che avendo forestieri in casa, per non fare due cucine, s’acconciano una coscienza erronea, e mangiano della stessa pentola. Chi giudicasse Roma a questo ragguaglio n’andrebbe forte ingannato.
In Roma è un’altra classe numerosa di persone, che v’han lunga dimora, e i forestieri che ci capitano, li reputan Romani, e i più non sono davvero. Noi li domandiamo artisti, e vi comprendiamo pittori, scultori, incisori, intagliatori, gessai, stuccatori che vengono a studio del disegno e delle arti speciali, cui s’addicono. Questi sono forestieri per la maggior parte: svedesi, danesi, russi, polacchi, tedeschi, inglesi, svizzeri, francesi, spagnuoli, italiani e greci, e s’io vi dico che in Roma avvene ben dieci mila, dicovi poco. Or quasi tutti sono scapoli e giovanotti; ingegnosi, acuti, fantastici e di nuove condizioni, poichè l’immaginazione li domina e l’estro gli stimola e fruga. Pensate vita che menano in Romal Lontani dalle loro famiglie, soli, senza testimonio che gli osservi, colle amicizie che formano, coi danari che più o meno ricevono dai parenti, dalle Accademie o dalle Corti che li mandano a studio. Se un forestiere giudicasse di Roma dai loro portamenti, voi stesso capite bene se il suo giudizio sarebbe falsissimo. Costoro non vogliono malinconie , vivono alla carlona in una stanzetta a pigione; oggi pranzano colla brigata in piazza di Spagna; domani a fontana di Trevi; un altro giorno al Tritone; un altro da Spilmann, da Lepri, e persino in borgo san Pietro se studiano in Vaticano. Oh sì, ormateli se sapete!
Ora veniamo alle molte migliaia di servitorame che formicola per le sale, per gli alberghi, per le stalle e per le vie di Roma: sopra i dieci i nove e mezzo sono forestieri, o se alcuni nacquero in Roma, son figliuoli di forestieri; né da questi puossi conghietturar l’indole del popolo romano, ancorachè appartengano alla classe popolana e vivano mescolati co’ popolani. Essa è tutta gente che ci viene in Roma coi Prelati d’ogni regione, cogli ambasciatori, coi principi e coi monarchi, i quali scelgono la stanza della metropoli del mondo cristiano. Voi ci avete inoltre più di cinque o sei mila carrozze, i cui cocchieri son quasi tutti regnicoli; altrettanti mozzi di stalla che sono quasi tutti abruzzesi; camerieri de’ numerosissimi alberghi, che son venuti a cercar loro ventura ; garzoni d’osterie , di pasticcerie , di taverne: niun Romano ci troverete di certo.
Forse Roma, la quale non ha villaggi e terre vicine, è l’unica città, in cui si domino i cavalli; e ove li scozzoni
da sella e da cocchio sieno così numerosi , che facciano quasi una brigata speciale. Questi son uomini d’ordinario grandi, muscolosi, gagliardi, atletici, avvezzi da fantini nell’agro romano in mezzo alle mandrie delle cavalle, sempre in lotta cogli stalloni da razza, sempre per le macchie e per le paludi tiberine in caccia de’ puledri sviati e randagi, che accappiano gittando loro alla testa, come i torieri peruani, lacci scorsoi con una destrezza mirabile; costoro sanno slanciarsi al collo di que’ ronzoni indiavolati, e mentre più imbestiano e imperversano s’afferran loro alle criniere, e tanto vi s’aggavignano, che li stringono alle froge, o lor calano un pannaccio sugli occhi e gli arrestan di tratto. Venuti finalmente in Roma co’ puledri s’accontano coi domatori e cogli scozzoni, i quali hanno i maneggi assegnati nelle grandi cavallerizze de’ principi romani, nelle scozzonerie del Quirinale, di Campo Vaccino, del Circo Massimo, e d’altri luoghi determinati. Ora figurate voi uomini che deono esser costoro; e se voi li potete annoverare fra i cittadini romani: gente sempre in giostra con quelle bestie indomite, il cui linguaggio sono imprecazioni, urli, bestemmie; i quali dopo tre ore di buglia e di batosta escono sudati, stracchi, trafelati dal maneggio e dalle stalle per passare alla taverna a gozzovigliare e tracannare. Costoro formano in Roma una plebe a sè, nè usan con loro se non vetturini, sensali, postiglioni , stallieri, barbereschi e simil volgo. Io credo per cerio che voi non cercherete la pietà, nè la gentilezza, nè l’urbanità romana fra questo lignaggio di gladiatori.
Nè il viaggiatore ha terminato ancora di sceverare ciò ch’è nostrale da ciò ch’è forestiero in Roma. Dovete arrogere i carbonai, che son quasi tutti genovesi e toscani; i norcini, i salumai, i caprettari, i venditori d’uccellame e di selvaggina: tutti cotesti sono popoli avveniticci. Poneteci altresì i gramignai, i lattugai , i cicoriari , una gran raunata di famiglie che ci vengono dagli Emici, dalla Matrice, e dai paesi intorno al Liri, i quali escono per l’agro romano in cerca di gramigna e di cicoria e recanla poscia alle donne loro, che la vendono per le piazze e per le vie di Roma, e sono quelle che portano in capo quello sciugatoio a bendoni, vanno in sandali che allacciano su per la gamba colle guigge e colle funicelle sì bellamente intrecciate, e serrano alla vita quegli scheggiali verdi, rossi o cilestri filettati di nastro giallo. Le matriciane sono per lo più le ortolane che vendono gli erbaggi e portano in capo il pannistrato, che cosi nomano alla latina il piccol manto di lana o di cotonella. Tutte coteste famiglie non c’è dubbio che possano mescolarsi mai coi trasteverini o coi veri montigiani; poichè nè ce le vorrebbono , nè, se per caso alcuna vi si traforasse, sarebbevi se non come forestiera, e chiamerebbonli l’aquilano, il ciociaro, il marchegiano, ecc., di generazione in generazione. A cotesti si aggiungono le lattaie, le ciambellaie e quanto v’ha di fantesche in Roma, che son tutte foresi venuteci dall’Umbria, dalla Sabina, dagli equi e dalle terre dei monti laziali, degli artemisii e dei cimini.
— Oh che ci riman egli adunque di Romano in Roma? esclamò il forestiere. E don Alessandro, soggiunse: Avvene anche di soverchio. Roma è composta dell’alto patriziato romano, della borghesia, degli artigiani, de’ mercatanti, del clero, e de’ popolani dei Monti e di Trastevere, ordini numerosi che compongono la vera Roma; e credo saldamente che in questi (ad onta di tante seduzioni e di non pochi sedotti, massime negli ultimi anni precorsi) vi sia ancora viva e fiorente la fede, che, come vi accennava dianzi, loro ascrive con tanto encomio san Paolo, e ch’essi trasfondono in gran parte o rinsaldano in que’ forestieri che fanno lunga dimora in Roma, quando non vogliano chiuder gli occhi alla luce.
Roma vive nella memoria delle sue antiche grandezze, quanto all’indole fastosa e superba del suo popolo; ma quanto alla religione, Roma germoglia frutti di pietà e di fede perenne, perchè pasce le sue profonde radici nel terreno annaffiato dai sangue di tanti milioni di Martiri: siede e riposa sopra le sacre volte delle sue Catacombe; conserva nel suo seno il venerato deposito dei sepolcri di Pietro e Paolo principi degli Apostoli, e dei più generosi Campioni della Fede di Cristo; visita il carcere Mamertino eTulliano , in cui Pietro e Paolo furon per nove mesi sepolti vivi , e non ne uscirono che l’uno per essere crocifisso sul Gianicolo e l’altro per lasciar la testa sul ceppo: visita il carcere d’Appio decemviro, ove in quei sotterranei paurosi e tra la muffa di quei petroni gemeano incatenati tanti confessori di Gesù; visita i Fori ove i Martiri si bruciavano sulle cataste; visita gli, anfiteatri, ove si gettavano ai leoni, alle tigri e ai leopardi; visita i palazzi conversi in templi de’ santi martiri patrizii Giovanni e Paolo, di santa Cecilia, di santa Balbina, di santa Prisca, di santa Bibiana, di santa Prassede e di santa Francesca romana; visita le case e le camere, ove abitarono e si santificarono sotto gli occhi suoi santa Brigida, santa Caterina di Siena, san Filippo Neri, san Camillo de Lellis, san Giuseppe Calasanzio, sant’Ignazio, san Luigi, santo Stanislao, san Pio V, san Felice Cappuccino , il beato Leonardo da Porto Maurizio, il beato Paolo della Croce, e da quelle camere esce piena di compunzione e di Fede.
Ma Roma vive e regna potente nel successore di Pietro, che siede sulla rocca Vaticana , Capo e Maestro infallibile della Chiesa. La presenza del Padre dei fedeli è per Roma ciò ch’è l’anima rispetto al corpo. Senza il Sommo Pontefice Roma sarebbe già da molti secoli come Babilonia, come Ninive, come Ecbatana, Susa, Palmira e Menfi , un acervo di ruine, che darebbero appena indizio ov’era un di la conquistatrice e la imperatrice del mondo. La presenza del Gran Gerarca la fa centro dell’orbe cattolico , e fonte vivo e inesausto di luce che spande sulla terra i raggi folgoranti della vera Fede, della vera sapienza e della vera civiltà. I Romani si beano di quella luce, e in quella , e di quella, e con quella vivono e alimentano l’ingenita fede che gli anima e li governa.
— Ai Romani, ripigliò l’uomo d’oltremonti , più della Fede importa mangiar bene, ed ispassarsi meglio; Panem et circenses, è il vecchio proverbio di Roma.
— S’egli è poi per cotesto, rispose con un po’ di sdegnuzzo don Alessandro, crederò che tutto il mondo sia romano: mangiare e trastullarsi fu sempre la divisa dei figliuoli d’Adamo.
— Sì, ma i Romani amano di lavorar poco, di guadagnar molto, di vivere a uffo e non perdere i loro diporti. Dove, di grazia, vedeste voi mai la plebe delle città d’Europa andare in carrozza e pavoneggiarsi e trastullarsi tanto come la plebe romana? Noi siamo in ottobre, e i giovedì e le domeniche voi vedete correre di molte centinaia di cocchi per Roma e per le deliziose villette del suo contorno, piene di popolani che vanno ad autunnare con un fasto, con un brio, con un tripudio , ch’io ne disgrado altrove le famiglie più benestanti dell’ordine cittadino.
— La favola significa, ruppe don Alessandro, che dunque il popolo romano non è quel pitocco, quel cencioso, quello schiavo roso dai pidocchi che vanno descrivendoci e lamentandoci i giornali di quelle nazioni, le quali si predicano per le più fiorite, ingentilite, libere e felici del mondo. A miglior agio, signor Edmondo mio , vi sciorrò di molti dubbii intorno al popolo romano, e vi dipingerò alcune sue costumanze particolari , e mi fo certo che le non vi dispiaceranno, e almeno vedrete, che forse egli è il popolo men disagiato e meno infelice che abbiate mai conosciuto. Intanto andiamo a gustare anche noi un po’ della letizia romana all’anfiteatro.
— Che? ci ha egli qui presso un anfiteatro?
— E grandissimo e vaghissimo a vedere; perocchè ha i gradi erbosi e freschi ed ombrati dai vivi padiglioni ondeggianti d’alberi secolari. In questa villa in autunno si sogliono dare alcune feste al popolo romano, che vi accorre in gran folla. Altre volte è una corsa di barberi, è una tombola, è l’alzata d’un pallone areostatico, è una mostra di saltatori a cavallo, o di ballerini da corda: quest’oggi è l’albero della cuccagna. Così detto avviaronsi di buon passo all’anfiteatro, che si chiama il Campo di Siena, perchè è foggiato a simiglianza della gran piazza di quella città.
Egli è un’immensa prateria tutta girata con iscaglioni erbosi ad elittica , sui quali seggono di molte migliaia di popolani vestiti a festa; i quali, dopo aver fatto la loro corsa in carrozza alle cantine di Ponte molle, di monte Mario e di Tor di Quinto, vengono alla cancellata di villa Borghese, e quivi smontati, entrano e si diportano all’ombra di quei boschetti e di quei macchioni di roveri e d’elei, sinchè approssimandosi l’ora de’ giuochi tutti convengono all’anfiteatro. Quel giorno era piantata nel mezzo un’altissima antenna liscia come l’avorio e insaponata dalla cima al fondo. In vetta era posta una borsa di trenta scudi, e attornovi appesi salami, salsicciotti, prosciutti, anatre e gallinacci.
Avresti veduto qui da piedi un buon centinaio di monelli scamiciati guardare in su bramosamente e anelare al conquisto di sì ghiotta imbandigione. Già fanno abbasso i loro conti, e gli amici e i parenti dicon fra sè: ce li mangeremo all’osteria del Carciofoletto; ed altri a quella del Sole, anzi noi a quella dell’Olmo. — Detto, fatto. Un birboncello della Suburra spicca un salto, abbraccia il pedale, e su e su — Bravo, coraggio — Ah! fa un cimbottolo e giù. La gente ridere, e il cattivello si scrolla — A me, a me grida un mariuoletto di piazza Padella, si sputa sulle mani, e izza: ma che! gli è giunto a dieci, dodici palmi, e tuffete; il tomo è fatto. Dalli, un altro, e un altro, e un altro; ma le tombolate succedonsi rapidissime, e le risa de’ popoli erano un mare in burrasca. Un gaglioffo di via dell’Oca pensò un tranello e, rubato a un bischetto di ciabattino un panetto di pegola, erasela a un po’ di fuoco distesa sui calzoncelli fra le cosce, e cosi calda, aspersa di rena; laonde gridato: A méne; e abbracciato l’antenna, fu tutto un punto. Erasi inerpicato già quasi a mezzo, e la gente incuoravalo, plaudivalo, gridando: Bene! animo! La borsa è tua. Il tapinello arrancava, anfanava, s’arrangolava, e intanto la rena dal lungo strisciare erasi consumata, e la pece sul sapone non facea presa; di che il meschinello in un lampo fu a pie dell’albero, guardando in su, e dicendo fra sè: io non ti mangerò.
La speranza non muore mai. Con tutto che fossero fallite tante prove, eccoti un mozzetto del naviglio di Ripa Grande farsi innanzi, abbracciare l’antenna , incrociare le gambe e arrampicarsi un tratto. Ma come fu giunto a sei braccia, lo scaltro si trasse dal seno un funicino rinforzato che aveva in capo una palla di piombo, e gittatolo attorno all’antenna velocissimamente, lo vi attorcigliava a molti giri, e il putto lung’esso strisciavasi in alto; e siccome l’antenna assottiglia vasi verso la cima, e la funicella faceva più giri, cosi meglio vi s’atteneva: onde l’astuto pervenne al vertice, prese la borsa, ficcossela in seno, tolse dall’arpione i salami e l’altro camangiare, gittandolo giù ai marinai che delle loro fascie faceano grembo. Intanto la musica militare intuonò una gagliarda; le grida, i battimenti, i tripudii del popolo intronavano l’aria, e il mozzetto sceso a terra si presentò tutto lieto alla loggia del Principe , il quale con molte gentildonne e signori romani, l’accolse a gran festa e lodollo del suo stratagemma.
LA FEDE ROMANA
Il giorno di santa Cecilia erano rimasti di trovarsi insieme alla festa don Alessandro, Edmondo e Carlo pittore a udir sonare quel famoso accompagnamento d’arpa e di flauto al canto dell’antifona : Cantantibus organis, modulato dal soprano e dal tenore, il soprano con voce argentina e dolcemente pastosa usciva in trilletti sì fini e dilicati che vinceano i gorgheggi della rondinella; e l’arpa e il flauto, ciascuno da sè, uniti a conserto, davano a quella melodia una soavità e una grazia che rapia l’animo degli astanti.
La basilica era messa a festa di vaghissimi veli e arazzi che pendeano dalle vòlte e dalle pareti; la Confessione era illuminata da quelle numerose lampane a traforo dorate che v’ardono tutto l’anno; la cancellata che circonda la nicchia della Santa era a bei compartimenti piena di facelle e di ciocche di fiori pellegrini, che le davan l’aria d’un giardino celeste scintillante di stelle fra i cespi delle peonie, delle camelie, delle ortensie, delle giorgine, delle dalie e delle rose. La statua poi, opera illustre del Maderno, bellamente coricata nella nicchia e involta in una vestetta lina, volge graziosamente il capo dopo le spalle (come fu ritrovato nell’antico loculo) e avvegnachè ci nasconda il viso, pur tanto nella dolce piegatura del collo ne mostra, che tu coll’occhio dell’anima la vedi raggiare d’un’angelica bellezza di paradiso.
Udite le armonie, i tre amici scesero nel sotterraneo, in che riposa da tanti secoli la salma della Vergine suonatrice, ed ivi i due cattolici adorarono, e il protestante ammirava la dipintura del Vanni nella lunetta, che rappresenta Cecilia giacente e semiviva pei tre tagli nel collo fattigli dal carnefice, e due vergini cristiane che la mirano con una santa invidia, e con una spugna e con panni lini ne raccolgono il sangue da venerare come reliquia di martire. Intanto i tre amici erano urtati da una folla di Romani che scendeva a venerare la Santa per l’andito che volge dal corno dell’epistola, e risale per quello del lato dell’evangelio.
Don Alessandro, quando si fu rizzato da pregare dinanzi all’arca benedetta, frugò col gomito Edmondo, dicendogli all’orecchio: Vedete, amico, ove i Romani attingono le acque limpide della Fede? Queste urne de’ martiri sono le fonti perenni che la rampollano, e di loro purezza fecondano il seno immacolato della Chiesa di Dio. Quei Romani, che paiono all’occhio di molti non aspirare se non alle feste e ai diporti, vedete con quanta pietà convengono ai sepolcri de’ martiri; e ve n’ha di molti, che, per lontani che siano dalle loro dimore, non mancherebbero di visitarli ad ogni patto. Quello che voi vedete fare quest’oggi ai Romani continuasi di fare dal primo secolo della nostra redenzione senza interrompimento: laonde considerate come in ciò i protestanti mentono a sè medesimi. Conciossiachè essi, in fra gli altri, tolsero eziandio il culto de’ Santi e la venerazione delle sacre immagini, dicendo che cotesta idolatria fu introdotta dalla superstizione della Chiesa cattolica, la quale, secondo essi, si corruppe dopo il terzo secolo; quando noi mostriamo tuttogiorno ai protestanti sempre aperte le catacombe, entro le quali per tutto il I, il lI e il III secolo si poneano alla venerazione le urne dei martiri, sopra le quali i primi fedeli celebravano il santo sacrifizio della Messa, e a piè delle quali prostrati pregavano; nè potendone portar seco alle case loro le sacre ossa, intingevano nel sangue de’ martiri i lini e li serbavano come reliquie e oravano innanzi a quelle. Anzi nei marmorei coverchi dei monimenti de’ martiri aprivano un foro per calarvi dentro i veli, che toccassero quelle ossa, e da quel contatto credeano che traessero virtù di risanare gl’infermi , e di cacciare i demonii. Che poi tenessero in gran divozione le sante immagini bassi apertissimamente nelle dipinture delle catacombe, le quali ci rappresentano la Vergine Maria, il volto di Cristo ritratto nel buon Pastore, i sembianti di s. Pietro e di s. Paolo, con quelli de’ più antichi martiri della Chiesa: ed oltre a questo argomento luculentissimo, noi abbiamo i vetri sacri de’ calici, nel fondo addoppiato de’ quali frammetteasi una foglietta d’oro graffita ad immagine di Maria e de’ Santi. L’uso di cotesti vetri cessò ne’ primi secoli dalla natività del Signore; dunque sino dai tempi ammessi per legittimi dai protestanti, i cristiani onoravano i martiri nelle loro immagini sante — Come donAlessandro ebbe detto queste cose, uscirono del sotterraneo e della Chiesa di santa Cecilia.
Il signor Edmondo era tutto in sè ristretto e pensoso; indi voltosi al Mansionario con sembiante quasi di trionfo — Cotesti, disse, sono argomenti. di conversazione, ma non hanno fondamento, perchè le catacombe furono per tanti, secoli cosi rovistate, che non vi si ha che una vaga tradizione di cotali urne di martiri, le quali ora non si trovano più.
— Sì, rispose don Alessandro, non poche di quelle furon tolte per trasportarle nelle basiliche erette nel quinto, sesto e settimo secolo ad onore di que’ martiri; ma oltrechè sopra il luogo d’alcune vedonsi ancora murate le lapidi incise dei versi di s. Damaso Papa e di Prudenzio, egli v’ha delle catacombe ove le urne de’ martiri sono ancora a’ luoghi loro nelle edicole a lor consacrate. Io vi condurrò un giorno nelle catacombe di sant’Agnese , di Pretestato, di Callisto e in quelle di sant’Alessandro, scoperte pochi anni sono, e vedrete quelle arche venerande cogli occhi vostri, e vi mostrerò le dipinture che ne adornan le vòlte; e le ampolle, entro le quali conservavano il sangue; e i fori della mensa degli altari, da cui calavano pannilini per toccarne l’ossa; e le mensolette, sopra le quali nel tempo del sacrifizio della Messa posavansi le ampolle del vino; e dipinti i simboli del pesce, che adombrava Cristo, con attornovi i cestelli del pane e le anfore del vino, che sono la materia del sacrifizio. Vedrete il simbolo del battesimo nel Mosè che colla verga batte la rupe e ne sgorga l’acqua viva ; vedrete I’ apostolo divino figuratovi nei pescatori , che a lenza e a sciabica colgono il pesce dal mare del gentilesimo; e il matrimonio espresso nell’uomo e nella donna che si porgon la mano sopra l’altare: e persino la confessione nel Lazzaro risuscitato dalla virtù del Redentore, ove un Apostolo gli scioglie i legami, affinchè si rizzi colla grazia vivificante e cammini gagliardo nella via dei divini precetti.
— E si veggono tutte queste cose, riprese Edmondo con meraviglia, e il tempo ce le ha conservate?
— Sì certo, rispose don Alessandro, e Dio ne mostrò di molte anche negli scavamenti del secolo XVI, quando i Protestanti cominciavano a calunniare la Chiesa d’aver introdotto quei riti e que’ Sacramenti, ne’ secoli dell’ignoranza; e a’ dì nostri si scoprono più che mai per confondere il protestantesimo che imputridisce ne’ suoi errori, e perfidia costante nelle sue menzogne, aggiugnendo col suo razionalismo, che la incarnazione del Figliuolo di Dio non è che un mito. Vedrete colà se sono fatti reali; se quelle urne e quelle dipinture sono testimoni parlanti della venuta di Cristo in terra, della potenza della sua Grazia, del valore de’ Sacramenti, dell’uso delle cerimonie, che tali e quali per diciotto secoli sonosi conservate dalla Chiesa. Ah! credono i razionalisti, che per un mito o favola tanti milioni di martiri avrebbero esposto i corpi loro a tanti tormenti, quanti l’umana crudeltà attizzata dall’inferno ha potuto inventare a strazio di quegli Eroi confortati dalla Fede nella venuta di Cristo in terra, e nelle sue promesse di vita eterna? Il popolo romano, che ha ogni giorno sotto gli occhi i fondatori e propugnatori della sua Fede , crede a quei testimoni e si ravvalora nella sua credenza.
— Arbitrate voi però, amico, disse Edmondo, che tutti i cittadini romani, intendano quei simboli, e conoscano la storia di quegli atroci martirii, e la costanza ineffabile di questo e quel martire che nel dì della sua festa vanno a venerare?
— Fermamente, soggiunse don Alessandro. Voi vedrete il 29 giugno il clivo Capitolino, colà ove scende nel foro romano, pieno di popolo, che cala per entrare sotterra nel carcere Mamertino a venerar la memoria dei principi degli Apostoli Pietro e Paolo, i quali vi stettero incatenati sotto Nerone ben nove mesi, nè usciron di là che per suggellare col sangue la Fede che predicarono ai Romani. I padri co’ loro figliuoli a mano, le avole, le madri, le zie colle loro giovinette scendono quelle scale e ammirano que’ petroni che le fiancheggiano; entrano nel sopraccarcere; additano il luogo ove, secondo la tradizione popolare, mettean capo le scale Gemonie, per le quali furon precipitati o tranati tanti martiri; mostrano ai loro figliuoli il foro pel quale collavano nel covo mamertino i prigioni di Stato, e narran loro come ne’ tempi della repubblica vi fecero morir dentro di fame il re Giugurta. E sanno coteste cose non già soltanto i colti cittadini, ma i fabbri, i falegnami, i calzolai, la plebetta minuta.
Quando poi per la chiocciola, aperta all’uso de’ fedeli, discendono nel carcere sottano, indicano ai figliuoletti spauriti quel forno sotterraneo, dicendo loro — Bacia la terra, caro mio, ch’è terra santa, calpestata per nove mesi da s. Pietro e da s. Paolo: vedi cotesti gran sassi d’asprone così umidi, così pieni di muffa: ecco qui dove erano incatenati i santi Apostoli. Poveretti! nel buio, nel fetore, in quest’aere umido e crasso, con poco cibo: li calarono giù là da quel buco. Quest’è la fontana che s. Pietro fé zampillare con un segno di croce per battezzare i suoi carcerieri Processo e Martiniano, che furon poi martiri anch’essi. Bevi, figliuol mio, di quest’acqua viva, e prega s. Pietro che ti conservi in cuore perenne la fede, com’è perenne la polla di quest’acqua miracolosa — Intanto presso alla fonte è un Confrate, il quale con uno sgomberello at tinge l’acqua, la mesce ne’ bicchieri, e ciascuno divotamente ne bee.
Vedrete il medesimo nel sotterraneo di santa Maria in Via Lata ove si crede che il Dottore delle genti stette in custodia due anni presso il Centurione; e costì eziandio rampola tuttavia l’acqua, colla quale tanti convertiti dall’Apostolo si battezzavano. Andate pure il giorno 2 d’ agosto alla basilica di s. Pietro in vinculis, e vedrete le brigate de’ Romani accorrere a far pressa per sottoporre il capo alle catene, che in Gerusalemme e in Roma tenner legato il principe degli Apostoli e si congiunsero insieme prodigiosamente. E dopo aver disfogato la loro pietà verso san Pietro, tratti al buon gusto delle arti, in che sono pasciuti dalla puerizia, eccoli volgere tutti ad ammirare il Mosè di Michelangelo, e additarne ai figliuoli la maestà del volto, la morbidezza della lunghissima barba, la vigoria delle forme, il risalto de’ muscoli , il largo andare del panneggiamento, il nobile e grave posar di quel braccio sulle tavole della legge, l’eccelsa mossa di quel capo raggiante, la grandezza ch’esce da quella figura, la sublimità che spira quello sguardo, e l’aria divina che tutto l’adombra. Nè v’è alcuno che non faccia toccar colle dita al suo garzoncello quel risentito ginocchio, e gli dica: Vedi costì quella fenditura? e’ fu un colpo che gli diè su Michelangelo colla mazzuola quando, rapito alla sovrana bellezza di quel colosso, quasi estatico, il percosse, gridando: Rizzati e cammina.
Lo stesso giorno della Crocifissione di s. Pietro il popolo romano sale il Gianicolo, e visita il tempietto, opera eccelsa del Bramante, e. gittasi in ginocchio dinanzi al foro in che venne fitto il capo della croce, sulla quale rovescio volle esser crocifisso l’Apostolo. Altri intanto, escono dalla porta Ostiense per visitare la basilica di s. Paolo, venerarne la Confessione, e stupire alla gran selva di quelle colonne, alla copia e ricchezza di que’ marmi , all’augusta corona dei ritratti a musaico di tutti i Papi, all’abbondanza dell’oro che rifulge in quel vasto soffitto, al portento di quegli altari di malachite, alle sontuose cappelle, all’antico abside che signoreggia tutto il tempio. I più agiati si spingono in carrozza sino al luogo del martirio di s. Paolo, ove dalla bipenne del littore decapitato, il mozzo capo guizzò tre salti, ed ove toccò la terra scaturirono tre fontane che sgorgalo a larghe polle sino in presente, e son chiuse in un marmoreo tempio edificato dai Pontefici ad eternare la ricordanza.
Or vedete, signor Edmondo , se può spegnersi la fede nel petto dei Romani, quand’essi ogni anno si conducono a ridestare la rimembranza dei loro maestri, sui luoghi stessi che furono testimoni dei lor patimenti nelle carceri, nelle catene, nelle croci, e ne venerano i loro sepolcri , alla vista dei quali si sentono sublimar l’animo, e provocare a virtù. Da quelle urne odono quasi uscire la viva voce di que’ gloriosi, che par dica loro: Romani, serbate intemerata quella Fede che noi piantammo nei vostri cuori, inaffiammo col nostro sangue, ed ora, beati in Dio, vi preghiamo con ineffabile sentimento d’amore.
Il Giovedì santo i Romani vanno a vedere in Vaticano cogli occhi proprii i flagelli piombati, le tanaglie, i pettini, gli scorpioni, le ruote falcate, coi quali stromenti batteansi, attanagliavansi, squarciavansi, dilaniavansi le carni de’ santi martiri: le caldaie in cui bollivansi; gli imbuti, pei quali infondeano il piombo liquefatto in que’ forti petti; le mannaie, le spade, i coltellacci , coi quali eran dicollati e trinciati a membro a membro. Il giorno 10 d’agosto vanno a venerare in s. Lorenzo in Lucina la graticola, sulla quale fu rosolato il santissimo Levita; il 16 di gennajo entrano nel catabalo, ove il Pontefice s. Marcello fu condannato a governare e nutrire i leoni, i leopardi, le tigri, le pantere, gli orsi e le iene, che serbavansi a sbranare i martiri nel circo di Nerone, nel circo di Flaminio, nell’anfiteatro del Colosseo.
Nei giorni delle loro feste scendono ad orare dinanzi ai sepolcri de’ santi Cosimo e Damiano, di santa Sabina, di santa Prisca, di santa Balbina, di s. Crisogono, dei Santi quattro Coronati, di santa Martina, di s. Clemente, di s. Marco Papa, di s. Pietro e Marcellino, di santa Prassede, di s. Martino e di santa Bibiana. Pregano sul luogo, ove furon decapitati per ordine di Giuliano Apostata i santi fratelli Giovanni e Paolo: scendono nel carcere di s. Nicola, ove gittavansi dall’alto a marcire tanti confessori di Cristo.. Quel carcere è uno dei più antichi monumenti dì Roma edificato sotto i decemviri. Egli è orribile soprammodo, e si veggono ancora nelle vòlte le bocche, dalle quali calavano in quel baratro. É forse il più vasto sotterraneo di Roma e piglia quant’è lunga la basilica di s. Nicola in carcere. Ha due grandi androni, ognun de’ quali a doppia fila ha un covo quant’è la lunghezza d’un uomo, e sono a compartimenti come le poste de’ cavalli. Le mura e i serragli sono formati d’enormi petroni, in alcuni de’ quali si veggono ancora i segni delle grosse anella di ferro, ov’erano appese le gorgiere e le bove che inceppavano i miseri condannati. Nel giorno della festa, par dare adito al popolo, sono appesi lungo i cunicoli de’ lampioncini, i quali fanno risaltare tutta l’orridezza di quell’abisso. Là entro scendono i Romani taciturni, e dinanzi a quelli sfondi si guatan muti, sospirosi e piangenti. Di rado vi conducono i fanciulli e le giovinette, che n’avrebbero soverchio terrore. Nell’uscire di quelle caverne si domandano l’un l’altro: Oh Dio, com’è egli possibile che in quel buio, in quell’umidore, in quell’afa, in quel puzzo potessero vivere a lungo quei servi di Cristo, se pur vivere dir si possa in quel continuo languire?
Dall’alto di quelle bocche gittavan loro un tozzo di pan duro e muffo, e doveano, incatenati com’erano, sedere sul proprio lezzo , e sentirsi per l’umidità cadere di dosso i brandelli de’ vestimenti; spesso avvenendo, che morto qualcuno, ne lasciavano imputridire il cadavere, nè traendo di là, se non per sostituirvi un altro martire, che dovea giacere su quel marciume per attendervi fra poco anch’egli la morte.
Signor Edmondo, con sotto gli occhi cotesti esempi della fortezza cristiana de’ padri loro per mantenere inviolata la Fede che aveano giurato a Cristo ; è egli a dubitare che i Romani non se la sentano ravvivare in petto ad ogni momento? lo non voglio negarvi che non v’abbia de’ Romani increduli, i quali anco fanno professione di miscredenza; ma cotesti sono aborti schifosi, mostri orrendi, de’ quali non è mai priva una gran comunanza; segnatamente dal 48 in qua, che con ogni arte serpentina, con ogni astuzia diabolica s’argomentarono i nemici di Cristo e del suo Vicario in terra di svellere e sbarbicare ogni germe di virtù dal cuore del popolo , e di spegnerne ogni scintilla di Fede. Scorreano i settarii come cani bracchi pel rione de’Monti, per la Regola e pel Trastevere spargendo moneta, seminando calunnie, gittando cavilli, dubbii, sospetti, bestemmie contro il Sacramento della confessione, della santissima Eucaristia, dell’Ordine sacro; contro i premii e le pene della futura vita; contro le leggi di santa Chiesa, mettendo in mala voce il governo sacerdotale, lo zelo de’ parrochi, l’autorità de’ prelati. Nondimeno, credetelo a me, non attirarono a quell’amo che pochi dissoluti, che donne scostumate, che beoni giocatori e altra gente da bisca, che non aveano gran bisogno di sprone per darla in ogni scarriera. Ricomposte poscia le cose, coloro ch’erano per inganno caduti in que’ lacci, se ne strigarono bellamente e ritornarono alle consuetudini antiche, e maledicono a’ loro seduttori, e si pentono, e molti si confessano di quegli eccessi.
— E che la cosa sia al tutto così, interruppe Carluccio, e che la Fede sia sempre viva nel popolo, ad onta delle perfidiose insidie – degli empii, io il ritraggo principalmente dal vivo desiderio che hanno ancora, massime i popolani, di far battezzare i loro bambini in s. Pietro. Quand’io attraverso il Borgo per condurmi alla Pinacoteca vaticana a copiare qualche tavola di Raffaello, mi diletto assaissimo a veder portare i bambini al battistero del Vaticano. Egli è chiaro che i padri, ancorachè potessero far battezzare i loro figliuoletti alla propria parrocchia , tutta via preferiscono di farli cristiani presso al sepolcro del Principe degli Apostoli, cui ha detto il Signore: Ego autem rogavi ut non deficiat fides tua. Questo sentimento d’amore e di riverenza de’ Romani a s. Pietro mi par sublime sopra ogni dire, e aperto argomento ch’essi vogliono innestare nell’animo pargoletto de’ nati loro quella fede viva e folgorante, che faceva gridare a Pietro: Tu es Christus filius Dei vivi. Vi dico il vero ch’ io mi reco sovente al Battistero; e alle sante e auguste parole del sacerdote, e alle proteste del padrino e della madrina, fatte in quel tempio ove riposano le ossa gloriose del gran Maestro della fede romana, mi sento sollevar l’animo sopra sè stesso ; e quando veggo il padre del battezzato portare il suo fantolino alla Confessione di s. Pietro, e deporlo a piò del suo sepolcro, e offrirlo a Dio e alla Chiesa per mano del Principe degli Apostoli , io dico a me medesimo: Questa è Fede che non iscrolla; perocchè Iddio dee accettare quella offerta per le mani di s. Pietro in odore di soavità. E invero dee uscire da quella tomba tanta luce a inondare quell’anima, che non fia mai che la tenebra delle passioni la cancelli nell’adolescenza, nella virilità e nella vecchiaia.
— Oh che bella Fede! esclamò Edmondo; chè s’odono cotesti trasteverini per ogni nonnulla gridare con beffa ribalda; Ah corpo di s. Pietro! Ah per s. Petracciol Che amore neh? che dolcitudine d’affetto? che divozione?
— Appunto, ripigliò don Alessandro; bestemmiano s. Pietro nell’ ira e nello sdegno bestiale, perchè non hanno nulla di più sacro che il nome suo; non si bestemmia giammai dagli uomini pravi se non ciò che adorano; né udirete mai un luterano e un calvinista bestemmiare s. Pietro, o l’Ostia sacrosanta.
Cosi ragionando i nostri amici pervennero allo studio di Carluccio; ma essi non toccarono punto della ceremonia del comparatico, ch’è per fermo un singolare costume di Roma; e mentre essi favellano insieme, io narrerovvela in breve. Già da qualche mese il marito della puerpera aveva apparecchiato il Compare e la Comare, i quali sogliono esser trascelti fra i più agiati della contrada, puta il macellaro, il pizzicagnolo o il salumaio; la maestra delle tessitrici, la pentolaia, o la bettoliera. Nata la creatura, s’ell’è femmina, la festa è liscia liscia; ma s’egli è un maschiotto, si festeggia il nascimento d’un cittadino romano come ai tempi degli Scipioni e de’ Marcelli ; e non mancano mai li pronostici di certe donne del vicinato, che hanno voce di veggenti, e spacciano le divinazioni. Appena si sa che il bambino è uscito alla luce, eccotele in camera della madre, e dicono entrando : Prosit, sora Betta; gli è un maschietto eh? L’avea pur detto io! e anco l’altra sera all’osteria del Granchio ci pizzicammo coli’ Assunta e colla Nastasia, che le volean pur dire che la sarebbe una femminuccia. Femminuccia un fico, diceva io; vi par egli che la Bettina abbia viso da far femmine? Fiato disteso e agevole, occhio sereno, la pozzetta del mento rosso come una fragola, passo franco, le ugne colla lunetta bianca come una mezza perla: figuratevi! femminuccia? e’ bisogna pure aver le traveggole. Dunque prosit, sora Betta: ce lo fareste vedere?
La mammana accostasi alla culla, toglie il velo che ricopre il bambino, ed esse scortolo a grand’occhi, gridano a una voce: Gli è tutto il nonno; gli è mastro Carlona spicciolato: vedi quella fronte, vedi quel labbruzzino di sotto, tutto lui mastro Carlone, requesca; se fosse ancor vivo, che fiaschi farebbe vuotare! che buona trippa di vitello ci darebbe da colezionel ‘N’avea ve’ degli scudi quel vecchio, e gli avea buscati dai Francesi, quando in tempo della repubblica del 98 vennero a rubare Pio VI, e li trasteverini davano loro addosso e li buttavano a fiume; perocchè Carlone essendo egli bonaccio, se li strascinava in casa, strappandoli di mano ai funari di s. Cosimato che voleano scannarli ; ed ei diceva loro : Qua, dateli a me questi accidenti di framassoni; li getterò io dalle mie finestre che riescon sul Tevere; e intanto, venuta la notte, li rimandava vestiti da carrettieri al palazzo Corsini: laonde aveva da quegli ufficiali di gran manciate di doppie.
Indi voltesi alla puerpera, diceano: Che nome gli porrete voi? — Si sa, rispondeva, il nome del nonno — Che tu sia benedetto, dicea l’una segnando il bambino della croce in fronte — Non fare, soggiungea l’altra, ch’ egli non è ancora cristiano. Ma guarda, Felicita, che grugnetto ardito ha costui! oh non si lascerà pestare sul collo, tel dico io, e vorrà esser come suo padre: buono ve’, mastro Peppe; ma guai chi lo tocca com’egli abbia beuto un tantino — E qui procuravano il bambolo a membro a membro, e diceano: Poffare! vedi bracciotte rotonde, vedi spalla sollevata, petto largo, polpe di gamba fusate, costui verracci un torello.
Mentre costoro cicalano intorno alla culla, mastro Peppe ha partecipato al Compare Checco, e a Comar Angiola come qualmente domani si farà il battesimo a s. Pietro in sul vespero. Essi preparano le mance alla levatrice, al sacristano, al campanaro, ai cocchieri, e l’elemosina al cherico e al Curato: mastro Peppe compera li confetti, le pinocchiate, i canditi e le ciambelle; ordina all’osteria del Falcone un buon rifreddo colla gelatina alla vaniglia; al friggitore della Longaretta i calamaietti e le seppie fritte; provvede in piazza della Rotonda un gallinaccio, i funghi dall’uovo pel tocchetto, e dal macellaio un bel pezzo di lonzadi bue pel bollito. Commette al Bianconi una buona carrozza chiusa a cristalli, e un’altra aperta foderata di cuoio paglierino a sgonfietti.
Il domani la mammana acconcia il bambino coi pannicelli galati, e col zendato chermisino filettato d’oro da far isvolazzare fuori dello sportello. Comar Angiola il corsetto di raso verde coi manichini a smerlo , col grembiule di nobiltà corso tutto di trinetta d’oro, con dodici anella nelle dita, colla collana a traforo e a smalto, cogli spilloni e colla rosa tremolante a filograna in capo. La ti par proprio una Ilitia incoronata. Ella siede sulla sinistra della levatrice, e dall’alto sono sedute in gran fasto le cognate o le sorelle di mastro Peppe.
Nella seconda carrozza è in sulla dritta il Compare, a mano manca il fratello o il cognato, poscia dall’altra banda siede egli, e il primo garzone della sua bottega. Hanno i vestiti da festa, colle lattughe arricciate alla camicia, e i manichini a crespe: il cappello poi è felpato a pelo lungo di lepre, e il venticello che lo accarezza il fa orezzare come una marina. Sono tutti quattro sdraiati sui sederini colle gambe distese e con ambo le mani nei taschini dei calzoni, procedendo verso s. Pietro con un poffare che ti dice: Eccoti quattro padroni del mondo.
Posciachè fu battezzato il bambino e offerto alla tomba di s. Pietro, risalgono in carrozza, fanno un lungo giro per le vie più popolate di Roma, e ridottisi a casa, confettano; e com’è venuta poi l’ora del desinare s’assettano a tavola, dove trionfano que’ loro messi e trincano que’ loro fiaschi con un sapore e una letizia che ne disgradano le cene d’Apicio e di Lucullo. Sopravviene di spesso il ribecchino e il poeta, e lì fra i brindisi e i trimpelli s’alzano di tavola a gran notte, colle gambe che annaspano e col cervello che grilla.
Chi consideri in queste cose soltanto dal lato umano ride un poco di questa mescolanza di pietà e di fede coll’orgoglio e la vanità e la ghiottoneria che signoreggia sovente il popolo romano; ma l’uomo savio e discreto sa discernere e sceverare l’oro dalla scoria, e dice: Costì è fede viva; e costì è sfogo di natura che s’intromette nelle cose più nobili e sublimi ad appannarne la luce. Intanto per l’uomo cristiano sarà sempre commendevolissima cotesta brama che ha il padre romano di far battezzare il suo figliuolo nel tempio, ove siede la Cattedra di Pietro maestra di verità, e dond’escono gli oracoli della Fede emanati per tutta la Chiesa di Dio dai suoi Successori.
Altri de’ Romani amano eziandio di far battezzare i loro figliuoletti in s. Giovanni in Laterano ch’ è la prima chiesa del mondo: Caput et Magistra omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis. Ivi a lato del battistero di Costantino Imperatore sono rigenerati a Cristo i figli de’ Romani, e attingono ai piedi del Salvatore quella Fede inconcussa ch’ è la gloria di Roma. Quando il bambino fu battezzato, il padre lo depone innanzi alle teste dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, lo accosta alla sacrosanta tavola, sopra la quale nell’ultima cena Gesù Cristo istituì l’Augustissimo Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue prezioso, la quale si conserva nel sacrario del Laterano; indi lo porta alla Scala santa salita e discesa le tante volte dal Redentore nell’andare al Presidente romano ad essere interrogato, flagellato, coronato di spine, e condannato alla morte di croce. A queste sante memorie son poscia ricondotti que’ pargoli dal padre e dalla madre insino dalla puerizia; e ad ogni ricorso delle feste de’ martiri raro è mai che manchino di rinnovellar loro la rimembranza di que’ grandi campioni della fede, facendoli prostrare dinanzi a quelle tombe sotterranee che spirano tanta’ riverenza. Di guisa che i giovanetti romani rinfrescano le memorie della Fede, cominciando al gennaio nelle ricche e sovrane catacombe di santa Martina a piè del Campidoglio, e seguitando tutto l’anno sino al 25 decembre in quelle di santa Anastasia a piè del palazzo de’ Cesari in capo al Circo massimo. I protestanti e i miscredenti possono ben gracchiare, calunniare, imprecare e maledire a Roma; ma Roma sarà sempre il centro della Fede, e il popolo romano l’avrà sempre viva nel cuore.
LE PRATICHE ROMANE
La torre degli Anguillara è uno de’ pochi monumenti del medio evo, che duri ancora in Roma dopo la distruzione di quelle dei Colonna, degli Orsini, dei Frangipani, de’ Savelli, dei Cenci, de’ Crescenzi, e di tanti altri antichi signori, che ci ricordavano le congiure, le sedizioni e le buglie del popolo romano quando parteggiava pe’ Papi, per gli antipapi, pei Banderesi, e per le sette dei più potenti suoi cittadini. La torre degli Anguillara s’erge severa e bruna in Trastevere di fianco alla piazza di s. Grisogono, e vi si sale passando per molti androni smattonati e per molte scalettacce slabbrate e scommesse, le quali ti conducono sino all’antica bertesca, la quale co’ suoi mutoli e co’ suoi piombatoi la correva. tutto d’intorno sotto a’ merli. Il signor Forti cittadino romano, che fra le muraglie dell’antico ricinto del castello ha una sua vetriera, formò in sul battuto della detta torre un Presepio di Gesù bambino a somiglianza della grotta di Betlemme, e invita ogn’anno a vederlo i Romani, i quali salgonvi a gran folla sì per la divozione che spira, come per la maestria mirabile ond’è condotto.
Imperocchè oltre la grotta, ove nacque il Redentore del mondo, costrusse di sugheri, di cepperelli, di muschi e di graticci, coperti con fogliami di lauri, di mortelle e di tamarischi, le più belle prospettive che mai dipintore di paese potesse immaginare. Là s’alzano monti dirupati e scogliosi, e fra I’ammonticchiamento de’ macigni divelti s’internano spelonche e antri, dagli sbocchi e dalle rotture dei quali si veggono lontananze, e fughe di montagne cilestrine che si perdono nella sfumatura de’ cieli. Qui s’aprono vallette ombrose piene di pascoli e di boschetti; colà si stendono praterie seminate di cascine e di mandrie d’armenti, di tormerelle di pecore e d’agnellini: costassù v’ha rupicelle e selvette di cornioli, di lecci, e di lentischi, infra le quali s’ inerpicano le cavriole, e scorrono rivoletti che dai greppi ricascano in mille sprazzi, e brillano in mille luci, e giunti al piano formano pelaghetti, e peschiere e scherzi di pispini e di schizzi altissimi e trasparenti.
Siccome poi la scena è diurna, cosi il Forti colse tutte le guardature del sole, di guisa che vi si vede verso Tivoli e Palestrina sorger l’aurora e farsi vermiglia e rancia, laonde spuntato il sole manda furtivo i suoi raggi a illuminare i monti e le valli del Presepio con certi giochi di luce tramirabili. Quando il sole è alto scendono torrenti di luce, ma da certi ingegni rifratti, che balenano negli sfondi delle caverne, e ne fanno vedere tutt’ i risalti e gli anfratti. Dal lato poi di ponente il Forti condusse sull’alto di quella torre, attraverso le varie giogaie di monti che diresse a quella plaga, certe sboccature che fanno vedere la caduta del sole, rotta alcuna volta da nuvolette d’oro, e da lunghe falde vermiglie, che le danno quella grazia ineffabile tanto ammirata dai forestieri oltramontani nel cielo di Roma.
In una di coteste belle sere invernali appunto, quando il cielo è più limpido, quando il mare è più rispianato e il sole vi sta pendulo sopra e tutto lo chiarifica e indora, salieno le scalette di quella torre don Alessandro, Edmondo e Carluccio. Pervenuti in sulla cima alenando, al primo aspetto del Presepio, Edmondo, che non s’attendeva a quella graziosissima vista, rimase come attonito e stupefatto. Giace il bambinello Gesù a mezzo la grotta in una greppia sopra un covoncello di paglia, riscaldato dall’alito del giumento e del bue: vi seggiono allato Giuseppe e Maria che te riguardano mestamente in sì povero stato e doloroso: e intanto a mezz’aria veggonsi grupperelli d’angioli celestiali che cantano il Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Già i più solleciti de’ pasturi son giunti ed offrono al divin pargoletto agnelli e cacio e latte con altri doni pastorali: quelli che si mossero più tardi scorgonsi scendere dai circostanti dossi dei monti e affrettare il passo per adorare il nato Redentore.
A quella vista Edmondo sentì tutta l’anima sollevarsi sopra sè medesima, e stava a capo chino e riverente senza far motto. Allora don Alessandro cominciò a mostrargli a mano a mano la varietà de’ prospetti , e l’artifizio onde furono aperti gli sfoghi che dall’alto di quella torre mettean l’occhio in lontanissimi spazii di cielo, di terra e di mare: perocchè da un lato la vista trascorreva dal Soratte ai monti Sabini e mettea in bel riguardo Tivoli e il monte Catillo; dall’altro iscorgeansi i monti laziali coi giardini di Frascati, colle vette del Tuscolo, coi vigneti di Marino, colle cime del Giove Laziale che mette le sue radici nel lago albano: là in fondo stendeansi le marine di porto d’Anzio, di Nettuno e d’Ostia, e più qua scerneansi i vasti piani del Lazio da Ardea insino ai monti Cimini.
Don Alessandro leggeva nel sembiante di Edmondo la meraviglia mista con un senso di Riverenza che suscitavagli in cuore la religiosa scena che lo circondava: perchè stato alquanto, si mosse per ritornare. Ma come furono a basso e volsero passeggiando per s. Gallicano — E che vi pare? disse a Edmondo; vedete come a Roma si ridesta ogn’anno la memoria della natività del Verbo, fatto uomo per nostro amore? Anche codesto è un dolce mezzo di ridestar la fede di nostra Redenzione nell’animo de’ Romani. Imperocché non crediate che il grazioso presepe di torre Anguillara sia unico in Roma. Avvene assaissimi altri pubblici e pri vati, in fra i quali bello e magnifico si è quello di san Francesco a Ripa e quello d’Araceli, ove si espone il miracoloso Bambino, cui tanta divozione professa il popolo romano, che non muore contento se non lo si vede recare al capezzale dai sacerdoti ed esser benedetto da quello.
Domani vi condurrò sul Campidoglio ed entreremo a vederlo in Araceli: son certo che la vaghezza dell’ arte vi desterà diletto, e la divina maestà che move da quel santo Bambino vi spirerà tenerezza ed ossequio. Oltre a ciò vedrete nuovi modi con che in Roma si suol ravvivare la fede in cotesto soavissimo mistero; perocchè da poi che ci saremo intrattenuti dinanzi a quell’antro luminoso, in cui giace il divino Infante, ci volgeremo, e vi piacerà di certo il vedere le madri che conducono le loro figliuoline di sette in ott’anni, vestite di bianco e coronate di fiori, e fattele salire sopra un pergametto, fanno recitar loro un discorsino in laude e gloria del vago bambinello. Altre vi cantano, con voce argentina e con dolci e acuti modulari, una strofetta; altre in due o tre rappresentano una scena pastorale, ed altre a coro intonano cantici ed inni che fanno tutto il tempio echeggiare.
Se poi usaste colle case cittadine, vedreste che in Roma non v’ha famiglia, ove sieno fanciulli, la quale non abbia il suo Presepio. I garzoncelli cominciano sino dai primi di decembre a stimolare i padri e le madri acciocchè proveggan loro sulla piazza di sant’Eustachio i sugheri, i ceppi, i vilucchi e le mortine per affondare la grotta, per incastellar le montagne, per accavallare gli scogli, per rizzare le lontananze: e vogliono le casucce, le capanne, le pecorelle, i pastori da fornire le valli, i monti, i boschetti e le pianure. Voi non potete immaginare come i Romani son destri, fecondi, e pieni di poesia nel comporre coteste rappresentazioni, che in pochi palmi vi spingono la vista a molte miglia, e sanno darvi giochi di luce e sbattimenti, scorci e fughe, sollevazioni e abbassamenti meravigliosi. Ogni sera il presepio s’illumina, e tutta la famigliuola raccolta a piè di Gesù Bambino vi fa la Novena del Natale, vi recita il Rosario, e vi canta le litanie. Il vicinato v’accorre, i parenti, gli amici, i conoscenti si visitano a vicenda: e v’è quasi sempre un garzoncello o una fantolina che vi declama graziosamente il suo discorso, o vi recita le sue strofe, o a più insieme consertano un’egloga pastoreccia.
Dite un po’, caro Edmondo, fra voi altri protestanti è egli rimasto più nulla di coteste costumanze cristiane, che tanto conferiscono a tener deste le credenze della santa nostra religione? Nulla per fermo; e i vostri giovinetti, che son tutti fantasia e cuore come i nostri, mancano di cotesto poderoso sussidio.
— E che giova tutto questo, ripigliò don Alessandro? L’uomo non è una pura intelligenza, come gli angeli, da pascere soltanto la mente di principii astratti; ma l’uomo oltre l’intelletto ha il cuore, ha l’immaginativa, e però abbisogna d’immagini e d’affetti, e più gli muovete il cuore e gli eccitate la fantasia, e più riceve per que’ mezzi l’impression delle cose anco puramente spirituali, i primissimi cristiani, sotto la scorta degli Apostoli, conobbero questa gran verità, e però sino dal primo secolo ornavano le cappelle sotterranee di pitture allegoriche, le quali non essendo intese dai pagani, al cristiano rappresentavano ora Cristo, ora gli Apostoli, ora i Sacramenti ed ora altre verità di vita eterna. E sino altresì dal primo secolo v’ebbero ceremonie, riti, vestimenta, addobbi, e incensi e lumi e canti ed altre sacre e reverende celebrazioni.
— Ma cotesti presepi ed altre rappresentazioni che s’usano in fra voi cattolici possono condurre a culti superstiziosi e a pratiche vane, scambiando l’ombra colla realtà.
— Eh caro, toglietevi coteste suspizioni; imperocchè i nostri fanciulletti hanno tanta chiarezza di fede ch’egli non v’è pericolo che piglino sì fatti sgarroni; e il bambinello di cera, ch’essi pongono di lor mano in sulle pagliuzze, sanno benissimo ch’ è la figura del Dio vero che sta ne’ cieli : ma cotesta figura rimembra loro il prezioso mistero, e colla rimembranza si desta viva e calda ne’ loro cuorellini la fede. Vedeste sere sono in sulla piazza di sant’Eustachio che pressa di gente incontro ai venditori di quelle figurine, e i salti che spiccavano quelle puttine e que’ putti per l’allegrezza di comperarle? E come tirando i genitori per la mano, gridavano — Papà, vorrei quel gruppo di pastorelli: Papà, oh vedete i re magi, vedete i dromedarii, i camelli, i moretti, deh sì comperatemeli; nel mio presepio gli acconcierò parte in viaggio e parte arrivati alla grotta. Le sorelline che piacere n’avranno; la Lisa colla Nerina vi reciteranno dinanzi l’egloga composta da don Agostino, ed io inginocchiato intonerò io le litanie della Madonna — E sapete voi, caro Edmondo, come quei fanciulli per ottenere que’ bamboccetti, stettero buoni, ubbidienti e studiosi da quindici giorni in qua!
— Al più, disse Edmondo, coteste letizie sono per le famiglie agiate, ma la plebe romana non le gusta.
— Non le gusta? V’ingannate a partito. La plebe romana è avidissima di vedere i presepi che sono nelle chiese; e la ricorrenza delle feste Natalizie e di Pasqua è una festa universale. Vi ricorda la vigilia del Natale quando vi condussi in pescheria, in piazza Navona, in quella del Panteon e della Pace? Vedeste voi mai in vita vostra un popolo più trionfante? Voi stesso mi confessaste che nè Londra né Vienna, nè Berlino ha una plebe più agiata della romana. Non v’è famigliuola si minuale e sì poveretta che in quella notte non faccia il suo cenone (come lo dicono i Romani). E v’ha a essere il suo pesce fritto e il suo pesce arrosto. Se non ponno comperare il capitone, e’ vogliono almeno due rocchi d’anguilla; e se anch’essa in quel dì è troppo cara, si volgono alle murene, alle lasche, alle lamprede. E ciò che per la vigilia va in pesce, pel dì del Natale va in capponi e in gallinacci, e per Pasqua va in manzo e va in cavretto: tanto il popolo cattolico festeggia i misteri principali della sua Redenzione giubilando alle mense.
— E gozzovigliando, interruppe Edmondo con un sorriso, e tracannando e briacandosi e talvolta accoltellandosi.
— Si sa, l’uomo abusa le più sante cose: ma che perciò! Sarà egli men vero che se il popolo romano avesse manco di fede non si abbandonerebbe a tanta letizia?
Allora Carluccio soggiunse: Credetelo, amico, che don Alessandro ha tolto a provarvi un assunto che basta conoscere da qualche anno quest’ammirabile Roma per esserne chiariti pienissimamente.
— E non gli ho tocco si può dir nulla ancora, ripigliò don Alessandro, delle manifestazioni della fede romana. Edmondo mio, voi non potete nè conoscere nè apprezzare la divozione e la confidenza figliale che ha il popolo romano verso la Madonna madre delle grazie e fonte d’ogni bene. Io vi vorrei meco in un cantuccio dinanzi a santa Maria Maggiore, alla Madonna del Popolo, alla Madonna di s. Marcello, della Minerva, di santa Maria in Via Lata, del Panteon, dell’Archetto, della Pietà in piazza Colonna, di Loreto nel foro Traiano, del Pilastro in s. Pietro, del Carmine, a s. Martino a’ Monti, del Buon Consiglio a s. Pantaleo, della Strada al Gesù, di Campitelli, di santa Maria Liberatrice in Campo Vaccino, di santa Maria del Pianto e del Suffragio e di cent’altre chiese di Roma; e le vedreste piene di ricchi presenti, e ardervi di continuo all’altare qualche lampana e qualche candela votiva, e prostratavi innanzi qualche madre di famiglia che non ha pane, o ha il figliuolo infermo ch’ è l’unico sostegno de’ vecchi genitori; o qualche sposa che ha il marito in carcere per qualche zuffa, o ha perduto l’impiego, o è per fallire in commercio, o domanda la consolazione d’un figliuolino, o uno sposo dabbene per la figliuola.
Il Romano ha Maria in luogo di Madre, e le confida le sue angustie e le sue gioie, le sue speranze e i suoi timori ; se la tien sempre al collo o in medaglia o nello scapolare o a capo il letto, nè per tristo, facinoroso e dissoluto che sia , si corica senza averla salutata almeno d’un’Ave. Voi la vedete dipinta sopra gli angoli delle vie, sui palazzi de’ grandi e sugli abituri de’ popolani; e avvene alcune chiuse ne’ tabernacoli colla lampana accesavi tutte le notti, alle quali in certe feste dell’anno tutta la contrada offre i suoi omaggi di musiche, di luminarie e di preghiere. Il Romano ha la sua Madonna ne’ fondachi, nelle botteghe, nelle officine e insin nelle taverne.
Sopra tutte però ha in riverenza la Madonna di sant’Agostino, e voi ci entrerete all’alba, a mezzo giorno e alla tarda sera finchè si chiude, e troverete sempre di gran gente prostrata dinanzi a quel celeste simulacro. Ivi il soldato è genuflesso accanto al Prelato, il bottegaio a lato al giudice, l’accattone accosto al dovizioso Patrizio: ivi la vedovella che implora pane pe’ suoi figliuolini; ivi la Principessa che domanda amore dal fieddo marito; ivi la giovinetta che ha perduto l’amante; la pia fanciulla che dedica il suo fior virginale alla Madre di purità; il giovine studiarne che brama riuscire onorevolmente agli esami del dottorato. Egli non v’ha dolore che non s’addolcisca nel mirare quella tenera Madre, nè affanno che non s’allievi, nè desiderio che non si appaghi, nè angustia che non si accheti, nè grazia che non si ottenga. Vel dicono i voti che pendono al suo altare, i quali son tanti e di sì inestimabile ricchezza, che ben si conosce quali e quante grazie Ella dispensi ogni giorno a quelli che a Lei ricorrono.
— Ne’ miei paesi, disse Edmondo, riputerebbesi un togliere a Dio tutto ciò che si dona a Maria.
Poveri ciechi, sclamò vivacemente don Alessandro, se pur non me li convenga dir sciocchi. E non fan eglino coi ministri e coi cortigiani del Re terreno ogni giorno ciò che i cattolici fanno colla Madre di Dio e co’ Santi ? Di quanti onori e di quanti doni non son eglino larghi a cotesti amici del monarca per averli benevoli alle loro domande? Con tale differenza nondimeno, che i cortigiani de’ Re della terra si ciuffan per sè i presenti onde son regalati, e Maria e i Santi riferiscono tutto a Dio, dalla cui potenza e benignità scende come da fonte vivo omne datum optimum et omne donum perfectum; e i cattolici stessi nell’onorare i Santi intendono in quelli di gratificare a Dio; perocchè anco i nostri bimbi sanno che soli Deo honor et gloria.
Ma per provarvi quanta fede alberghi in petto ai Romani io vorrei, caro Edmondo, che voi credeste nell’augustissimo Sacramento, e vedreste altra fontana viva di fede che scaturisce dall’Ostia sacratissima, la quale si espone in Roma ogni giorno nelle quarant’ore , e i Romani vanno attingere disiosamente in essa. Con ciò sia che all’esposizione di Gesù in sacramento vedreste non solo le grandi e sontuose basiliche, ma eziandio le povere chiesicciuole, messe a maravigliosi addobbi di damaschi e di velluti, di tocche d’oro e d’argento, di lumiere cristalline pendenti dalle volte con torchietti accesi, e gli altari folgoranti di lumi e disegni e a compartimenti bellissimi, col trono su cui posa il divinissimo Sacramento attorniato d’angioli dorati, di nubi lucide e trasparenti, di serici padiglioni che scendono maestosi dal colmo dell’abside insino alla mensa dell’altare. E cotesti sono i fregi materiali del tempio: ma la gloria più bella e il trionfo più nobile e cospicuo si è la folla de’ Romani che accorre a quella esposizione, e per tutto il giorno e la notte sta genuflesso adorando il suo Dio e Signore sacramentato. E siccome a tarda ora si chiude la chiesa alla divozione del popolo, eccoti una fraternità speciale di Romani, detta degli Adoratori, deputata a corteggiare Gesù per tutta quanto è lunga la notte, vegliando all’altare e cantando inni e salmi insino all’aurora, allorchè riaprendosi la chiesa, già una mano di fedeli vi sta affollata in sulla soglia attendendo l’onore di corteggiare la divina maestà e mattinarla solleciti ed amorosi.
Anche un’altra testimonianza luculentissima della fede romana ci porge la pietà che nutre il popolo verso i suoi cari defunti. Da un vent’anni in qua tutti i morti di Roma si conducono seppellire fuori di porta Tiburtina, accanto la basilica di s. Lorenzo nel campo V’erano, in cui ogni gleba fu tinta del sangue de’ martiri. Or voi vedreste, Edmondo mio, dalla notte del martedì al mercoledì una schiera divota, la quale recitando il Rosario si reca in sì lontana e solitaria basilica per assistere alle tre messe che vi si cantano dalla mezzanotte all’aurora in suffragio dei morti ivi sepolti. Pensa l’inverno in quelle nottolate da lupi, colle piogge dirotte, colle nebbie che si levano fitte nell’agro romano, colle tramontane rigidissime che di frequente vi imperversano, pensa, dico, qual fervore di fede è forza che animi que’ generosi petti per affrontarle: e nota, che v’ha di quelli che da molti anni la durano con una costanza di mente, e virtù d’animo, e fervore di spirito inestimabile; e tornati di gran mattino, vanno a opera chi di muratore, chi di fabbro, e chi d’altro mestiere. Oh ditemi se fra’ protestanti v’ha nè anco l’ombra di cotesta carità verso i defunti. I protestanti s’affaccendano a recare sui loro tumuli ghirlande di fiori nostrali e pellegrini; ma che valgono agli estinti coteste prove di vano amore? I fiori la sera sono appassiti, ma la preghiera sale sino alla regione de’ cieli, e si posa odorifera e santa in grembo a Dio che la riceve in odore di soavità e la ripone negli eterni tesori delle sue misericordie.
Ma se io vi parlo dell’ottavario de’ morti in Roma, io vi farò stupire alla gran calca di gente che s’affolla in tutte le parrocchie assai prima dell’alba per ascoltare la Messa e pregare in comune a suffragio delle anime de’ lor trapassati, e confortarle d’elemosine e di private orazioni. Avvi eziandio un singolare costume di fare in alcuni cimiteri delle sacre rappresentazioni, alle quali i Romani accorrono avidamente. Le tombe sotterranee della Confraternita della morte in via Giulia sono tutte attapezzate d’ossa cristiane disposte a disegno d’architetture d’archi, di colonne, di cornici, di fregi e di frontespizii che ti figurano l’interno d’un tempio. Pendono dalle volte a illuminarlo di molte, lampade tutte formate d’ossicini delle falangi delle dita, di vertebrette, di costoline di fanciulli: nel mezzo poi sollevasi una piramide costrutta d’ossa d’umani stinchi e di teschi con candelabri fatti colle spine dorsali e con altro ossame. Là in fondo s’apre una scena di figure di cera al naturale, le quali rappresentano o Davidde col capo di Golia o Giuditta col capo di Oloferne; o somiglianti fatti sacri.
Avvi un’altra rappresentazione al cimitero dello spedale di Santo Spirito, un’altra al cimitero di santa Maria in Trastevere, al cimitero di s. Giovanni in Laterano, e in altri antichi cimiteri di Roma. Quelle statue, che hanno capo, mani e piè di cera, in tutto il rimanente sono vestite di drappi di velluto, di seta e di pannolini, e i Romani li foggiano e li acconciano sì maestrevolmente che ti paion vivi e parlanti. Il popolo per tutti quegli otto giorni vi trae a divote caterve, e prega pace a’ suoi defunti con mirabile compunzione.
La Confraternita poi della morte raccoglie tante elemosine che non potendo far celebrare tutte le Messe a’ suoi altari, le spande per le altre chiese della città. Essa Confraternita forma l’edificazione di Roma, perocchè sono ascritti a quel sacro sodalizio la maggior parte de’ principi e de’ patrizii romani, de’ Cardinali, de’ Vescovi, de’ Prelati, con gran numero di cittadini e di popolani, i quali al solo invito si recano in buffa ad accompagnare i funerali de’ confratelli : e v’è questa legge, che quando vengono avvisati, giacere insepolto nell’agro romano qualche infelice accoppato per isventura o per omicidio, essi incontanente si recano anche a molte miglia colla bara in sul luogo, e levatosi il cadavere in ispalla, portanlo seppellire a Roma. Tanto sono solleciti di quest’opera di misericordia, che il primo, il secondo e il terzo che ne rechi l’avviso ha mancia d’uno scudo, sicchè gli affogati nel Tevere o nell’Aniene, gli scornati da’ bufali, i caduti dall’alto e fracassati, i morti a tradimento di coltello, nè giacciono a lungo in sepolti nella solitudine, nè privi dei suffragi della Chiesa.
— Noi vi nego, e il debbo pur dire, soggiunse Edmondo, che i protestanti non hanno e non possono avere tanta carità pei loro defunti, perchè non credono nel purgatorio.
— Sicchè, disse Carluccio ridendo, voi altri andate di volo tutti in paradiso. Pur dite, amico, se voi foste invitato a pranzo dal vostro Re e messovi in gala per andarvi, un amico incontrandovi dicesse — Bada, Edmondo, che passandoti accanto un mugnaio, tinseti di bianco il braccio e la falda del vestito — che fareste voi? Cerco d’un setolino o d’una spazzola, preghereste un vicino che vi scopettasse ben bene per infarinarvi ; nè cessereste di farvi strofinare qui e là sinchè più non appaia la più lieve macchiolina, non riputando cosa decente il presentarvi alla mensa reale col minimo imbratto. E volete che l’uomo, anche perfetto e pio, non rimanga talvolta adombrato l’anima dalla polvere dell’umana conversazione, sicch’egli non abbia duopo d’una spazzolata che tutto il rimondi prima d’entrare nella purezza de’ cieli?
Il popolo romano ha un’altra cagione di tener desta la fede, riprese don Alessandro, ne’ sodalizii che frequenta la domenica e le feste; essendo che egli non v’abbia arte o mestiere in Roma, che non apra una chiesa o un oratorio per chi v’è ascritto. I cocchieri, gli staffieri, i barbieri, i tintori, i legnaiuoli, i fabbri, gli orafi, i muratori, i librai, i fornaciai, i panattieri, i vignaiuoli, gli ortolani, i conciatori di pelle, i sarti, i mugnai, i calzolai, i carradori, i facchini, i macellai, i tavernai e gli ostieri, i barcaiuoli, i rigattieri e le classi di cent’altri mestieri, hanno le loro; e ciascuna ha quale prefetti, quale guardiani, o rettori, o massai, e consiglieri, mazzieri, cantori, cappellani e maestri. Ciascuno si gloria della sua Congregazione, ciascuno l’ha cara, ciascuno l’accarezza e s’argomenta di tenerla ben fornita, ben addobbata ; nè bada a spendere perchè sia appariscente. Anzi le arti de’ minuali più abbietti all’occhio de’ cittadini son quelle che brillano di maggior pompa, che hanno arredi più nobili e ricchi, che celebrano più messe, appunto perchè in costoro la fede è più viva, e privansi volentieri dell’obolo, che si levan di bocca, per darlo a Dio. Aggiugnete che alcune di coteste fraternite hanno per istile o per istatuto di visitare gli spedali e le carceri, di accompagnare i defunti ai funerali o alla sepoltura, di confortarli condannati alla morte, o d’assisterli sino al patibolo. Altre hanno alcune doti per le figliuole dei confratelli, altre pensioni pei vecchi, per le vedove e pei pupilli, altre elemosine per gli infermi, o soccorso di cibo, di medici o di medicine. Voi potete pensare che i giorni di festa, se giraste per Roma, udireste dai congregati cantare i salmi o recitar preghiere dall’aurora insino a calato il sole; onde eccovi migliaia di popolani che ogni domenica porgono a Dio pubblici omaggi. Or ditemi, eziandio che molti di cotesti Romani per l’umana fragilità cadano in molti peccatied eccessi; sarà egli men vero per questo che nel fondo dell’anima conservan la fede viva, per la quale possono quando che sia riconoscersi e ricorrere alle divine misericordie? Il guaio è quando un popolo perde la fede, perocchè privo di quella non può provocare l’animo suo a pentimento, avendo detto il Signore: Impius cum in profundum venerit contemnet.
S’egli è poi pei giovinetti del popolo, essi, oltre il zelo de’ parrochi, hanno il potente aiuto delle scuole diurne de’ Fratelli della dottrina cristiana che gli ammaestran sì bene nel catechismo e gli educano sì costumati e religiosi : hanno le scuole notturne pe’ fattorini dirette con tanta industria dai sacerdoti delle parrocchie; hanno gli oratorii de’ Padri Filippini, hanno la coltura di molti altri pii ecclesiastici ed anco Prelati che li conducon la festa a diporto per toglierli dai pericoli: hanno le missioni urbane, hanno gli esercizii spirituali a Ponterotto, hanno ricoveri per accoglierli al l’apparecchio della prima comunione; e le giovinette hanno anch’esse i loro: di sorte che quasi tutti i fanciulli e le fanciulle della plebe romana sono apparecchiati in cotesti ritiri spirituali a degnamente accostarsi alla sacra mensa: anzi di molti giovinotti e di molte giovani romane ivi si raccolgono alcuni giorni per disporsi cristianamente a contrarre i loro matrimoni. Che vi pare, Edmondo? Avvegnachè non siate stato cattolico, siete però cristiano, e dovete pur convenir meco, che Roma primeggia sopra tutti i popoli cristiani nel radicare la fede nell’animo de’ suoi cittadini.
— In gran parte però vorrete concedermi, ripigliò Edmondo, che tutti cotesti sono mezzi molto materiali e che l’uomo dovrebbe sopravolare a tutte cotali cose sensibili e attenersi soltanto allo spirito.
— E dalli! ripicchiò don Alessandro: voi siete sempre lì col vostro spirito! Or ditemi, quando voi piglierete moglie degna della nobiltà vostra, voi l’amerete di certo assai; ma siccome l’amore è tutto nell’anima, vi basterà egli di amarla soltanto in ispirito? mai no: ma per provarle che l’amate di buon amore le comprerete gioielli, vezzi, diademe, vesti di gran valore e di molta orrevolezza: farete le sue camere elegantemente e splendidamente guernire di arazzi, di cortinaggi, di pitture, di sculture e di tante altre belle cose, n’ è vero? O che ci ha egli che far l’amore coi diamanti, cogli ori e fogli argenti? L’amore è spirito, il rimanente materia. La donna vostra sappia che l’amate, e non vi date altro pensiero. Voi ridete di cotesta uscita: ma così è in religione. Sissignore, lo spinto è l’anima della pietà, ma cotesto spirito è unito alle nostre polpe, le quali voglion vedere, udire, toccare. La fede senza le opere è morta; e la religione senza culto è un’idea. Il culto è lo sveglierino dell’anima. Oh. caro Edmondo, quando io sento a questi dì il suono delle pastorali, io me ne rifò, e voglio più bene alla Madonna.
Egli è costume in Roma , che per la prima domenica dell’Avvento scendono dagli Abruzzi que’ montanari colle cornamuse e le cenamelle per suonare la ninna nanna dinanzi alle Madonne che sono dipinte sui trivii, sulle case, e nelle botteghe de’ pizzicagnoli, de’ salumai, de’ droghieri, e d’altri mercati. La città echeggia di questi suoni per tutto; ed è bello vedere que’ discendenti degli antichi pelasgi a due a tre col loro cappello aguzzo in capo, tutto ricinto di nastri di varii colori, colle zazzere ricciute che ricascano loro giù per le spalle, co’ sandaletti allacciati su per quelle gambe sì ben fusate, con indosso le loro pilose mastruche, o con un sarrocchino in ispalla che batte appena loro alle ginocchia, fermarsi ritti sotto i tabernacoli e gli altarini della Vergine Maria ; porre la falda del cappello sotto il braccio; inchinare e riverire la santa Immagine, e dare ne’ rozzi loro stromenti. Vedresti quegli uomini di forme maschie e risentite , co’ volti abbronzati e colle barbe arruffate gonfiar l’otre della cornamusa e scorrere colle dita sui forellini delle cenamelle, mentre i compagni squillano cui pifferi acutamente , modulando quelle arie pastorali che ti trasportano coll’ immaginazione e col cuore alla grotta di Betlemme. Passando pel Rione dei monti verso l’ora di notte senti fra gli orti, e nelle valli delle Esquilie e del Viminale que’ suoni lontani lontani che ti commuovon tutta l’anima e t’invitano a dar gloria al Signore.
I bottegai romani crederebbero di non esser benedetti in quell’annata se non facessero sonare i pifferari alle loro Madonne, e ve li fanno venire tutte le sere dalla prima domenica dell’Avvento sino a dopo il Natale: poscia li regalano di qualche paolo, e i montanari nell’accomiatarsi lasciano loro per ricordanza un cucchiaio di faggio, ch’essi incavarono a sgorbia nelle montagne. M’avvenne un giorno del 1849, allorchè Roma era in mano de’ repubblicani, che trovandomi in casa d’un popolano, la moglie sua , ch’era un donnone si fatto, passando innanzi alla sua Madonna, gridò da sè a lei — Eh Madonna santissima, mandatele un accidente a sti birboni — Non si può , sapete , sora Agnese, imprecar male a nissuno, le diss’io: se volete bene alla Madonna dovete perdonare a tutti — Se ie voio bene! riprese l’Amazzone: figurateve, sor compare mio, se ie voio bene, ie faccio venì tutti gli anni li pifferari, ie faccio: che ve ne pare? — Io risi a sì fatto amore di nuovo conio; ma qui si che Dio gradisce la fede.
— Ed io vorrei un po’ meno di fede, disse Edmondo, ma più di buone azioni.
— Ed io vorrei l’uno e l’altro, soggiunse don Alessandro; ma perciocchè l’umana fragilità casca sovente in qualche miseria, se la fede è poca, l’uomo non si ricupera più mai; laddove colla fede l’uomo si pente de’ suoi trascorsi e torna a bene. La rozzezza e l’ira lo fa bestemmiare, la fede lo rivoca alle benedizioni. Vedrete a’ 17 di gennaio s’io dico vero. In quel giorno cade la festa di sant’Antonio abate , il quale fu scelto a patrono degli armenti e del bestiame minuto, acciocchè li difenda dai maligni influssi, dai casi sinistri, dalle ruberie de’ ladroni, e faccia prosperare gli ovili delle pecore, le mandrie delle vacche, delle bufale e delle cavalle con buoni pascoli e sani che le rendan feconde e lattose. Ebbene, io vi condurrò il giorno di sant’Antonio al monistero delle Camaldolesi ov’è la sua chiesa, e vedrete nuovo e bello spettacolo di religione e di fede. Que’ carrettieri trasteverini e montigiani, che in Roma sono migliaia, ed hanno que’ cavalloni vecchi per tirare la rena, la calce, i mattoni per gli edifizi, per isgomberare il calcinaccio dalle ruine, per tirare le alzaie delle barche in sul fiume, per condurre le paglie e il fieno dai fienili alle stalle, per iscaricare il pattume nel Tevere, e più che altro per carreggiare il vino da Velletri, da Genzano, da Civita Lavinia, e dai paesi de’ colli albani a Roma, que’ carrettieri sono in gran parte la plebe più rozza, audace e manesca della città, i veri discendenti de’ littori, de’ pugilatori, de’ gladiatori dell’antica plebe romana. Que’ loro cavalli non intendono spesso altro linguaggio che le bestemmie, le imprecazioni, i convizii e le contumelie; non hanno altre carezze che di colpi di nerbo e di randello; non veggono altri visi che burberi e feroci; non odono altro che urli e minacce. Tuttavia il carrettiere romano ama quel suo rozzone, e al frontale della testiera gli appende la medaglia di sant’ Antonio: e colui che ogni mo mento gli grida in capo — Che sant’Antonio t’azzoppi, che sant’ Antonio t’ accechi, che sant’ Antonio ti mandi un accidente — il giorno di sant’ Antonio lo mena a benedire con molta divozione al suo Santo.
Quel giorno pe’ carrettieri è gran festa. Alla prim’alba ognuno striglia il suo cavallo, gli dà il bruschino, lo ripassa col setolino, ungegli le unghie per bene, gli ravvia la criniera e la coda, gli pone in capo il pennacchio rosso e le nappe sotto gli orecchi, lo bardamenta da festa, e tutto il bardamento adorna di nastri, di fiocchetti, di campanelle, con una gran rosa di seta vermiglia sul posolino, laonde ne fa un brigliadoro. Il carrettiere stesso addestra il cavallo, e passeggia per le vie di Roma colla sua penna di cappone sul cappello a tesa riboccata; col suo farsetto gittato cavalcioni la spalla sinistra; colla sua fascia di seta chermisina ristretta al fianco; colla barba rasa insino alla pozzetta del mento, che gli gira sul risalto della mascella alle basette; colle scarpe di sommacco lucido, che pochi anni addietro aveano i fibbioni a traforo; co’ suoi orecchini nell’orecchio, e la catena d’argento dell’orologio che gli dondola alla cintura. Procede ritto, coll’aria brava, coll’occhio maestoso, ammiccando ai conoscenti, facendo le sue fermate alle taverne ov’è miglior vino: bee lì sulla via il bicchiere che gli paga il compare, si forbisce la bocca col dosso della mano, e oltre infino a sant’ Antonio, ove si mette alla fila attendendo la sua volta colla candela in mano per l’offerta.
Intanto i cocchieri de’ Principi romani fanno anch’essi la loro mostra; e il primo cocchiere del Signore per isfoggiare la sua valentia nel maneggio guida solo appaiati tutti i cavalli da cocchio delle stalle di palazzo. Tutte le coppie son messe a festa con pennoncelli in capo, colle bardature dorate, colle rose alla groppiera, colle redini di seta. Il cocchiere sale a cassetta del più bel carro da caccia (entro il quale siede il maestro di stalla cogli altri cocchieri), si chiude in mano le guide di diciotto, venti e ventiquattro cavalli; dà loro il cenno; e via. Egli è un gran sollazzo pe’ Romani il vedere tanti e sì nobili corsieri appaiati sotto un sol cocchio, ire superbi e mansueti, facendo le girate de’ canti a tempo, alzando in bell’arco i piè davanti, guizzando gli orecchi, e squassando le piume variopinte de’ loro pennacchi, mentre il cocchiere col suo zigaro in bocca, con tante redini in pugno, col calcetto della frusta appoggiato sul gallone, siede con un’agevolezza, come se guidasse due vecchi e docili cavallucci. Anche i cavalli delle stalle del Papa co’ finimenti da gala son menati dai cavalcanti e dai mozzi a sant’ Antonio, e sì a questi come a tutti gli altri il sacerdote dal limitar della chiesa dà la benedizione. Il Papa manda un cereo, e i Principi e Signori romani offrono anch’essi i loro: ma i popolani più ricchi, i grandi vetturini, i mercatanti di cavalli offrono cerei dipinti, dorati, e cinti di bei nastri a varii colori.
Amico, disse don Alessandro guardando fiso Edmondo, non vi par bello che il cristiano riconosca da Dio ogni bene, e lo supplichi a benedir lui e le sue cose? Mi pare che il popolo protestante manchi di gran consolazioni. Egli sente tutto il peso della sua povertà, delle sue fatiche, delle sue tribolazioni senza quei conforti che porge la religione cattolica alle calamità e alle miserie della vita. Il Romano, credetemelo, anche nei più gravi affanni, anche nelle più mortali angustie trova nella sua fede un balsamo che lo ravviva. Io vorrei condurvi incerte case del pianto, ove un’occhiata alla Madonna asciuga lagrime irreparabili e profonde.
—Edmondo, gli strinse la mano, e gli disse: Voi mi infondeste un nuovo concetto del popolo romano; e mi gode l’animo d’aver trovato in voi un cosi caldo patrocinatore de’ vostri concittadini. A rivederci.
LE OTTOBRATE
Pochi giorni dopo che don Alessandro ebbe quel lungo ragionamento con Edmondo a difesa del popol di Roma, andò a trovare Carluccio pittore in via Felice. Egli avea suo studio su altissimo a tetto, e le finestre rispondeano sopra il clivo del Pincio dalla banda che volge a ponente, per onde aveasi tutto disteso sotto gli occhi il prospetto della città, di Monte Mario, e del Gianicolo. La cupola di san Pietro nuotava in un mar d’oro per la calata del sole che coricavalesi dietro, e spandeva un lume fulgentissimo, il quale digradava dolcemente sfumato in un azzurro d’indaco trasparente per la volta de’ cieli. Carluccio era in un gran palandrano di cascemir rossocorallo con istelluzze e piastrelli bianchi e arancini alla persiana , e lo stringeva attraverso con un grosso cordone vermiglio che terminava in due nappi ricascanti sino al ginocchio. Copriagli il capo una greca di velluto color d’amaranto, dal coppo della quale si spiccava un larghissimo fiocco cadente all’indietro con largo sprazzo. Avea i suoi mustacchi e la moschetta ben pettinati, ed era in un paio di pianelle gialle a calcagnino, sicchè t’avea tutta l’aria d’un Van Dyck , o d’un Guido Reni.
Il suo studio era pulito e ben assettato, il finestrone mandava per l’impannata una luce quieta e dolce che non confondeva, ma dava grazia e vita alle tinte. Pendeano dalle pareti di molte bozze e schizzetti di teste, di braccia, di mani, di scorci; e mirandole dicevi: quella è la testa di santa Cecilia in estasi di Raffaello; quello è il profilo della Madonna della Seggiola; quello è il s. Bartolommeo di Michelangelo nel Giudizio della Cappella Sistina: quella è la Psiche della Farnesina; quello è un putto del Giambellini, il s. Marco del Tiziano, il Redentore di Leonardo da Vinci. Vedevi scherzi; vedevi grotteschi; musi e grifi di bestie; gruppetti d’alberi; tocchi e sfondi di prospettive; levate di sole, e fughe e lontananze aerine di monti.
Carlo dilettavasi eziandio di storiare argomenti del medio evo, e però alla parete di fronte vedevi appese corazze, usberghi, panziere, ghiazzerini, catafratte c giochi e cotte d’arme ben panneggiate. Costi erano elmi cristati, morioni, barbute, cervelliere, bacinelle a gronda, e visiere e nasiera e guanciali d’ogni foggia. Colà penzolavano stinieri, tracciaiuole, ginocchielli, gorgiere, spallacci, e guanti a lama e a scagliette; poi scudi, pavesi, rotelle, mezze lune, parme e brocchieri: quassù erano spade, scimitarre , daghe, tra fieri, costolieri, pugnaletti , stocchi , e punteruoli costolati da ferire tra le maglie de’ giachi.
Ohe! disse don Alessandro , Carluccio tu hai qui, l’arme de’ Paladini di Francia, e de’ Cavalieri della Tavola Rotonda: è quella Durlindana? E là non vegg’io la rotella del re Artù, e l’usbergo di Lancilotto del Lago? Che diascol di modelli hai tu cerco? lo ne disgrado l’armeria dell’arzanà de’ Viniziani.
— Accommodommele gentilmente un Principe romano, che l’ebbe da’ suoi castelli, ch’erano un dì dei Frangipani e poi de’ Savelli. E’ mi convien dipingere alcuni tratti delle antiche glorie italiane. Vedeste costà quella bella armaturina a commessi d’oro? La sarà per vestirne la giovinetta Matilda contessa d’Italia, allorchè di quindici anni scese in sul Tevere con Gotifredo di Lorena suo patrigno a combattere l’esercito tedesco che sosteneva te parti dell’antipapa Cadolao, e lo ruppe e disfece. Di quell’altra più grande con quelle borchie dorate vestirò la famosa Ubaldina quando sostenne l’impeto de’ Borgognoni sotto Cesena. Coteste serviranno per la battaglia de’ Lombardi contro il Barbarossa a Legnano, e quell’altre pei Pisani, che assaltano e vincono i Saracini di Sardegna.
— Ben fai, disse don Alessandro, di pingere le antiche glorie, poichè poco avresti delle moderne; allora gl’Italiani combatteano per la Fede e per la Patria e vinceano nemici dieci tanti di loro: oggidì combattono per ischiantare la Fede e la Patria , e si fanno scorgere da ogni savio , e avere in beffe per non dire in orrore.
Mentre Carlo e il Mansionario erano in questi ragionamenti entrò Edmondo con Gianni napoletano, ch’è un dipintore valente, e d’ingegno pronto, piacevole e bizzarro — Addio, signori, gridò Gianni con un vocione sonante e scoppiettando colle dita: son venuto a salutarti, Carluccio, e a fumare un zigaretto con esso te, che so n’ hai di prelibati di mano qui del nostro Edmondo.
— Prelibatissimi , rispose Carlo: ne vuoi dell’Avana o della Virginia?
— L’Avana è più dolce. Oh, don Alessandro, il fumo vi dà noia?
— Punto. Chi bazzica co’ pittori e non regge al zigaro, è come chi vuol passeggiare la Longara e non udire lo strepito de’ telai e il cicaleccio delle tessitrici.
— Puh, disse Edmondo, eccetto sempre i giovedì d’ottobre. Oggi per la Longara, per la Longaretta, per lo stradone di s. Gallicano e di s. Francesco a Ripa, pel vicolo del Moro e pel vicolo del Cinque, passate e ripassate a vostro bell’agio, e non udirete strepito nè di casse, nè di calcole, nè di navette. Oggi le popolane di Trastevere e de’ Monti sono tante Ladies, e tante Principesse del gran Mogol; anzi le dirò meglio tante sacerdotesse di Cibele, tante Menadi e tante Bacchee che trescano coi Satiri e coi Coribanti a gran vergogna del cristianesimo e di Roma. Voi avete bel dire, don Alessandro , della fede del vostro popolo, ma non iscemerete d’un dramma lo scandalo che egli dà a tutto il mondo.
— V ha più sorta di scandali, caro mio, rispose il prete romano: v’ha lo scandalo ragionevole, v’ha lo scandalo de’ maligni e v’ha lo scandalo de’ pusilli. Vedeste voi in quelle centinaia e centinaia di carrozze piene zeppe di popolane niuna donna o donzella scollacciata, o sol colle braccia scoperte? Le avrete vedute tutte vestire accollato, con que’ loro gran fazzolettoni di rosso fiammante incrociati sul petto e annodati alla vita; colle maniche a’ polzini; ed ora che molte le usano a tromba e a campana, le vedrete scendere sin sotto la metà del pesce del braccio. Andate un po’ ai Vaudevilles di Parigi, andate nei prati de’ sobborghi di Vienna, andate ai ridotti di Londra, andate ai baloardi di Berlino , e mi saprete dire se nelle feste popolari vedrete le donne in goletta e in pettino come le romane.
— Noi vi posso negare, e in ciò le glorio sopra tutte le donne d’Italia, nè vidi altre da poter farne riscontro se non le donne di Napoli, che procedon forse più turate delle romane; ma egli v’è un intoppo che le rende appariscenti e lusinghiere in eccesso, voglio dire quel vezzo di uscir per le vie in chioma senza una foggetta, una pezzuola , o un velo che le ricopra un pocolino. Ell’hanno certe acconciature, e quei loro capelli morati e luccicanti come l’ebano, che danno loro un’aria procace e scialacquata.
— Noi pittori , soggiunse Carlo ridendo , non diciamo così, e siam loro tenutissimi di quella mostra, perocchè vi abbiamo i modelli sempre bellissimi e sempre pagati. Vedete là quelle teste? Io le copiai tutte quest’anno in sulla via di Monte Mario nel prato d’un ridotto, ov’era un gran trebbio di donne in cerchio a veder un ballonzolo di giovinette. V’ha certo di ricche pettinature; ma le più hanno la dirizzatura nel mezzo, e vi ricascano i pendoni a stiacce che attorcono sotto l’orecchio e colle forcine gli appuntano dietro le tempie , ch’è un’acconciatura oltre modo modesta. Alcune sono a sbuffi ; ma le popolane vere lasciano quel garbo alle crestaie , alle sartorelle e alle modiste , che fa loro certi caponi sgonfi a cocomero; e quando le han sotto la veste il crenolino o la gabbia paion palloni arrostatici capovolti.
Allora don Alessandro, soffiandosi il naso, disse: Doni del quarantotto. Le popolane di Roma vestivano d’altra foggia, perocchè le portavano l’acconciatura col pettine alto a trafori, e nelle trecce sofficcavano gli spilloni d’argento a ghirlanda fitta che parea un’aureola o un nimbo: e cotesti spilloni dal mezzo cerchio in su erano a palline brunite, e i sottani erano a spadine coll’impugnatura e colla guardia: altri terminavano l’elsa con una mano che serrava una mela, o uno scettro: e le spose v’aggiugneano la rosa d’oro tremolante. Le più anziane chiudeano la capellatura in una reticella di seta verde, dalla quale pendea un cordoncino che terminava in un fiocchetto dondolante sin giù alla balza della sottanella. Ora le van tutte in certi calzarini di seta verde e rosata intrecciati sin sopra la caviglia, dove le nostre madri aveano le scarpette basse co’ fibbioni d’argento che picchiavano in terra: ora le nostre popolane, o minenti, non si differenziano dalle cittadine se non nell’andare in capelli; nell’avere quattro o cinque anella per ogni dito, negli orecchini a campanella , e in quelle tre e quattro collane d’oro a scudetto cogli smalti a sovrapposte e i granellini penziglianti a sonagliera.
— Egli è tuttavia un bel vestire, disse Edmondo, e voi cerchereste invano tutte le città d’Italia ove la plebe sia in miglior panni e vistosi della romana.
— Sia con Dio, caro Edmondo: segno che la non è poi quella plebe pitocca e lercia che, grazia loro, ci descrivono i giornali piemontesi, perchè angariata, spoglinta e smunta dai preti; i quali però si vede chiaro che le lasciano ancora qualche baiocco a scialare in vezzi d’oro, in usattini di seta , in abiti galati; e da godere per giunta qualche giornata d’ottobre in carrozza; far di buone merende; e menare il riddone in un prato a suon di cembalo e di ribecca.
— Le donne di trent’anni addietro, disse don Gianni, che ci descriveste, vedetele qui nei profili del Pinelli, che il nostro Carluccio tiene appesi alla parete dell’andito. Vedete fibbioni massicci, e orecchini che paion cerchi di botte: le collane a scudetto allora erano a mostaccioli, a olivelle bacche di cornia : ve n’era eh dell’oro!
— Ma il gran divario, soggiunse don Alessandro, è più rilevato negli uomini. Vedete qui nel Pinelli i romaneschi quant’erano originali; ora vestono quasi alla paina. Non si veggono più quei farsettini di velluto nero co’ bottoncelli fitti a pistacchio, nè que’ corpettini di scarlatto, o di vermiglione, che non aggiugneano alla braca per dar lungo alla fascia di seta variegata che avea gli svolazzi a frangia. Erano in bracconcel corto, affibbiato sotto il ginocchio colle fibbie a filograna, e aveano in gamba calzetta cilestra colle scarpe a tomaio basso e in fibbioni a traforo. Vedete pezzi d’omaccioni col loro cappello a pinnacolo, e la tesa sinistra riboccata con entrovi la penna di cappone! I più portavano il farsetto cavalcioni la spalla sinistra e il braccio ritto aveano spedito da poter difendersi ove occorresse.
— Dite bene, riprese don Gianni, che oggidì tutti costoro vanno in casacca di panno e in lunghi calzoni, di qualità che non li riconoscete plebei che alle mani callose, e perchè van tosi alla coppa con un po’ di ciuffo in capo alla brava.
— Noi siamo usciti di questione, don Alessandro mio, disse Edmondo. Io vi dicea che in cotesti giovedì d’ottobre le donne romane ritraggono dalle antiche Baccanti, sì sformato è il bagordo che menano su quelle carrozze. Oggi n’ho veduto più d’un mezzo migliaio vestite accollato bensì, ma sfarzosissimo, e le sono ben dodici per carrozza. Tre a cassetta, sei nella cassa e sino a tre e quattro sedute entro il mantice battendo i cembali, incoronate d’ellera e di rose. Ponete loro in ispalla le pelli maculate di leopardo, e in mano l’agatirso, e mi direte voi se le non sono le antiche Menadi seguaci di Bacco. Le son rosse infiammate in viso, cantano a gola le strofe dionisiache, e talora hanno di dietro, seduti sull’asse sospesa a bandelloni, tre uomini mezzo cotti, i quali con vociacce squarciate fanno bordone ai canti, e batton le nacchere a cadenza co’ cembali. Le vie di Roma, ond’elle passano a tutta corsa, ci dipingono i trionfi di Bromio. Escono di città, e tutte si rimbucano nelle taverne suburbane, ove s’apparecchian loro le tavole sotto le pergole, da cui pendono i grappoli nericanti, che esse non gustano, ma in quella vece s’attaccano ai fiaschi, e le son già brille prima che cominci il desinare.
Le tavole son tutte sparse di foglie di vite , d’ellera e di corimbi. Comincia la zuppa di trippe di vitella mongana condite colla pancetta di porco; e alcune per fare il brodo più gustoso versanvi dentro una foglietta di vin brusco. Si vien poscia al gallinaccio ripieno di salciccia e di bondiola col pastone: indi il garofonato di manzo , e per ultimo la coscetta e l’arnione di castrato. Poi la pizza coll’aglio, col pepe e colle alici per l’ultimo bere, il quale prima di venire a capo ha fatto vedere il fondo de’ fiaschi da dieci volte in su.
Come sono poi rimpinzate e avvinazzate come Dio vel dica, eccole in sul prato e dar ne’ cembali e nelle nacchere, e fare il ballo tondo, che voi non vedeste mai baccanale somigliante a cotesto. Chi si pone le mani a’ fianchi, e tragittando le gambe all’impazzata, si diguazzano, si contorcono, e scambiettano, spiccando salti e trinciando capriolette a mezz’aria. Talora vi sottentrano i maschi, e menano il riddone, la moresca, la gagliarda e la monferrina. Indi i livori, le invidie, le gelosie de’ giovinotti se la lor ninfa ha carolato più con quello che con questo; e stassera chi sa quante puncigliate e quanti sberleffi usciranno dalle punte de’ loro pugnalozzi dal manico d’ottone. E voi, don Alessandro, volete difendermi siffatte costumanze pagane?
— Io non le vi difendo, signor Edmondo ; ma dico che ogni popolo ha le usanze sue, e non v’ha città che alcuna volta fra l’anno non abbia le sue follie, nelle quali matteggia e scapestra lietamente. Ite a Firenze per la Rificolona e per la Befana , e udirete frastuono e nabisso che fanno colle voci e colle trombe, che paiono impazzati. Trovatevi a Pisa per s. Ranieri al gioco del calcio; trovatevi a Siena pel giuoco delle bandiere, e mi direte se quel popolo tranquillo e gentile folleggia di buona ragione , e se tira calci da stincare, ,e se chiocca pugni da smascellare. Ogni popolo vuole il suo sollazzo: e sì vi dico: che più ne’ popoli è pace, e più gustosamente si trastullano; di guisa che vedrete che nei turbamenti politici cessati le feste popolari ; e a’ nostri dì, che i vizii e le congiure fan guasto, i popoli non pigliano più piacere alle loro feste cittadine come pel passato.
— Sì, ma coteste delle ottobrate romane ritraggon troppo dal gentilesimo, e s’avvengono meno che mai alla città vostra.
— Primieramente, rispose don Alessandro, circa le feste delle vindemmie e del vin nuovo non potete giudicare voi altri settentrionali, che non avendo le vigne , non sapete qual gioia mettano le uve mature nell’animo de’ vindemmiatori: il vin nuovo col suo grillare, e con quel suo razzente pare che infonda novella vita, e i popoli meridionali la sentono correr loro per le vene e pel celabro, che grilla anch’egli, e spumeggia, e schizza gioia e tripudio; che dà poi nelle gambe e danza e caròla; dà nel gorgozzule e canta e strilla; dà nelle mani e battono il cembalo, e trimpellano il chitarrino.
Leggete i Profeti, e vedrete letìzie, gioie e feste grandi nella stagione del mosto; intantochè Iddio per affliggere il suo popolo peccatore e ribelle; lo minaccia della sterilità dell’uve, e dice che lugebit vindemmia; non vi saranno più canti, non vi saranno più danze, non si vedrà il vin nuovo spumeggiar sulle mense, le botti e i tini rimarran vuoti, dicerchiati e sdogati. Appunto come vedemmo anche noi negli anni addietro, che la muffa ci rodeva e marciva e cenerava le uve: oh di certo da cinqu’anni in giù non vedevate per le vie di Roma il festeggiare di quest’anno, in cui qualche poco d’uva s’è fatto, per grazia di Dio.
Io non vi vo’ tuttavia negare ch’egli non sia un vestigio delle feste di Bacco , come pel carnovale si è quello de’ Saturnali; ma oltrechè i popoli non pescano sì a fondo, e seguon l’usanza senza badare più a Bacco che a Cerere; Dio permise, che certe cotali rimembranze di gentilesimo rimanessero nelle genti cristiane, per ricordar loro da quali lascivie, stoltizie e dissolutezze le abbia tratte e divelte la Redenzione del figliuolo di Dio; le quali, ancorachè adesso non sieno a mille cosi sporche e bestiali com’erano nei di dell’idolatria, sono pur nondimeno cosi bruite, che le anime timorate non vi si mescolan punto, e noi sacerdoti ne sconfortiamo le giovani pudiche, quantunque a dir vero la maggior parte di loro ci va per sola voglia di trastullarsi, di correre in carrozza, di goder il verde della campagna, di cui son ghiottissimi i Romani, e specialmente per ispiccar quattro salti a suon di cembalo: tuttavia osserverete, che le donne ballano fra loro, e gli uomini non vi si mescolano , che rarissimo e per poco. Ite in Alemagna; ite in Francia; ite in Ispagna, e non vedrete mai nelle feste popolari le donne carolar sole, come a Roma.
Quelle poi che non hanno danaro da unirsi in brigata, hanno cotai lor giochi in sulla via e nell’andito della casa: perocchè le giovinette di quindici e sedici anni si raunano dal vicinato, levano un mezz’uscio dai gangheri , v’acconciano quattro cavi di fune che raccolgono in uno, l’attaccano al ferro della mezza luna del sovra porta , vi salgon suso a sedere in sei ed otto: e due lo dondolano a muta, il che in Roma si chiama la Canofiena. La capitana siede in testa e picchia il cembalo a battuta mentre tutte l’altre incoronate cantano certe loro canzoni con un gusto, e con un batter di mani , e con un’esultanza maravigliosa. La gente trae a vedere; le inquiline delle case di rincontro son tutte alla finestra, e fanno un cicalio , un passeraio, uno schiamazzo, animando le dondolone, e spesso portando giù le bambine, che lanciano loro in grembo, e godono a vederle dondolare. Altre più picciolette, al suono de’ cembali e delle scrocchie, gittan le pianelle, e danzano in peduli, e spiccano salterelli, e pigliansi per mano, e fanno la ghirlanda e il ballo tondo. I garzonetti col carruccio del padre stanno cavalcioni le stanghe, ed altri seggono sulla coda, e così altalenando, e spesso stramazzando, trastullano la brigata. Cose tutte che mostrano come per la vindemmia la plebe romana è in giolito, e tripudia e gavazza come la può.
— Io non vidi mai altrove, disse Edmondo, tanto bagordare come in Roma: e come bisogna stare all’erta nelle vie per non essere schiacciati dalle carrozze! tanto corrono a prova que’ cocchieri per oltrepassarsi e giugner primi alla taverna. Giovedì passato veniano giù dalle Zoccolette due carrozze piene di coteste cembaliere che s’affilavano per ponte Sisto: i due cocchieri faceano a gara a chi primo imbocca il ponte, e dalli, e frusta, e grida: i cavalli erano alla carriera; la gente, in quella stretta via, vedendo due carrozze appaiate di fronte venire a precipizio, ripanava entro le botteghe, pigliando i bambini, levandoli in aria perchè non istritolassero, e inviando imprecazioni ai cocchieri e alle minenti. Quand’ecco la carrettella sinistra, non pigliando bene le sue misure, investe col mozzo della ruota in uno dei cippi di granito che circondano la fontana di Paolo V. A quell’urto improvviso il pannello dell’asse si sganghera; la ruota si fracassa, il carro s’arrovescia; il caviglione dello sterzo salta fuori ; i cavalli scappano coi due rotini pel ponte; il cocchiere è scagliato a venti passi; le ninfe che sedeano nel mantice battendo il cembalo balzarono in aria: due caddero nel pilo della fontana; le sei ch’eran nella cassa, al capovolgere del carro, rimasero ammonticchiate le une sulle altre: i cembali rotolavano per la via, i fiaschi ch’erano nelle borse degli sportelli si ruppero e le avvinarono: le ghirlande cadder di capo, le chiome si scompigliarono, le vesti si squarciarono — Ohimè il capo! ohimè la gamba! ohimè il braccio! Accidenti al correre! Aiuto, cristiani!
Le due naiadi cadute nel pilo erano bagnate di sotto; i dragoni, che sgorgan violenti l’acqua dalle bocche, le aspergevan di sopra, la doccia dall’alto le affogava. Accorron popoli: chi salta sul pilo e dà di mano alle sommerse; chi s’affaccenda a levar su le cadute in terra — Non è nulla, coraggio, scuotetevi la polvere. Ho perduto il pettine; ed io lo spillone: eccolo, su, brava — Il cocchiere, che avea dato del capò in un ciottolone, era quasi tramortito; il sangue gli filava giù per la fronte, perchè avea uno squarcio nel sopracciglio: una delle cadute avea dato del naso in terra e sanguinava. I cavalli, ch’eran fuggiti col carrino, sgominarono i passeggeri ; tutti saltavano sui marciapiedi e si serravano alle spallette del ponte — ferma, ferma — chi fugge qua, chi fugge là: quattro gagliardi trasteverini dall’altro capo del ponte, veduto quell’abisso, tolsero i loro farsetti, e attesi i cavalli a piè fermo, li gittarono loro agli occhi, e si fermarono all’istante.
— Ecco, disse don Alessandro, ove terminano sovente cotesti pazzeggiamenti.
— E sarebbe il meno, disse don Gianni, mercecchè quando in carrozza vi son uomini , coteste gare del correre e del trapassarsi vanno talora a finire in coltellate. I Romani sono maneschi e subiti all’ira,. Giunti all’osteria, e fermati i cavalli, saltano a terra e vengono cogli emoli a parole di ferro; perocchè dettosi — Tu, a me? — A me, tu? e trarre i coltelli, e menarseli dritto all’epa, e cascare feriti gli uni di qua e gli altri di là è tutt’ uno. E ciò ch’è più maraviglioso a considerare si è, che in coteste ire belluine, altrove gli astanti accorrono per impedire che non vengano alle coltella; ma i Romani raro è mai che si gettino alle braccia de’ feritori per rattenerli, quando non fosser le mogli o le sorelle, che si scagliano come lionesse ad impedire i colpi; e se l’una giugne ad afferrare il braccio di colui che fiere il marito o il fratello, l’altra per disimpacciare il suo consorte abbranca la compagna per le trecce, o trattasi di capo il suo spillone, gliele dà in faccia: di che avviene che cominciata la buglia fra gli uomini, termina nelle donne, che s’accanano fra di loro come cagne rabbiose.
— Scherzi olla romanesca, disse ghignando il forestiere; e soggiunse — Don Alessandro, parleremo poi a bell’agio di coteste carezze tiberine, e vedremo se voi colla vostra eloquenza Socratica, ci saprete trovare il suo lato buono, che vi riesca in bocca un nuovo elogio da commendare i Romani.
— Voi, rispose, parlate troppo pel generale, e le generalità in questi casi escono dei termini e offendono il vero. Aggiugnete che, sebbene per lo passato qualche po polano fosse troppo facile al coltello, da alcuni anni in qua le tribolazioni hanno resa la nostra plebe più mite. Pel resto, signor Edmondo, come i maligni trovano il lato da mordere eziandio nelle più sante cose, così gli animi discreti veggono sempre un raggiuolo di luce anche ove altri non iscorge che notte profonda.
Carluccio accorgendosi che don Alessandro mutava colore, per toglier cagione di qualche dispiacere e rallegrar la brigata, disse ridendo : Vedete quel bozzetto di testa che ha tanto dell’antiche fattezze romane? Ell’è il ritratto d’una trasteverina di via della Luce, che le tolsi in un orticello presso santa Cecilia. Nel secondo giovedì d’ottobre io venia ragionando col padre Curato lungo la via di Piscinula per volgere a Ripa grande e uscire al fresco lungo il Tevere fuor di porta Portese. In capo a Piscinula è un bell’orto che avea l’uscio aperto. Il padre Curato disse: Vi disagerebbe, Carluccio, ch’io entrassi un istante nell’orto; ch’avrei a dare una risposta all’ortolano? — Punto, risposi; ed entrammo. Poc’oltre la porta trovammo in capo alla pergola un pratelletto, nel qual era un gran crocchio di fanciulle amiche della figliuola dell’ortolana parte a sedere, e parte a danzare fra loro al suon del cembalo.
Le fanciulle romane, e molto meno che mai le trasteverine, non sono punto peritose; perchè veduto il padre Curato, le sedute sguizzarono in pie, e corsero a baciargli la mano: quelle che danzavan ruppero la carola, e vennero anch’esse pel medesimo — Oh brave, figliuole mie, disse il Curato, cosi mi piace: sonate, cantate, ballate a vostro buon grado, ma da voi a voi senza cicisbei — Le putte lo ringraziarono; e passati appena, s’udì un gran ridere, e si videro alcune fare quattro scambietti, e l’altre correre al cembalo e ripigliare la danza.
Noi tirammo oltre in cerca dell’ortolano, ed ecco in fondo al viottolone, fra un cespo di ramerino, sedere tutta soletta e mesta una bellissima giovane, col gomito sul ginocchio e col mento in mano — Bè, che si fa Nunziatina? disse il Curato: come cosi solitaria? M’avevi pur detto giorni sono, che saresti andata quest’oggi a Frascati colla tua Comare di s. Giovanni , colla Tuta , colla Celeste’, e coll’Agnesina e le sue figliuole ? Or come veggoti qui così triste? Ètti egli incontrato qualche sinistro?
Eh, padre Curato mio, rispose la giovane gittando dua lacrimoni, chi è nato sotto cattiva stella non ha mai bene. Ditelo voi s’egli non è proprio così: io poveretta ogni sabbato che ha fatto il sole ho recato alla Comare un mezzo paolo del mio tessere, levandomelo della bocca, e per le strenne di Natale e di ferragosto vi recai sino a tre paoli, e ciò per goder l’ottobrata d’oggidì colle amiche. Per essere più appariscente, feci un poco di debito col mercantino di via del Moro, e comperai un grembialetto di nobiltà verdegaio fatto a ventaglio da pagargli un carlino la settimana; e v’aggiunsi due manichetti di trina, e un fazzoletto di setino giallo zafferano grandinato di cerchielli bianchi con intornovi una frangetta rosa, che mai la più bella. Pensate voi, padre Curato, ero io la cembalaia , e dovea proprio sedere in mezzo al soffietto della carrettella. Mi dicean la Tuta e la Celeste (oh sì) che noi tre facevamo la più bella carrozzata di Trastevere da santa Ruffina insino a Ponterotto.
— Eh bene, Nunziatina, perchè non ci se’ tu ita? Disse il Curato.
— Che volete? Toto mio fratello giocava domenica a piastrella con Cencio della Balbina ch’è il mio fidanzato: avean prima beuto un paio di fogliette ed eran calducci tutti due. V’era attorno a vedere di gran gente, e mio fratello diceva che la sua piastrella era più vicina al lecco di quella di Cencio: piglian le pagliette: misura di qua, misura di là — Ho vinto io, anz’io — Testimoni! — Tutti zitti. A Cencio salta il ruzzo, e dà del piede nella piastrella di mio fratello. Toto a quel sopruso non si tiene alle mosse, e avendo un coltelluccio, gli tira un sottomano al cuore. Cencio si cessa: ma la punta lo sfiorò tra costa e costa. Erano scamiciati ambidue; quando si vide sangue, il mio Toto riparò in quattro salti nel chiostro di s. Cosimato, ch’è luogo sacro: Cencio fu accompagnato a casa, e giuntovi, cadde in deliquio. Io ne fui tosto avvisata, e a quell’annunzio credetti morire: ma non ismarrii però d’animo, e corsi da mastro Girolamo, supplicandolo di condursi ratto in casa Cencio, sì per sapere se la ferita era mortale, e sì per indurre il padre suo a non dar la querela al fisco; chè noi avremmo pagato le spese del chirusico e delle sue giornate perdute. La più ritrosa a perdonare fu la Margherita sua sorella e amica mia: basta, misi su la Nastasia e l’Angiola, e tanto fecero e tanto dissero, che la Margherita mi rese contenta. Intanto era stato chiamato il chirurgo di s. Gallicano, il quale disse, che la non era più che una scalfittura; lavò la ferita, misevi la faldella, fasciollo, ed oggi comincia a levarsi.
Io corsi subito dalla mia comare di s. Giovanni , e le dissi: Comare mia, egli vi bisogna darmi que’ cinque scudi che avevo raggruzzolato a tanto stento per l’ottobrata. Essa non volea darmeli dicendo — Tu se’ matta, lascia che li maschi se la impattino fra di loro — Che siate benedetta, le rispos’io, volete che fratelmo piombi in carcere per pochi paoli rognosi? Non sia mai. Me li diede: pagai subito le visite del chirusico; diedi cinque paoli al portinajo di s. Cosimato che mi tenne il fratello un giorno e mezzo, e del rimanente domenica faremo una merenda alla prima osteria fuor di porta Portese. Vi sarà Cencio, suo padre, sua madre e la Margherita con me, coi miei e con Toto, mastro Girolamo, e i due giovinotti che condussero Cencio ferito a casa.
Vedete, padre Curato mio, se son disgraziata! Ma ancorchè sia dolente di non aver potuto godere questa bella giornata, nondimeno stamane son ita a fare le divozioni alla Madonna di sant’Agostino; che m’ha guarito Cencio mio, e liberato fratelmo di carcere; le ho promesso di digiunare tre sabbati a pane ed acqua, e di non giocare al lotto per un mese.
II Curato era tutto commosso del sorellevole amore di Nunziata, e l’animò ad esser virtuosa, e venire ogni domenica alla dottrina: diche la si consolò tutta; ed io intanto vedendo sì bell’intaglio di testa, colla matita ne pittai quattro segni e poi la ritrassi a pennello. Vedete s’egli non ha tutta l’aria delle antiche sembianze latine! —
Edmondo, fu sì preso del pietoso animo della fanciulla romana, che voltosi a don Alessandro, e datagli una stretta di mano — Io non credea, disse, che sotto quegli arditi sembianti albergassero cuori sì teneri e generosi.
I SOSPETTI
Egli era omai più di venti giorni che nè Carluecio né don Alessandro aveano novelle dell’amico Edmondo. Carluccio era stato più volte per trovarlo allo studio di due scultori, presso i quali solea ridursi; ed era ito per lui al suo alloggiamento; ma la casiera diceagli sempre non è ancora tornato — Sapete voi s’egli sia fuori di Roma? Le disse un giorno — Noi vi saprei dire davvero, rispose; ma io suppongo ch’egli sia ora cogli amici andato a caccia pei paludi e nelle macchie d’Ostia o di Fiumicino; perocchè una notte al tardi ci venne in casa vestito d’ un farsettaccio di carfagno colle brache di tela spina e aveva in capo il cappello colla tesa sinistra rivolta sopra l’orecchio, e dentrovi una penna di cappone penzigliante. Che v’ho a dire, signor mio? Egli mi pare che da un pezzo in qua il signor Edmondo non sia proprio più lui. Voi, che usavate seco tanto dimesticamente, sapete ch’egli era pulito come una farfalla, ed usciva sempre attillato, sempre azzimato, sempre odoroso come una ciocca di Bori. Si radeva la barba ogni giorno: avea certi pettinuzzi di tartaruga coi quali pettinava le basette per una buona mezz’ora; per la scrinatura dei capegli stavasi allo specchio da un’ora in su; e ugni, e ravvia, e dalli col pettine fitto, e col setolino forte, e colla scopettina molle; e liscia e liscia e gira il ricciotto che va sotto l’orecchio; insomma è non v’è fanciulla che facesse tanti vezzi ai capegli come il signor Edmondo.
Per la biancheria poi egli era incontentabile; sasselo la Giulia di via del Babuino, la quale stira per tutti i principi che scendono all’albergo di Londra, a quello di Russia, a quello di Serny. Ce ne vuole a contentarli. Eh! pure ne faceano gli elogi e davanle di buoni scudi. Ebbene. Il signor Edmondo avea sempre a ridire — e coteste crespe non sono diritte; e cotesti manichini e colletti non sono bene inamidati; e i petti non sono ben appianati; e il sopragitto degli ucchielli non è ben battuto; e quelle grinzoline del collo pajon fatte col vomere; intantochè la povera Giulia ne usciva intronata, e un bel giorno gittategli le camicie sulla tavola, disse — Oh la si trovi chi la serva meglio — e andossene. Egli era sempre a rimbrotti co’ sarti — e quest’è corto, e quest’è lungo, e il taglio non è di moda, e non mi si fa alla vita, e i bottoni li voglio a spighetta; nonsignore, questi vanno a reticella e quegli a bombolina — Il lucidatore degli stivali, (che ha il bischetto qui accanto) aveva un rabbuffo ogni dì — Bestia, chi t’ha insegnato allucidare a questa guisa? Ti paion egli stivali da metter mi innanzi? va isfangare le scarpe de’ villani pari tuoi. Il poveretto si scusava, dicendo — Sono specchi, tanto lustrano; che vuol ella? v’è tanto di cera, tanto di nero avorio, tanto d’olio di pesce, tanto di zucchero, v’ho dato su con tre setolini e due spazzole di vaio —
Ora, signor mio, uomo di tanta delicatura quant’era il signor Edmondo, s’è fatto rustico e grosso come un facchino di Ripagrande. Il vid’io, quella notte che ci tornò in farsetto, con una camicia di canapella indosso, coi capegli senza spartimento, toso di dietro come i carrettieri di Borgo sant’Angelo, con una fascia di filaticcio azzurro attorno ai lombi, che il direste un ranocchiaro di porta Angelica. Volete di più? Io non ci credo, vè; ma la Paola lavandaia dell’albergo dissemi l’altrieri, che il vide alla Lungaretta in sul canto del vicolo della Luce ivi ritto dinanzi a una cesta di rane e di granchietti di mare che vendeva alle trasteverine. Diascol credici! gridai alla Paola: e la Paola giurare ch’egli era desso; e che com’ella il si mise a guardar fisso, ed egli calò gli occhi. Sicchè fate voi. Io per me dico che egli è impazzito affatto.
— E nel suo quartiere non torna mai? Vi ci avrà pure le cose sue.
— Tutte: e che robe! che biancherie d’Olanda, che panni sopraffini, che porcellane di Boemia, che vasellame d’oro e d’argento! Vi dico io, che per signore gli è desso —
Carluccio salutò la casiera, e come uno stupefatto andò dirittamente in cerca di don Alessandro, dicendogli: Ho inteso del nostro Edmondo sì e sì: cose, come voi vedete, da spiritare soltanto a immaginarle possibili.
— O, s’egli è poi per cotesto, rispose il Mansionario, qual maraviglia? Ci capitano in Roma alle volte di così strani cervelli e bizzarri, che fanno capestrerie dell’ottanta. Puh! fra questi si potrà annoverare anche Edmondo, il quale per imitare le braverie di Giorgio IIII quand’era giovinotto, può benissimo scapricciarsi pe’ trebbii e per le taverne inciurmandosi colla plebe.
Ma don Alessandro era alle mille miglia dall’immaginar la cagione di quel farnetico, e disse a Carluccio: Tu che avevi si stretta consuetudine con lui non ti se’ mai accorto di qualche sua nuova fantasia? Non mi par naturale che l’uomo venga in qualche grande novità senza che l’anteceda alcuno indizio d’alterazione; poichè Edmondo non solea poi dare in istravaganze.
— Se v’ho a dire il vero, or che vi ripenso, mi pare ch’egli si fosse fatto più taciturno dell’usato: veniva allo studio, e datomi appena il buon dì, s’ interteneva a guardare i bozzetti e i ritratti che pendono dalla parete; e spezialmente piantavasi innanzi a quello della trasteverina, che copiai l’ottobre scorso nell’orto di Piscinula. Talora pigliava il trespolo, e sedeale di rincontro, standovi le ore sane senza dire parola e senza batter palpebra. Io intanto lavorava, discorrea cogli amici che sopravveniano, ed egli fitto sul trespolo, e ancorachè fossero di sua conoscenza non facea motto veruno. Una mattina venne Gianni napo letano, uomo faceto come sapete, e visto Edmondo in quella nuova estasi — Oh Carluccio, gridò a me per istrazio e per farlo versare, oh Carluccio, che testa hai profilato costi? che nasino è quello? che mentuccio colla fossetta in mezzo? e’ pare il buco d’un fusaiolo da dipanare il cotone.
A quelle parole Edmondo balza su come un aspide; dà uno strido da forsennato dicendo: Tu menti; e senza dire addio a persona m’uscì dallo studio. Gianni rimase sopraffatto a quel ghiribizzo, e voltosi a me — Gli è pazzo in fede mia buona, disse, e me ne incresce; perocchè in fine in fine, tutto protestante ch’egli si voglia essere, egli è poi bonuccio: ma mi si dice, che gioca la sera gagliardemente in casa di certi suoi amici, ove si taglia il Faraone; e vi perde di bei gruzzoli d’oro; e però ne va sì straniato, che pare un almanacco a vederlo girar per Roma cogli occhi stralunati, massime da qualche tempo in qua.
— Oh dimmene tante! esclamò don Alessandro. V’è egli dubbio che il cielo di Roma siagli venuto in uggia, perché il gioco del Faraone non gli dice bene?
— Ma la casiera mi disse però, ch’egli tiene ancora l’alloggio in suo capo, e v’ha dentro il mobile e tutto il suo corredo.
— E tu vuoi ch’egli siasi gittato per disperato a fare il ranocchiaro!
— Che! Le son baie coteste! e la Paola bucataia avrà beuto Dio sa quanti bicchierini di rhum e d’acquavite; chè la ne suol bere un buondato, e cogli occhi imbambolati avrà veduto Edmondo al trebbio della Longaretta. Figuratevi! Io credo che alle volte la non iscerne le pile del lavatoio, tant’è briaca, e vi affoga dentro le camicie, che perde sì spesso, e la dice poi che nel tenderle sul ballatoio il vento gliene portò negli orti del vicinato.
Mentre i due amici erano su queste parole, eccoti entrar Gianni , il quale lisciandosi i suoi gran mustacchi e la moschetta del mento, disse : Appunto voi, don Alessandro; ho la più sperticata novella a contarvi e la più matta che voi udiste in vita vostra. Ma grossa, sapete! e più panciuta della cupola di san Pietro.
— Escine, baione: tu sei sempre in sulle berte, e ci vorrai piantare qualche carota delle tue, che non la capirebbe il Coliseo.
— Oh s’egli è poi per carote; cotesta è una. Udite me. Ier sera a tardissima ora mi condussi a passeggio a Ripa Grande lungo san Michele con Nicoletta calabrese, il quale dovendo dipingere una bella notte rischiarata dalla luna per un quadro che figuri l’Erminia del Tasso, volle vederne i bei giochi delle luci e delle ombre nel Tevere e sul monte Aventino. Stemmo li un pezzo, considerando i lampeggiamenti delle acque sotto i mulini; gli sbattimenti di Ponterotto; il dondolare delle antenne de’ tartanoni e delle feluche; lo sventolare delle bandiere; il rompere de’ raggi fra le sarte e l’altro cordame dei navigli; i risalti argen tini e gli sfondi cupi della rocca dell’Aventino; le ombre delle antiche muraglie e le nericanti fughe degli allori che spalleggiano il lungo viale de’ giardini del Priorato de’ cavalieri di Malta. La varietà di quelle scene notturne, la vaghezza di que’ prospetti, i riverberi tremolanti delle acque correnti , il silenzio che ci regnava d’ intorno, la densa nebbia che stendeasi sopra la spelonca di Caco, ci teneano come assorti in un dolce rapimento.
Ma il rimbombo ripetuto della torre di Campidoglio, che sonava la mezza notte, ci riscosse, ed io preso il Calabrese pel braccio — Amico, dissi, è tardi: hai sentito il ritocco della mezza notte? Andiamo. Così dicendo ci avviammo passo innanzi passo verso il cancello della Dogana, e volti verso santa Cecilia, imboccammo la viuzza Anicia, e procedemmo verso l’arco de’ Tolomei. Come fummo inoltrati per esso, vidi una tavernaccia aperta e dentrovi alcuni magnoni seduti a un grosso desco di noce. Che volete? mi salta il ticchio di bere un bicchier di vino, ch’io vedea ne’ fiaschi limpidissimo raggiare dinnanzi alla lucerna come l’oro fuso. Detto fatto. Eccoci dentro. — Eh bel zitello, recaci due fogliette di quello da sei — Subito — Intanto ci sedemmo sopra un pancone, e posti i gomiti in sulla tavola, mi guardo attorno….
— Bè, ci beesti e ti seppe buono, interruppe alquanto alterato don Alessandro. Diascol, che tu ne venga a capo!
— Pace, pace, don Alessandro mio, riprese Gianni. Un po’ di quella flemma , che voi predicate in san Giacomo alle lavandaie di Scossacavalli. Guardandomi adunque attorno mi veggo in una volta a sei scalini sotterra, tutta affumicata, sudicia, e collo spazzo di terriccio a grommi, con tre deschi del colore del cioccolata : sopra l’uscio che mette in cucina e’ v’era una Mater Pietatis colla sua lampanetta accesa innanzi, ch’era infitta in uno sporticello d’asse, da cui pendeva una tovagliolina a frange, la quale dovette un di esser bianca, ma il fumo crasso che usciva dalle padelle del fritto, l’avea resa d’un lionato acceso. Dalle altre pareti pendea un Meo Pattacca , che trimpellava il ribecchino; una danza gagliarda ballata da otto fanciulle, una rissa di carrettieri che s’accoltellano, una barruffa di trecche, tutti quadrucci condotti a profilo coll’acquaforte dal Pinelli.
— Gianni, tu ci hai tolto proprio a straziare colle tue lungagnole: su bravo, vieni al punto.
— E al punto sia, riprese Gianni. Que’ magnoni di contro a noi eran quattro. Certi grugni vi dico io, che trovati per la via di notte egli era da gittar la borsa, per averne la pelle intera. Pare che avessero rondinato per Trastevere con un mandolino da serenate, perocchè il più giovane fra loro avea l’istromento posto sulla tavola. Costoro si trionfavano una trippa di vitello in zuppa, e un gallinaccio al forno; tre di loro trangugiavano con tanta furia che pareano cani da caccia, ma il quarto appena che spizzicasse con fastidio qui e colà; e mentre gli altri a bocca piena s’affaccendavano di parlare, o piuttosto grugnivano come i ciacchi, impacciati dai grossi bocconi, l’altro taceva, e colle dita sfregolava il pane che s’avea dinanzi; guardando e noverando i travicelli del soffitto.
Io volgea loro le spalle, e Nicola aveali di fronte; laonde, stava tutto intento riguardandoli, e spesso vedendo le boccacce che faceano maciullando a due palmenti, sorridea fra sè e sè; ma come furono verso il termine della cena e davan ne’ fiaschi trincando lietamente, allora scolpian meglio le parole, ed uno di que’ galuppi disse: Cecco, tu la potei ben sonare la tua ribecca, potemmo ben cantare quel bel duetto, che quella ladra si facesse mai a uscio o a finestra; e sì fummo per via Anicia, per l’arco de’ Tolomei, per la via Bonosa e del Merangolo, pei vicoli del Drago, della Luce, del Piede e della Torretta; in somma per tutti i crocicchi vanendo dal Ponte a quattro capi insino a oltre san Grisogono; e tu trimpellavi anco cammin facendo, e di molte fanciulle fecer capolino; ma quella qui che cerca compar Peppe e’ dice, che non la vide mai. O cotesta è una bellezza sognata da lui, o cotesta bellezza è sotto cento suggelli, e la non si può vedere. Ma proprio, compar Peppe, voi dite ch’ella è cosa viva ed abita in Trastevere, e la dee esser plebana della parrocchia di santa Maria della Luce? E che di più ell’è amata da uno che fu ferito dal fratello di lei? O ella ha mutato alloggiamento, o voi avete sognato, o in vero voi sognate adesso.
Compar Peppe a queste parole guizzò in piè come un liopardo, diè d’un pugno sulla tavola, e mettendo un gran mugghio, disse: Ell’è viva, e io non sogno, e tu se’ un poltrone che non la vuoi trovare: e gli sputò un sornacchio in viso, chiamò l’oste, gittogli una mezza gregorina sul desco, e senza attender l’avanzo, uscì fieramente dalla taverna, sbattendo l’antiporto come una furia. Pensate don Alessandro, s’io al primo udirlo gridare mi voltai ratto! E, fatevi pur le croci, egli era il nostro Edmondo vestito a uso trasteverino.
— Di’, ripigliò il Mansionario, egli mi parve Edmondo, ovvero somigliava Edmondo, che altrimenti io ti avrò per cicalone, come la Paola lavandaia, che giurava pel suo capo senza cervello, ch’Edmondo faceva il ranocchiaro.
— O Paola o non Paola, egli era desso; e il vidi a’ fatti. Perocchè non era egli appena uscito, che quel brigante cui avea sputato in sul muso, divenuto di mille colori, gridò anch’egli alla sua volta: Scannato! a me poltrone? a me uno sputacchio? E col manicotto forbitosi in fretta, disse, al corpo, al sangue, mi pigli un accidente se non gli pesto il grugno come il baccalà. Gli altri due senza punto scomporsi, gli dissero: Mastro Menico, sta buono e bei un altro bicchiere; che quella mezza gregorina vogliamo bercela tutta. Oste recaci tre altri fiaschi. Ma Menico disse — Serbatemi la parte mia, che vo a dargli due sgozzoni e torno. —
Noi avevamo già beuto le nostre fogliette e pagato, laonde visto quell’omaccio uscire, gli tenemmo dietro. Io aveva in mano un grosso randello nocchieruto che parea una clava, e Nicola un frustino all’inglese, che avea sotto l’intrecciatura di cordovanetto un’anima di ferro, e in cima un martello d’acciaio a due bocche, il quale ove picchiava lasciava il marchio davvero. Fattici adunque pel vicolo verso la piazza Anicia, vedemmo mastro Peppe ch’era in sul volgere per la via de’ Genovesi, e mastro Menico il quale a gran passi veniva ad investirlo colle pugna serrate. Come il primo udì i passi concitati dell’insecutore si volse lesto come un cavriolo, e postosi in parata col piè dritto dinanzi e con tutta la persona indietro, lo stava attendendo. Giuntogli a tre passi, grida — Che vuoi? — Menico a capo basso, gittasi tutto sul d’innanzi e si scaglia per investirlo: ma Edmondo (era lui certo alla voce e alle fattezze) si butta di fianco e gli lascia andare un pugno sì massiccio nella tempia che rintronò sino alla Madonna dell’Orto. Menico ne vibra un altro, ma Edmondo facendo delle pugna e delle braccia una ruota rapidissima, deviava i colpi del l’avversario. La buglia era forte: Menico sprangava pugni di libra; l’altro li parava colla ruota, e parando, sofficcavane di sì gagliardi, che sembravano bolzoni da far breccia nella cortina, ed erano sì fitti e spessi, che tra di sotto e di soprammano te lo condì di buona ragione.
Menico era nerboruto e grande, ma non potè mai colpire di pieno quell’alice d’Edmondo, il quale gli sguizzava per lato, e facendo il mulinello delle braccia non lasciava mai entrare il nemico. Finalmente Menico sbuffando come un istrice, spintosi addosso all’avversario, volea gittarlo in terra: ma Edmondo, avvedutosi del tratto, da buono schermitore gli caccia il piede fra le gambe, e datogli il gambetto, lo fa stramazzare supino, ed egli sopragli. Oh, don Alessandro mio, che groppo! Edmondo ficca a Menico un ginnocchio alla forcella dello stomaco, e picchia e zomba, che l’un pugno non attendeva l’altro : pareva un maglio delle gualchiere, ed ogni colpo rintonava come se desse in un cassone. Quando glien ebbe dato un pasto de’ buoni, si leva d’in su quel corpaccio, e fresco e snello vassene pe’ fatti suoi. S’egli non era Edmondo, ch’è sì valente nella scuola del pugilato, chi volete voi che crocchiasse quelle pugna, aggirasse que’ cerchi, desse quelle stincate? Io il vidi più volte in villa Borghese giocare co’ suoi camerata, e non v’era chi la potesse con lui.
— Dovevate tenergli dietro dalla lunga, disse don Alessandro, e vedere ov’egli tornava d’ albergo.
— E il feci; ma che volete? Sissignore, fatti alcuni passi eccoti quattro uomini d’arme ch’erano in ronda, i quali, veduto quel fastellaccio in terra che gemeva gli dissero: — Qual se’ tu? — Son mastro Menico, disse il cattivello balbettando, son mastro Menico della via de’ Chiavari — che fai tu qui? — Son caduto sotto i colpi del bastone d’un assassino — Chi fu? — mastro Peppe — Chi Peppe? — Quel che fa le serenate per la Longaretta ed è pieno di scudi. Io credo che li rubi — Dov’ è ito? — Laggiù che so io? laggiù, forse in Piscinula.
Due si spiccarono per tenergli dietro; ma trovato noi, ci piantarono quattro mani in petto, dicendo — Olà chi siete? dove andate? — Pei fatti nostri, rispos’io — Vedeste un assassino che assalì un pover’ uomo costà sulla piazza Anicia? — Noi non vedemmo assassino di sorte; siamo duo pittori stati a diporto a Ripa Grande per vedere i giochi di luce della luna da ritrarli nell’arte nostra — Pur non vedeste sulla piazza disteso un pover uomo? — Sì lo vedemmo; ma egli ebbe la mercede che si meritava: perocchè, forse ubbriaco, egli assali un popolano che passava indi soletto, e investillo. Quell’altro si voltò lesto come un daino, e si difese con grande animo, e pestò il grugno all’assalitore per modo che gli dee aver levato di capo il ruzzo di molestare chi va per la sua via — Ah bene, risposero i due carabinieri; e lasciati noi, tornarono di gran passo ai compagni, dicendo loro per certo, che il primo assalitore fu lo stramazzato, e ne avea riscosso quella buona derrata di pugna. Il fatto si è, che te lo rizzarono, e lo tradussero alle carceri nuove; poichè noi che li dinanzammo da Ponte Sisto, gli abbiamo veduti tener giù per la via Giulia e non arrestarsi che di rimpetto alle carceri.
— Prosit! esclamò don Alessandro, ma infrattanto il vostro preteso Edmondo v’è fuggito, e noi potrete più ormare.
Allora Carluccio stropicciandosi la fronte, disse: amici, cotesta non è cosa da pigliare a gabbo. Allorchè, ragionando delle ottobrate, io recitava il caso avvenutomi nell’orto di Piscinula con quella giovinotta che per salvare il fratello s’era privata di quel sollazzo, io vidi poco appresso Edmondo tutto sopra pensieri, e fece mille interrogazioni per iscalzarmi chi ella si fosse, e dove tornasse di casa; ma io che non la conoscea punto, gli risposi, che la ritrassi perch’ella avea fattezze del tipo latino d’un’aria fra il maestoso e il venusto, e d’un garbo e d’una grazia che sentiva più del bello ideale che delle forme volgari e quel viso mi dicea bene per un quadro della Virginia romana : e non ci posi più mente.
— Fa di chiedere al padre curato della Luce chi ella siasi costei; se fanciulla da bene, s’ell’abbia l’arte di tessere o d’ incannare; se la sia vicina alle nozze con quel giovinotto che fu ferito da suo fratello; che parentado abbia; poichè tu sai come son fatti i trasteverini; buoni, generosi quanto vuoi, ma iracondi e maneschi. Se davvero Edmondo si mise per istrana fantasia a voler ormeggiare la zitella, e’ risica d’aver più d’un ucchiello fra costa e costa, e l’avrà a buon mercato se non ci andrà che col capo rotto. Ma che proprio siasi gittato al pazzo partito di mascherarsi trasteverino per giugnere un tratto a vederla? Dico a vederla, e anco dalla lunga, poichè del parlarle può far suo conto di non ci riescire : dapprima perchè il più delle fanciulle di Trastevere hanno l’aria spigliata e brava; ma sono sì altere dell’onestà che sia detto a gloria del popolo romano, egli è da star loro a una rispettosa distanza: secondo perchè se la fanciulla ha già il suo fidanzato; sì, valle sotto la finestra o bazzica intorno all’uscio se tu puoi, e vedremo; in terzo luogo, ov’egli parlasse si scernerebbe al primo aprir bocca ch’egli è forestiere, e farebbesi picchiar dietro le tabelle alla gente; e i monelli e le putte gitterebbongli in viso le scorze d’arancio.
Se poi s’avvedessero ch’egli è gentiluomo, e come dicono i trasteverini, un paino travestito, leverebbonlo su in predelucce portandolo in trionfo per la Longaretta, e passato il ponte a quattro capi, gli darebbero la culattata per suggello della impromessa di non porre più il piede in Trastevere. Oh, che sarebbe forse il primo? Sanselo alcuni forestieri che si pensavano di fare i civettoni in via della Luce e sotto l’arco dèlia Nunziata, come sul Corso e in piazza di Spagna: vi do la mia fede, che da una volta in su non v’incapparon davvero la seconda, tanto n’ebber d’avanzo.
Cotesti ragionamenti di don Alessandro erano a capello; e per senno e verità ce n’era a ribocco; ma don Alessandro, comechè vecchio e sperto degli umani capricci, facea de’ conti a cui non tornava la somma, perocchè vi mancavano molte partite del dare e dell’avere. Il fatto si è ch’Edmondo per cotesta sua incognita trasteverina entrò a pie’ giunti in un labirinto, ch’io non vi prometto ch’egli n’esca a buon mercato.
Allorchè Carluccio pittore narrò la storia di quella buona giovane là nell’orto di Piscinuia , e com’ella stavasi solitaria e sconsolata mentre le altre fanciulle altalenavano e danzavano al suon de’ cembali, Edmondo n’ebbe compassione, e se ne sentì scendere all’animo un affetto di riverenza e di pietà. Ammirava quel suo tratto generoso di sorellevole amore, avrebbe voluto anch’ egli una sorella che l’amasse così; pareagli che un cuore sì fatto dovesse esser nobile, elevato, capace d’ogni più bella e magnifica azione. Col pensiero entrava sovente in quell’orto, fra que’ cespi di ramerino, sui quali sedeva col gomito sulle ginocchia, col mento sulla palma della mano, coll’occhio volto all’erboso terreno, mesta, sospirosa, con una lacrima che le cadeva in grembo. Quella lacrima egli avrebbe voluto asciugarla; dire a quell’afflitta: La tua mestizia è più invidiabile della gioia, poich’ella è mescolata colla soavità della buona coscienza, la quale è conscia a sè medesima d’una sì bella e candida azione. Tu non se’ ita in tresca colle compagne, non ti se’ condotta ai sollazzi della campagna, non hai fatto mostra delle tue chiome bene intrecciate e incoronate di fiori, delle tue robe da festa, de’ tuoi vezzi di oro; non hai suonato il tuo cembalo, non hai guidato la danza nei prati ; ma liberasti il fratel tuo dal carcere, cavasti di pena i tuoi genitori, inducesti l’amante al perdono, riacquistasti co’ tuoi industriosi modi l’amica perduta; ti rivolgesti a Dio, e Dio t’infuse una consolazione, che le tue compagne, ite ai villerecci trastulli, non posson gustare. Godi, benedetta, del tuo trionfo.
In coteste dolci fantasie tuffavasi Edmondo, e v’era in esse un misto d’ammirazione, di tenerezza e di placido affetto che tutto l’assorbiva. Edmondo era mondano, era poeta, era gran lettore di libri immaginosi, caldi, animati, che trascinano il cuore a passioni violente, a imprese audaci, temerarie, esorbitanti: nel fondo era buono, ma la bontà di cuore quando non è diretta dalla discrezione, devia sovente dai placidi affetti a malinconie profonde, ad agitazioni tempestose, ad arrischiati e stolti partiti. Edmondo il giorno poi que’ discorsi di Carluccio, recossi allo studio, e intrattenutosi con lui in baie, tutto a un tratto gli disse celiando:
— Bè, indicami il ritratto di quella tua Trasteverina.
— Dillo bozzetto, riprese Carlo, ch’ io incarnai venuto a casa con quattro botte di pennello. Ad ogni modo le fattezze son tutto quelle; vedi bella fronte, alta, aperta, candidissima, assettata in quella cornice di capelli corvini: i due pendoni, e le treccette non ti paion della Niobe? Ell’è una testa greca co’ lineamenti del tipo latino, ch’è più risentito e più maschio de’ sembianti ellenici. Non ci vedi tu l’aria di quella donna che campeggia nella Trasfigurazione di Raffaello?
— Va bene; ma la tua testa alla vaghezza del disegno congiugne un sentimento di pudica alterezza, un non so che di spiriti grandi, di dolci e chiare affezioni, d’animo gagliardo, candido e sincero che rapisce.
— Eh, tu se’ filosofo e leggi anco ciò ch’io non scrissi: tuttavia ell’è una testa romana d’una leggiadria non comune, e colsi con piacere l’occasione di ritrarla.
Qui terminò il dialogo fra i due amici; ma cominciò per Edmondo un tumulto nuovo nell’animo, che gli tolse la pace. Domandò, facendo lo sbadato: Proprio non sai chi la sia, ove abiti, come la si domandi?
— No, nulla, rispose Carluccio. Leonardo da Vinci entrava nella piazza del mercato, e visto un profilo che gli andava a garbo, schizzava due tratti colla matita, e tirava oltre cercandone un altro —
Edmondo non aggiunse più parola, e si tenne chiusi profondamente in petto i suoi pensieri: uscì dallo studio e si mise alla volta di Trastevere, non forse per avventura s’avvenisse in colei che allora era l’oggetto di tutti i suoi pensieri. Alle prime era fermamente una curiosità capricciosa; in processo si fece una passione crudele che aveagli alterato la mente, e conducealo alle più forsennate risoluzioni.
IL RANOCCHIARO
Il francese Charles offerse nei mesi passati in Roma uno spettacolo di forza, di coraggio, e d’ardimento sì grande e maraviglioso, che forse l’umana prodezza non avea ne’ tempi antichi e ne’ moderni dato ancora a vedere. Egli vi condusse un gran serraglio di bestie feroci, fra le quali primeggiava l’orso bianco, l’iaguar o tigre del Brasile, una pantera, un leopardo, la più bella tigre del Bengala che si vedesse mai, cinque ben giubbati leoni dell’Atlante, due leonesse, e otto iene del capo di Buona Speranza.
Charles domatore di belve è uomo grande della persona, di sembianti risentiti, franchi e alteri; d’occhio nero, fulgido e imperioso; di voce argentina e sonora; di belle forme e complesse , e in uno snelle e vigorose. Egli imperiava coll’occhio, cogli atti e colla voce sopra que’ crudeli e spaventosi animali per guisa, che dimenticata la ferità natia gli si assoggettavano come cagnuolini da vezzo. La gente traeva in calca a vedere quest’uomo audace entrare ne’ gabbioni, e farsi obbedire e riverire da quegli animali indomabili e superbi; sicchè vistolo solo a solo con que’ feroci palpitava il cuore in petto a ciascuno, e più d’un viso si facea smorto, e più d’uno sentiasi tremar sotto le ginocchia.
Charles dapprima entra nella gabbia della tigre. Questo crudelissimo animale volteggia rapido fra i suoi cancelli, e guarda sempre con terribili occhi, e annasa, quasi beendo per le narici il sito degli uomini circostanti; spesso spalanca la bocca e fa vedere quella crudele filiera di denti e quella lingua color di fiamma. Charles prima d’entrare schiude alquanto l’usciuolino per vedere le disposizioni della belva; s’ella è tranquilla egli attende che nel volteggiare gli venga di faccia, ed entra scamiciato con piè franco, e tenendo un lungo stocco in mano ravvolto in una guaina elastica. La guarda fìsso e grida in francese con voce sonora e imperiosa : Eh bene! qua vien qua. Quella efferata gli s’arresta di fronte e spicca un ringhio pauroso.
Allora Charles la picchia dolcemente sulla testa, e la gratta dopo gli orecchi e la liscia. La tigre lo guarda, e mugola e gongola alquanto di piacere. Indi le grida — A terra — e la bestia si colca. L’uomo la palpa, l’accarezza, e poi le mette il piè sulla testa e l’altro sul fianco, guardandola intentamente. Poscia si tira un pochetto da banda, e le intima di alzarsi. Quella dà un guizzo, salta in piè, e guata. Charles le abbranca le mascelle, e le spalanca la bocca, mentr’essa dalla strozza manda urli smaniosi. Per ultimo le grida in capo: — Raccosciati là — Colei fa una volta, e s’acciambella per accosciarsi; ma mentre fa il cerchio, Charles coglie il momento, dà due passi indietro sguardandola, e d’un salto è fuori della portella. Gli astanti, usciti da quel ribrezzo, batton le mani a quell’invitto.
Poco appresso è la gabbia del più grande e bello de’ cinque lioni: Charles d’un passo concitato è già dentro, e lo chiama per nome, e gli afferra la giubba e lo scuote. Quel re degli animali lo guarda con occhi accesi, dà un rugghio forte, e si piega sui pie’ deretani, quasi dicendo — Questa mano sola può ardire di tanto — Charles gli piglia coll’altra mano la mascella di sotto, e gli spalanca la bocca, e fra quelle immanissime fauci gli mette il proprio capo. Indi lo fa distendere in terra e gli sale ritto addosso, né quel superbo animale si muove punto, o dà mostra di sdegno. Lo rialza, l’accarezza, lo saluta, e parte, mentre il lione lo guarda con occhio tardo e solenne.
Noi vedemmo simili maraviglie in altri domatori di belve feroci, altri de’ quali entrava alla tigre, altri al lione, ed altri alla pantera: ma quanto descrissi di sopra è nulla a quella tremenda mostra che di poi diede l’audacissimo francese in Roma.
Era nel mezzo di quel serraglio una grande stanza inferriata, albergo dell’elefante, il quale fu fatto uscire di là e condotto altrove. Da quattro porticcjuole vi saltarono in mezzo quattro iene, urlando, stridendo, nabissando e azzuffandosi e addentandosi rabbiosamente. La iena è la fiera più crudele, odiosa, furibonda e implacabile contra l’uomo fra tutti li foresti animali che anelano al sangue. Essa o vivi o morti dilania gli uomini senza pietà; e per le scure e dense foreste e per gli aridi e sabbiosi deserti dell’Africa sente a molte miglia l’odore umano, e v’accorre sitibonda di strage, e ringhia, e latra e le alte setole della groppa rizza e commove serpentosamente.
Entrate adunque in quella gran cancellata le quattro iene, e con occhi biechi e con rabbiose bocche assannandosi, balza fra loro l’intrepido Charles minacciandole a gran voce, e scoppiando per aria una frusta. Avresti veduto quelle quattro versiere peritose e intimorite, sgropparsi, sceverarsi e ritirarsi nei quattro angoli, mentre Charles garrendole e fulminandole cogli occhi, le tiene in resta. Indi tratto di tasca un pezzo di zucchero le chiama ad una ad una per nome, e ciascuna, secondo che le domanda, s’accosta per torgli di mano quel candido, di cui sono ghiottissime. Egli alza la mano alle sbarre, e quella spicca un gran salto per aggiugnerlo, e coltolo s’abbassa: ma Charles le s’avventa alla bocca, gliela spalanca, le ficca dentro il pugno, e le ritoglie lo zucchero. La belva mette un urlo che spaventa, e non s’acqueta sinchè non gliel ridona. Nè basta. Charles si pone lo zucchero fra le labbra, chiama la iena : quella gli pianta una zampa in petto, l’altra sulla spalla, e con l’ingorda bocca gliel trae dalle labbra, con estremo palpito degli astanti.
Nè basta ancora. Charles rizza una tavola, vi pone uno sgabello, s’accosta a un usciuolo, piglia da un garzone (ch’è di fuori e sporge il braccio) un gran vassoio di carne affettata, lo pone sulla tavola e siede. Le iene vi accorrono due per parte, e con ferino fremito e con grida e abbai ferocissimi agognano al cibo e saltano per azzaffarlo. Egli grida, minaccia, ma quelle bestiacce ribelli ad ogni imperio e dimentiche d’ogni disciplina, con occhi di bragia e colle bocche spalancate s’apparecchiano all’assalto. Allora egli ne getta una fetta alla più vicina, e l’altra per astio l’addenta dall’altra parte, e tirano, e ringhiano, e la disquarciano. Una più ladra e violenta saltò di botto sulla tavola, ciuffò dal piatto un gran catollo di carne, e le altre addossole per istrapparglielo di bocca. In un attimo quel monticello di carne spari fra le bramose canne.
Allora Charles apre uno sportello, e balza in mezzo alle iene il leopardo agile e destro, spiccando salti altissimi; se non che mentre più s’agita e freme, Charles con occhi scintillanti l’arresta a mezzo il salto, lo atterrisce, e riciso gli grida — Cuccia là — Quella snellissima delle fiere si scaglia d’un botto sovra un alto sgabello e sta. S’apre un’altra porta, e vedesi procedere innanzi una lionessa, alla vista della quale ogni iena dà luogo e si rincantuccia in presenza della sua reina. Charles l’affronta ardito, la palpa, la fa coricare, e fatto della lionessa guanciale vi posa su il capo, le prende la zampa davanti, se la circonda al collo, e colla mano le gratta il capo. Quella immane fiera non fiata, si grande è il potere che quell’uomo esercita sopra di lei. Poscia la fa rilevare, e le impone di saltare sopra uno sgabello di fronte al leopardo e star cheta. Essa pone le due zampe dinanzi l’una sovra l’altra, s’attorce la coda alla groppa, e guarda dignitosa gli astanti, come le due lionesse egiziane di basalto che posano sulle fontane del clivo Capitolino.
Tu stai ammirando quell’uomo fra quei feroci animali che colla folgore de’ suoi occhi tien domi; ma Charles apre un portello, e vedi entrare a passo maestoso un lione, il quale entrando scuote la giubba, s’inoltra ruggendo, e si pianta nel mezzo. Allora Charles chiama tutti gli altri , e scoppiando la frusta, e gridando profondo e concitato, li mette in gran movimento; sicchè stando egli nel centro, le iene e i leoni corrono, saltano una sbarra, s’accerchiano, si confondono con un arruffio spaventoso — Alt! A questa parola tutti s’arrestano: il leone riparte il primo per la sua gabbia, la lionessa per la sua: le iene l’una appresso dell’altra, ciascheduna pel suo sportello, sgornberan la piazza: il leopardo scambietta di nuovo come un gatto, e d’un salto rientra ne’ suoi cancelli, lasciando solo quell’uomo più temerario che audace.
Ma la costanza, la pazienza e l’industria d’una volontà ostinata e gagliarda vince i più duri e tenaci ostacoli della natura. Nulla resiste al volere dell’uomo, se non l’uomo. Colui che trasnatura le ferine belve in agnelli col vigore della sua volontà, non è capace il più della volte di domare una sua passioncella, la quale da principio par dolce e mansueta, ma se non s’infrena a tempo diventa selvaggia e crudele tanto, che per niuno argomento s’ammansa e corregge, Quale affetto è più nobile e soave della compassione? Ma se si lascia travalicare i confini si volge a una tenerezza che confina coll’amore; ed ove amor metta l’ale nell’umano petto, lo impenna talora a voli che trasportano la ragione nel dominio della follia, e la trabalzano di mattezza in mattezza e di furore in furore.
Il primo affetto che surse nell’animo d’Edmondo verso la giovane trasteverina, che per salvare il fratello privossi del sollazzo autunnale della plebe romana, fu di compassione per la mestizia in ch’era caduta quella generosa, avvegnach’ella sentisse l’interno contento della buona azione. Alla compassione successe in Edmondo un sentimento d’ammirazione dì sì bell’atto, che gli infuse una certa cotal tenerezza, la quale avrebbelo condotto a premiare quella nobile sorella e farle gustare tutta la gioia della virtù. Coteste affezioni animate, accresciute, infiammate dalla fantasia trascinan l’animo, senza ch’egli se ne avvegga, nei lacci dell’amore, e ve lo stringono sì fattamente che vale più a districarsene, e più vi si dibatte per entro e più se li serra al piede.
La fantasia, che il proverbio, a giusta ragione, chiama la pazza di casa, ove le si allenti la cavezzina in sul collo trascorre all’impazzata per le regioni dell’intelletto e del cuore, e tramesta e travisa ogni cosa. L’occhio della mente non accoglie più la luce serena e chiara, ma vestita di tutti i colori onde la dipinge la fantasia, la quale ha inoltre la proprietà d’allucidare le scurità più tenebrose, d’intenebrare la luce più limpida e pura. Così la fantasia, quando occupa un infelice, gli dipinge il suicidio, ch’è sì orribile e sozzo in sè medesimo, a rosei colori, pieni d’una luce amorosa e d’un senso laudevole e sublime; e di questo lo pasce a lungo, e faglielo credere opera d’animo prode e gagliardo; laonde, uccidendosi per viltà si reputa d”averne gloria quasi trionfatore della vita. Così il perdonare l’offesa, ch’è atto sì magnanimo ed eccelso, la fantasia dipingelo per povertà di cuore, per bassezza e viltà: laonde chi si lascia condurre alla fantasia perde il senno, e per giunta giura d’esser sapiente.
Edmondo lasciò trariparsi dalla sua calda immaginazione nelle più matte risoluzioni che possano capire in umano cervello, e chi avesse ragionato con lui in que’ pazzi momenti, l’avrebbe udito commendarsene di saviezza. Imperocchè tanto gli s’inchiodò nella fantasia di voler conoscere la Trasteverina, che cominciò a passeggiare per quelle vie più volte al giorno per veder pure d’abbattersi in quella: ma non venendogli fatto, n’era oltre misura dolente. Svegliatosi una mattina più agitato che mai, s’alza in fretta, e va diritto in via de’ giupponari. In questa contrada, che move da san Carlo a Catinari e mette capo in Campo di Fiore, ha da ogni lato merciai d’ogni sorte robe da vestir popolani cominciando dai berretti lani a maglia de’ barcaiuoli del Tevere e de’ facchini di Ripa, sino ai borzacchini di cuoio a fibbie de’ cavallari di Maremma, che sono i due oggetti conservati ancora dai popoli latini del loro antico linguaggio; poichè il berretto che usano è il frigio, e i gambali ritraggono dagli stinieri de’ primi Pelasgi , come noi vediamo tuttavia dipinti in capo e in gamba di que’ remotissimi popoli sui vasi tirrenii.
Edmondo, cólte cotali sue ragioni di certi amici che gli aveano commesso un fornimento da caccia, entrò in uno di que’ fondachi, e misuratosi un farsettone colle tasche a carniera, e così a occhio squadrato un paio di calzoni di bordato, e un corpetto di carfagno, li ebbe comperati: passò da una calzettaia, e tolse quattro mute di calzette di coton mischio azzurro e bianco; e dalla merciaiuola vicina sei camicie di canapella coi bottoncini di osso: entrò a uno scarpaio, e trattosi i lucidi calzarmi di pelle ginevrina, mise il piede in due uose di vacchetta bulettate ai tacchi a tre giri, e dato ogni cosa a un garzonetto, recossele a casa, aggiuntovi un cappello alla carrettiera, che comperò in via de’ cappellai. Riposte quelle grossolane vesti attese la notte; indi vestitele, usci così camuffato e cominciò entrare nelle bettole di Trastevere , sperando pigliar lingua da rintracciarla.
Ogni paese ha le sue usanze, e ciò che recherebbe ammirazione in uno, è piena consuetudine in un altro. A Torino, a Roma, a Napoli i caffè son pieni di brigate d’uomini che vi passano la serata ragionando, cicalando, leggendo i giornali, nè ci vedrete una signora di rispetto; nelle città della Venezia invece ai caffè convengono le cittadine e le gentildonne a veglia coi mariti e colle figliuole, e vi fanno crocchi, e vi fanno la mostra le galanti, ne più né meno che nelle logge de’ teatri. Così nella Venezia voi non vedrete alle bettole e alle taverne alcuna donna onesta, ma vi s’accolgono soltanto i beoni e gli sviati. A Roma per converso, è usatissimo che le donne entrino a bere co’ mariti, co’ fratelli , e persino coi figliuoletti: e ciò a porte spalancate, e ognun passa, e vede, e non vi fa stato, siccome di costumanza popolare. Voi vedrete in un’osteria seduti a desco talora vent’uomini e trenta donne, e le madri vi conducono le pulzellette e insino a’ bambini, che si staccano dalla poppa per dar loro un goccetto di vino: il che i forastieri si recano a stomaco grandemente. Edmondo adunque, sapendo le usanze romane, voleva credere di trovar l’Annunziata seduta a qualche tavola colle amiche o colla famiglia. Vide molte donne e molte fanciulle; guardò, mirò, sbirciò; ma cotesto suo viso da ritrarne la Virginia romana non gli cadde sotto gli occhi : di che fu dispettoso sopra ogni dire. Uscì da una bettola ed entrò in un’altra: nulla. Venne a quelle taverne ove si bee e si mangia, vi trovò di molti ghiotti e di molte leccone che si trangugiano spesso in una sera il ritratto di una settimana, e il domani i figliuoletti domandan pane e non c’è, e mandano le figliuoline picchiare alle monache di san Cosimato, di santa Ruflìna, di sant’ Egidio, ov’ hanno una pappa e una fetta di pane: i garzoncelli poi vanno in busca di qualche tozzo dai frati di san Francesco a Ripa, de’ santi Quaranti o di san Pietro in Montorio, se pure non si mettono birboneggiando a involar fazzoletti pel Corso e per le chiese.
Edmondo, che nella sua follia avea pur ancora tanto di senno da giudicar certe cose pel verso, poniamo che fosse stizzito di non la trovare pe’ ridotti; n’ebbe infinito contento, riputandola oltre che di nobil cuore eziandio savia e dabbene. Fu allora che vedendo un giorno i pescivendoli ir colle ceste gridando per le vie di Trastevere, entrò nel pazzo avviso di mettersi a un deschetto in sul canto del vicolo della Luce, sperando che la venisse colle altre femmine a comperarne pel desinare o per la cena: perchè accontatosi con certi ranocchiari di Borgo Pio ebbe alcuni mazzi di ranocchie sbucciate, con seppie, calamai e granchietti di mare, cibo gradito alla plebe e di picciol costo.
Ma il granchio lo prese egli e sì grosso che non gli sarebbe entrato nel cappello: con ciò sia che il proverbio ne sutor ultra crepidam vaglia non solo per l’arti nobili, ma eziandio per qualsivoglia cosa che esca dalla propria condizione. I pescivendoli che corron gridando per le vie sono in tutte le città la bordaglia più scioperata e zotica dell’infimo popolaccio : gente senza mestiere, che si getta pei mercati a raccorre il rifiuto e gli avanci delle derrate per ispanderle negli angoli più remoti fra il popoletto a pochi quattrini. Costoro, che bazzican sempre in sulle bische e fra i mariuoli, non parlano il linguaggio comune, ma un gergaccio furbo che non s’intende che fra lor pari; sono sempre in sull’avviso di truffare i male avveduti; pronti per un grosso a tener mano a contrabbandi notturni, alle vendette, agli amorazzi e a qualunque pessima azione, purchè arraffino qualche grosseto. Hanno per lo più visaggi truculenti e vociaccie squarciate e roche: sempre scalzi, arruffati, sudici e cenciosi.
Ora pensate se Edmondo era uomo da mascherar sì fatto mestiere in faccia a un popolo sagace e baldo qual è il romano. Egli nato e allevato nobilmente non potea sì mentire la condizione sua che non ne risultasse una mostruosità fra il bizzarro e il ridicolo. Stavasi innanzi alla sua canestra, la quale in luogo di desco, era sostenuta da una vecchia sedia coricata, e non sapea neppur egli se dovea gridare alto — Chi vuol rane, chi vuol granchi? freschi freschi; vedete che danno ancora i tratti; venite; a due baiocchi il mazzo le rane; otto al baiocco i granchiolini; venite, comperate; coll’aglio e col prezzemolo e colla persa i granchi sono cosa ghiotta da leccarsi le dita: su chi li vuole? — Edmondo in quella vece stava musorno, colle braccia incrocicchiate, e a capo basso.
La prima che affrontollo fu un pezzo di garzona tant’alta, in ciabatte, coi capegli polverosi, con una treccietta del pendone che le ricascava per la guancia, colle mani tinte di turchiniccio per i’incannare dell’ ordito di quel colore; la quale tolto su un mazzo di dodici rane, disse — Quanto ne domandate, bel zitello? due baiocchi, rispose Edmondo — Viva l’abbondanza! ripigliò la beffarda: due baiocchi eh? Dite un po’, sor coso, le avete pescate sulla cupola di s. Pietro a farle pagar tanto? — Ve ne darò una dozzina e mezzo — Grazia vostra, per essere voi mi contenterò di venti — Pigliatele — e la tessitrice gli snocciola i due baiocchi, e via, che se ne corre allo stanzone dei telai ; gridando — Ragazze, o ragazze vedete questi due mazzi di ranocchie grasse e fresche: indovinate mo quanto io le ho pagate? — Si sa, risposero, sei baiocchi; tre baiocchi il mazzo è il suo prezzo ordinario ed anche tre e mezzo — Nòne nòne: due baiocchi tutte — Le saran fragide spente: io ne sento il fetore sin qui: uh che puzzo! Sentite, comare Agostina, che fiato di fogna? — Mi pare anco a me — Vi pare un fico, interruppe quella delle rane, non vedete che le guizzano ancora? — E come dunque le pagaste sì poco? — Chi lo sa? E’ c’ è laggiù un pesciaiuolo vestito a nuovo, il quale non è romanesco davvero: parla con una gorgia strana che mi sembra un calabrese, e si mangia le parole fra i denti.
— Che ci vengono a fare i calabresi in Trastevere? Ma se ne vendono a sì largo mercato, sieno anco turchi, non me ne cale. Oh voglio che fratelmo se ne faccia una panciata, che le ranocchie gli piacciono tanto: e il babbo le mangia pur volentieri anch’egli col tocchetto: zio Battista non se parla, e’ n’è goloso — Queste cose diceva una sgriccioletta di fanciulla, minuta minuta che la parea diafana, vispa come una pispola, e sempre balzellante come una cutrettola. Costei, preso il paniere de’ cannelli, corre a basso in peduli , e così discinta come stava al telaio si fa innanzi al pesciaiuolo, dicendo — Voglio sei mazzi di ranocchie, due baiocchi le ventiquattro, già s’intende — Gli è poco in fede mia, rispose il valentuomo — Oh che fede è la vostra, sor accidente? Le deste testò a comar Brigida, che la non sa dir le bugie. Ell’ha tre anni più di me, che n’ho diciotto ai vostri comandi, ed è una fanciulla dabbene, e pel vicolo del Drago delle Brigide ve n’ha una sola, vi so dire. La non aveva quindici anni ancora che Michelagnolo garzone del caffettiere alla scesa di ponte Sisto la voleva senza dota : ma siccome egli è un po’ paino, la Brigida gli fece le bocche e nol volle. Poi la n’ebbe delle richieste! Se la n’ebbe? fino a tre la si contendeano a un tempo, e una sera vennero alle brutte e ci fu sangue: anzi il burattaio del forno a quattro Capi penò allo spedale della Consolazione un mese a guarirne. Be’, sor tale, come vi chiamate? — Mastro Felice — Be’, mastro Felice , me li date li sei mazzi per tre baiocchi? —Pigliateli.
La parlantina mise le ranocchie nel paniere, e squadrato Edmondo da capo a piede, disse — O sor Felice, di che paese siete? — Son di lontano — Uh come si parla ne’ vostri posti! E perchè siete vestito da festa? menate moglie? — No — Il Bastraccone che suol venire colla cesta delle sarde, e grida tanto, gli è sempre scalzo e perde la camicia a brandelli, e voi siete bene in panni. Sie sie, la pigliate : ditelo a mène, ch’io son secreta, e come uno mi dice — Ceccarella, zitta vè — non c’è pericolo che m’esca di bocca il secreto; ho le labbra cucite. Ditemelo, sor Fe lice: e s’io lo conosco, il giorno della nozza verrò a farle la treccia. Chi è ella dunque?
Edmondo credette che gli fosse caduta la palla al balzo, e sperando che quella cicaletta lo mettesse in via di sapere nome, cognome, casa e uscio di colei ch’egli moria di conoscere, le rispose ciò che soltanto sapea di lei, dicendo: La sorella di Toto.
— Hiii ce ne’ de’ Toti in Trastevere un subisso ! e’ v’è Toto il lanaiuolo, Toto il maliscalco, Toto il fornaio, Toto il garzon dell’oste, Toto il carrettiere, Toto il figlio della zigariera. Se non volete che Toti, ce n’è da vendere. E Toto anche l’amante mio, e sta qui sopra alle mulina di san Pietro in Montorio: lesto come un daino e forte come un lione: i gabellieri del macinato tentarono più volte d’acchiapparlo col sacco in ispalla, quando vuol frodare la tassa del dazio. Sì, correte, l’aggiugnerete domani. Toto si dilegua loro dinanzi come un lampo. Oh addio, sor Felice.
Edmondo rimase lì come un zugo sulla gruccia, maladicendo in suo cuore le rane, le Brigide e le Ceccarelle; pure sperando che la sua non so quale capitasse al mercato, stava paziente aspettandola, e dal suo desco guatala quante s’abbatteano a passare. Ma la mingherlina ita su di corsa a’ telai fece un baccano di quel buon mercato, e tanto disse di mastro Felice, che tutte l’altre, cessato di pigiar le calcole e di serrar le casse, la stavano udire colla navetta in mano. Ma com’ebbe detto e cicalato assai, e fatto mille pronostici e indovinamenti di cotesta sorella di Toto, che dovea sposare mastro Felice; quasi tutte l’altre levatosi di sotto la panchetta, si rizzarono per iscendere al pesciaiuolo a fornirsi pel desinare.
Trovarono in vero che il pesce era freschissimo, e il mercato sì agevole ch’egli era proprio un comperare a macco: terminate le ranocchie, si venne a’ granchi, alle seppie, a’ calamai, e in men ch’io nol dico fu quasi vuotata la cesta. Ma non furono già vuotate le chiacchiere; imperocchè ciascuna avea la sua domanda a fare a mastro Felice — e donde siete? e come siete venuto a Roma? e dove tornate di casa? e quanti anni avete? e siete a padrone o vendete in vostro capo? quand’è che sposate? E la sposa è figlia di pescatori? è bianca, è rossa, è bruna? è ella romana o forestiera? de’ Monti o di Trastevere?
Intanto quelle femmine facean crocchietti e capanelli fra loro, tagliando i panni addosso al povero Edmondo, che si trovava impacciatissimo a rispondere. L’una ridea del suo modo di parlare, e diceva alle compagne: Costui parla come i Giudei; mastica le parole co’ denti, ha l’erre grasso e pare il gorgoglio d’una pentola di fagioli quando bollono — Ma proprio che sia un giudeo? soggiugneva un’altra; eppure non ha quel viso di sugna rancia, è ben vestito per pescivendolo: oh gua’, belle mani bianche ha egli! vedi, vedi, Lucia; vedi, Sabina, son elle mani da insudiciarsi coll’inchiostro che schizzan le seppie? Le son mani da guanti coteste.
Mentre le femmine cicalavano intorno a Edmondo, e già era accorso popoli per comperare, si ode il romore d’una carrozza che venia giù dalla Longaretta per volgere al ponte a quattro capi. Ell’era un carrozzone chiuso colla cassa color tanè, e fuori dallo sportello diritto le sventolava un zendado vermiglio: entrovi sedeano due frati Minori, l’uno colla stola, l’altro con un torcetto acceso — Ohe, gridò la Sabina, viene il Bambino d’Araceli — Davvero? O si, è proprio desso.
Lungo i fondachi, le botteghe, gli usci tutti accorrono, tutti s’inginocchiano, tutti si segnano; e s’ode un esclamare — oh santo Bambino, benediteci: oh santo Bambino, che tu sia benedetto! facci star sani; dacci buon lavoro; guarisci la figliuola mia; fa bassare il Tevere, che oggi è sì gonfio, e sta per traripare e innondarci lo stanze terrene — Le tessitrici inginocchiaronsi anch’ esse tutte intorno alla cesta d’Edmondo; e siccome in Roma le popolane (che vanno sempre in capegli) coll’entrare in chiesa si velano il capo, così alla veduta del santo Bambino, ciascuna si coprì col lembo del grembiule o col moccichino. Ognuna avea la sua grazia da domandare, ognuna faceasi il segno di croce.
Le più vicine a Edmondo, vedendo ch’ei non piegava le ginocchia, punzecchiavanlo del gomito alle gambe, accennandogli che s’inginocchiasse: un’altra lo tirò pel gherone del farsetto: ma egli da fiero protestante duro e fitto come un palo. Quando la carrozza torse per l’isola, tutte quelle femmine si rizzarono, e volta la divozione in ira furono colle pugna e coll’ugne al viso d’Edmondo, gridandogli in capo — Ah giudeaccio scontento, che ti possa pigliare un accidente: cosi eh? neanco al Bambino fai riverenza? Avei paura d’insudiciarti le ginocchia, brutto anticore — Non l’ho detto io, esclamò la Rosalba, ch’egli è un giudeo? Parla che ti conosca, dice il proverbio, e il linguaggio tuo è da ghetto.
— Io non sono ebreo, disse Edmondo a una che gli stava sotto il mento — Non sei ebreo? Tu pronunzi l’erre come se tu avessi la manna in bocca: sìne sìne che sei giudeo, e non so a ch’io mi tenga che con tutte queste buone cristiane non ti leviamo su di peso e ti gettiamo a fiume a capo di sotto per battezzarti — Mentre costei gridava, eccoti una torsolata che picchia diritto in fronte a Edmondo, e appresso quella un pomodoro fracido, e una scorza d’arancio gittatagli dai monelli.
Edmondo non dice: chi m’ha dato; ma visto la brutta parata, chinossi, e rotto co’ gomiti il cerchio di quelle femmine, la diede a furia di traghetto in traghetto sinchè riusci laggiù a ponte rotto; passato il quale, e messosi per la via della Bufala, fuggì là pei dintorni di Campo Vaccino. Quel po’ di granchi e di calamai, ch’erano rimasti nella cesta, la quale nell’urto s’era arrovesciata, andarono alla ruffa alla raffa de’ marioletti, che aveano cominciato l’assalto de’ torsi e l’avrebbono terminato a selciate. Gli schiamazzi delle donne, gli urli de’ garzoni, il correre de’ curiosi, formavano un patassio, un chiasso, un guazzabuglio, un frastuono del finimondo — Che è stato? che è? — Un giudeo travestito — Come un giudeo? — Si ci venne da ranocchiaro, e il truffatore ce le vendeva per nulla — Saranno avvelenate — Davvero? eh io non le mangio di certo — Fra quell’abbaruffio giugne mastro Egidio, ch’è il Salomone della Longaretta, e inteso tanto che basta per cavarne il netto, procurò di rimandare le donne al telaio, diè quattro scapezzoni ai birboncelli, e poi cogli uomini del vicinato fattosi sulla bottega del pizzicheruolo, cominciò a ragionare con loro. Mastro Egidio è uomo attempato, e fu per oltre quarant’anni il fontanaio dell’acqua Paola sopra san Pietro in Montorio: usava ancora il calzon corto, la camiciuola senza falde, la fascia turchina e le fibbie al centurino e alle scarpe. Avea due basettoni bianchi come la neve che gli scendeano sin verso il mento , e andava per lo più in berretto col fiocco paonazzo, e colle due catenelle degli oriuoli, che usciangli dai taschetti della traversa de’ calzoni. Egli ricordava ancora la cattura di Pio VI, era venuto spesso alle mani coi giacobini a’ tempi di Pio VII, e nelle buglie del 31 all’elezione di Papa Gregorio XVI, conduceva le squadre dei Trasteverini per fare alle archibugiate coi Carbonari sediziosi che cominciarono i moti di Roma. Egli avea tanta fede nel Papa, che avendolo scorto un giorno che usciva in carrozza, corse colla sua banda per assicurarlo che non temesse, perchè Trastevere era per lui: onde salito sullo staffone e fattosi allo sportello, disse — Padre Santo, non abbiate paura, che siamo qui noi — Il Papa, datogli con due dita per carezza in sulla gota, disse — Trastevere è sempre fedele — Padre Santo, ripigliò Egidio, dove m’avete toccato con quella man benedetta non mi lavo più sino a Pasqua. — Di che il Papa sorrise e licenziollo. Del 48 ebbe soventi guai co’ repubblicani , perchè brigavansi di corromper l’animo de’ Trasteverini attizzandoli contro il Papa ed il clero, e più volte tolse loro delle granfie qualche male arrivato, che volean traviare.
Come adunque Egidio fu sulla bottega, disse alla brigata: Fratelli, non crediate che colui in veste di popolano fosse giudeo, che niuno del ghetto a’ giorni nostri farebbe di queste celie; ma’ dee essere qualche Mazziniano mascherato, il quale cerca di traforarsi in Trastevere per trascinare ne’ loro nefandi lacci alcun scioperato di quelli, che non vogliono guadagnarsi il pane onestamente coll’opera delle sue mani, ma vorrebbono passare di taverna in taverna e di gozzoviglia in gozzoviglia; vadane l’anima e il corpo.
— I Mazziniani ebbero le mela a san Pancrazio, disse un carrettiere, e oggi non se ne parla più. — E io ti dico mastro Pompilio, che ce n’ha più che non credi, e proverottelo. Ti ricorda quella sera all’osteria del Sole quel finto fornaciaio… che con mastro Luciano… E qui a mastro Egidio venne da starnutare.
PIPPETTO SQUARCIA
— Prosit, mastro Egidio, dissero tutti allo starnuto; il cìel vi guardi e vi dia bene — Grazie, rispose Egidio; indi ripigliò — Ti ricorda, Pompilio, quel finto fornaciaio che disputava con Luciano nostro, e volea cosi bel bello condurlo a dire; che la repubblica del 49 valea dieci tanti Io stato presente, perchè il popolo ne stava meglio? Luciano, ch’è un cotale omaccio sgovernato e che vive a caso, e a que’ giorni avea buscato da que’ galuppi qualche viglietto da cinque scudi, era in sul rispondere — che sì’ bene — quand’io rottogli la parola fra’ denti , e voltomi alla ma schera, gli dissi —’ Sor minchione, per chi ci avete pigliati? per bigonci? Il bigoncio siate voi, che vi credete di ciurmarci con tanta agevolezza. Voi vi spacciate per un trasteverino a meglio ingannarci, ma voi siete di Trastevere come io sono di Campo Marzo. La vostra non è pronunzia di qua da ponte, e affastellate troppi proverbi che avete imparati sul Meo Patacca, sulle canzone dei lunarii e sulle tragedie di Pippo Tacconi, che si recitano al teatro delle muse in via del Fico. Capite, sor voi? Circa poi le beatitudini della repubblica, ve le godrete voi, che non avete nè foco nè loco, e vivete delle cinque dita (e qui mastro Egidio le girò a ventaglio); ma chi ha il timor di Dio, e un mestiere da dare un boccon di pane alla sua famiglia non vuol campare di roba rubata.
Allora colui ebbe tanta fronte da dirmi — Roba rubata! egli è sangue nostro — Sì, rispos’io, sangue nostro, dicesti una verità santa. Sangue nostro di certo. I repubblicani in pochi mesi stamparono parecchi milioni di carta e la faceano spendere per scudi sonanti. Ora tutti quei milioni rimasero a debito dello Stato, cioè a debito nostro; e a tante gocce del nostro sangue ci conviene pur di pagarli. Voi davate carta, e a noi ci convien dare argento.
— Se i preti, soggiunse l’impostore, amavano il popolo, doveano dichiararsi falliti, e allora il popolo non rimanea gravato — Questo è un pagare alla repubblicana, diss’io, e al modo di Pulcinella che paga i creditori a suono di randello. E poi tutti quei milioni di carta non eran forse sparti fra il popolo? Se il Governo si fosse dato per fallito, quel fallimento ricadeva sul popolo — No, gridò l’altro, anzi ricadea sui signori — E i signori non son popolo, soggiuns’io? E se per popolo intendi soltanto gli artigiani, chi dovea poi ripagare i signori di quel danno? Noi poveretti col toglierci i lavori, col farci pagare il doppio le derrate, col riempire d’altri fallimenti migliaia di mercatanti in tutte le città dello Stato, i quali traggono seco per mille guise il popolo. Meglio è adunque pagare il debito a poco a poco, che soffrir danni più intollerabili.
Vedi adunque, sorbaccello, beatitudine della repubblica! Più durava, e più il debito sarebbe cresciuto, e più noi avremmo dovuto pagare. Aggiugni tutto lo spogliamento dei tesori delle chiese, degli ori e degli argenti de’ principi e de’ cittadini, ai quali sarebbero venuti i repubblicani, e già avean cominciato per bene: indi alle confische, agli incendii, agli esilii, alle stragi. Eh, repubblicano mio, che delizie! che dolcitudini! che cuccagna! Così gli diss’io; e il finto trasteverino credette prudente di rizzarsi e andarsene pe’ fatti suoi.
Ma di cotesti infingitori non è sbarbicata l’iniqua progenie: perocchè i Mazziniani sperano sempre di ripullulare, e venire al macello, come dicon essi, e si sa di chi: però hanno bisogno di braccia e s’ingegnano e studiano e con tendono per ogni perfido modo aver compagni ed aiuti nel popolo. Indi mandano loro cagnotti per la Regola, pe’ Monti e per Trastevere, i quali entrino ne’ ridotti in sembiante di popolani a uccellare a tordi; e pur troppo ne dà loro nella rete più d’uno, e te lo accarezzano, e allettano col pagargli il fiasco, il zigaro, la merenda, e col lasciargli cadere in mano qualche paolo. E la cosa rimanesse costì; ma tirano a guastare le nostre donne mettendo loro in uggia e dispetto i parrochi e i preti. Si servono a questa malefica impresa de’ lavoratori di panni , e d’altri lavori donneschi: e quando le nostre mogli o le nostre figliuole vanno per la trama o per l’ordito dicon loro — Che aria di pizzocca ! come puzzate di confessionale! Balorda: non sapete che i preti e i frati dicono tutte le vostre marachelle al marito? E alle fanciulle dicono — Povera ragazza vi compatisco; ma che andate a fare a quelle grate? Le grate sono invenzione di chi vuol sapere i fatti vostri per dirli poi a mamma.
Gli è vero che le nostre fanciulle san bene la dottrina cristiana, e non danno retta a quelle ribalterie, e saprebbono ricacciar loro le parole in gola; ma le poverette si tacciono per la migliore; poichè quei cani rinnegati son capaci d’appor loro una calunnia di ladre presso i principali, e far sì che le non abbiano più lavoro. Costoro s’avvolgono fra le crestaie, fra le sartorelle e rizzan cattedra d’errore e d’empietà per tirarle a maladire i sacerdoti, e allontanarle dalle chiese. Sicchè per conchiudere, credete a me, il finto ranocchiaro dovett’essere qualche gaglioffo mazziniano, che venia per tirare l’aiuolo a qualche nostra femmina o a qualche male arrivato.
— S’egli è per cotesto, disse Pippetto, la m’é toccata anco a me pure, e se la Madonna della porticciuola di santa Cecilia non m’aiutava, ero bello e concio per le feste.
Pippetto è un muratore, piccìoletto della persona, secco, bruno, d’occhi vivi e trafiggenti, tutto muscoli e nervi, che gli risaltano alle giunture, alle braccia e alle dita delle mani come al famoso Discobulo di casa Massimi. Buono, ma subito, audace; e temuto per la sua bravura. Costui trovavasi una domenica d’ottobre, caduto già il sole, in una osteria, soletto e tutto ne’ suoi pensieri, perocchè il giorno innanzi la sua fidanzata gli avea fatto un po’ ceffo per gelosia; quand’ecco entrare sette giovani cozzoni di ca valli, e sedere a un tavolone di rimpetto al suo. Fanno venire i fiaschi, e mesciuto largamente, si misero in sul berteggiare. Pippetto bevea il suo Velletri a centellini, e pensava i modi di rifare la pace; perchè alzando a caso gli occhi, gli parve che coloro là lo sbirciassero con un’aria beffarda e parlottassero così fra’ denti non so che per uccellarlo.
Stavasi egli col gomito sinistro sulla tavola appoggiando la gota al dosso della mano, e colla diritta reggea il bicchiere a mezz’aria. Come s’avvidero che Pippetto li guardava, uno, ch’era già bene avvinazzato gli fece linguetta; e un altro gli rise in bocca; e un terzo fatto cerchio del pollice e dell’indice, il traguardava come per cannocchiale. A que’ tratti Pippo depose il bicchiere, e voltosi agli scher nitori, disse — Giovinotti, noi non abbiamo nulla a partire insieme, deh siamo amici — Allora colui ch’era in capo della tavola si leva bieco e vien diritto per affrontarlo con un coltello alla mano, Pippetto balza in piedi, appoggia la mano manca sull’angolo del tavolone, trae di tasca un pugnalotto aguzzo, e mentre l’avversario fa l’ultimo passo gliel ficca nelle coste e rovescialo in terra.
Di là s’alza un grido — Ah cane — e si gittan fuori per iscagliarsegli addosso: ma Pippetto, sempre fermo in sul canto, mena al primo e al secondo, e giù. Il terzo era un giovinetto di diciassett’anni, e perchè volea saltargli da lato, Pippo gli sbiescia un traverso e lo sventra ; tirando poscia puntone a quello che lo investiva di fronte. Gli altri due impacciati fra i caduti si lanciano per trucidarlo; ma colui, guizzando quel suo pugnaluzzo come una lingua di basilisco, gli ebbe còlti tutti due nell’anguinaia. Cosa inaudita! sette stramazzati da un solo, senza pur averne una scalfittura!
Pippetto visto que’ sette sforacchiati e giacenti, spicca un salto alla porta, e fugge ratto come un levriere pe’ vicoli e pe’ chiassuoli fuor di mano, sinchè sbucò pel Macello de’ corvi in piazza Traiana. Egli avea una sorella accasata da san Gian Laterano presso gli acquedotti della Scala santa; perchè messosi alla volta del Colosseo pervenne in sull’imbrunire alla detta sorella. Com’essa lo vide sì alterato nel viso disse tutta tremante — Pippetto mio, ch’è stato? Ètti egli incólto male? Tu se’ del color di cenere — Nulla nulla; ti dico che non è nulla. Giacinta, dammi le tue vesti — Che ne vuo’ tu fare? Oh Dio! qualche gran disgrazia t’è sopraggiunto: Madonna santissima, aiutaci tu — Zitto, per carità Giacinta mia! se no siamo perduti. All’osteria del granchio senza ch’io ne dessi nè cagione, nè izza, nè fiato, fui assalito di coltello da sette briachi , ed io proprio per miracolo della Vergine di santa Cecilia, con questa puntellina difesi la vita mia e li sbellicai tutti sette, e me ne corsi a te sano e salvo.
Allorchè Giacinta intese quella tregenda, si ficcò le mani ne’ capelli gridando — Gesù Nazareno, salvami Pippetto mio! Ah che vengono a carcerarlo! — Ma vuoi star zitta? disse Pippo; e le corse colla mano alla bocca. Dammi il tuo gamuirino e la sottanella, non è tempo da piagnistei : animo, lesta — E la Giacinta singhiottendo e lacrimando s’avvia al cassettone, e mentre Pippetto si svestiva, ne trae i panni e glieli acconcia addosso, facendo con due camicie del marito i fìanchetti alla veste, e raffazzonandogli sulle spalle uno scialetto. Gli mise in capo una sua pezzuola di seta, che gli annodò al mento per coprire la barba del soggólo, e tagliatesi sotto la treccia due ciocchette di capelli e arricciatele un poco, gliele appuntò colle forcine sotto la pezzuola verso le tempie.
Cosi camuffato, fece de’ suoi panni un fardello che consegnò alla sorella, e presala sotto il braccio, uscirono da porta s. Giovanni, volgendo verso le fosse a diritta. Era già notte buia; laonde quando furono presso alla porta Latina, Pippetto spogliossi delle vesti donnesche e rimessosi ne’ suoi panni,, prese commiato dalla Giacinta, la quale stretta dalla paura di scoprire il fratello non pianse; e trista e dolente rientrò in Roma e si ridusse a casa.
Intanto Pippo gittossi alle macchie d’Ostia, e accontatosi coi Norcini, che vivono colà nei capannoni per la caccia dei cignali, stette con loro. Se non che il popolano di Roma ove non vegga la cupola di s. Pietro, si tiene smarrito, e gli entra una febbre addosso che lo sprona ad ogni rischio per rivederla : e sopra ciò egli è sì incarnato nelle sue usanze romanesche, che per lui sono un altro elemento, e gli pare di non poter viver s’egli non vi guazza dentro. Or dunque avvenne, coll’andare dei giorni, che s’approssimavano le feste del Natale del Signore, e Pippetto cominciò a struggersi dentro per la voglia di goderle ; e ciò che non potè in lui la brama di rivedere l’amante sua, fu d’acutissimo stimolo il pensiero del cenone della vigilia.
I suoi novelli compagni veggendolo divenuto sì melanconico e taciturno, gli diceano — Pippetto, che hai? Sì la nostra è una vita dura; sempre in fra le macchie, sempre lungo le fosse, pe’ cannicci dei paduli e per le felci de’ maresi, alla guazza, alla brina, alle pioggie ed al sole in caccia de’ cignali, de’ cavrioli e delle beccacce; ma tornati alla capanna ci asciughiamo e riscaldiamo a un buon fuoco, ci mangiamo gli arnioni de’ cignali sulla graticola col pepe e colla persa, e si vuotano di buon fiaschi: sono soventi le brigate de’ cacciatori romani che ci vengono visitare, recandoci qualche buon gallinaccio e cacio cavallo e salciccie, che ceniamo col più solenne appetito. Amico, vuoi di più? che ci manca?
— Voi dite pur bene, riprese Pippetto, ma allora ch’io penso ch’indi a sei giorni è la vigilia di Natale, io non ci reggo: sento una smania addosso che mi magna vivo: io faceva il cenone con mia sorella Giacinta, e il cognato mio: vi venia mamma, sorima e fratelmo: v’era sempre compar Angelo, compar Silvestro con mastro Ermenegildo e sua moglie. Il pesce lo comperavo io, e ciascuno pagava la sua quota: sei libbre di capitone grosso come il mio braccio: otto di triglie, quattro di polipetti a guazzetto: il piatto di maccheroni colle alici fritte, col timo e col basilico pesto apriva la cena: fiaschi che dio tel dica, e l’Orvieto era l’ultimo: infine Cartoccio, il caffettiere della piazza di san Giovanni, venia col caffè, col rhum e colle ciambelline croccanti. Quando si tornava a casa, passando sotto l’obelisco, pareva che l’obelisco tentennasse come la campana di Monte Citorio. Vuo’ dire, ch’era il nostro cervello che grillava un tantino. E io qui ora sotto questo tettacelo di strame, su queste panche zoppe, a questo fuoco aggirato di sassi, fra questo fumo che mi soffoca il respiro* in gola, mi venga un…. quasi ch’io nol dissi, s’io la posso durare.
Il giorno 23 dicembre Pippetto disse ai Norcini ch’era di mala voglia e volea dormire: onde i cacciatori uscirono coi cani al cignale, e lasciaronlo coricato nella sua coccetta. Tornati, posto già il sole, non trovaronlo nella capanna, e credettero ch’egli fosse ito alla pozza per attendervi le beccacce che scendeano a bere. Giunse la notte, e nol videro capitare. Che sarà? disse uno — Se vi ricorda fu invitato dai bufalari di Fiumicino a mangiare le ova di bufala, e saravvisi condotto per torsi la mattana di dosso, tanto il travaglia da qualche giorni l’assillo di rivedere Ponte Sisto. Che volete? Cotesti Romani son fatti così: Roma Capamunni.
La notte del 24 dicembre , mentre Giacinta cuoceva i maccheroni, e già erano in casa la madre e la sorella Cecilia e due altri amici, s’ode picchiare all’uscio di via. Giacinta si fa alla finestra della cucina e dice — Chi è? — Apri, Giacinta — dice una mezza voce. Giacinta sente un guizzo al cuore; tira il saliscendi: esce col lume a capo la scala, vede uno che sale a tre scaglioni alla volta, lo ravvisa, e grida — Ah, Pippetto mio! — Iss. . . chétati — La Giacinta diede in un sudore che le filava giù per la fronte a goccioloni. Pippo entra in cucina e si getta sopra una sedia, e la sorella col lume in mano stava lì trasognata mirandol fiso — Chi v’è a cena? disse Pippetto — I soliti — Ben, di’ loro (ma col dito alla bocca vè) ch’io son venuto a cenare con essi — La sorella entra nel salotto, e ansando narra del nuovo ospite. La Cecilia era in grotta pel vino, e salita in cucina, vede Pippetto: fa un trasalto, che poco andò che non le cadesse il fiasco di mano, e posatolo appena sulla tavola, salta al collo del fratello, e senza poter dire parola lo baciava e bagnava di pianto. Entra la madre , e abbraccia tutti due e fa un gruppo serrato , e colla bocca all’orecchio gli grida soffocata — Ah figlio mio! — In quello entran gli uomini, e come possono gli levan del collo le donne, e mettono loro le mani alla bocca, dicendo — Se voi strillate ci va la vita nostra: calmatevi, avremo tempo di sfogarci — In frattanto il marito di Giacinta va a chiudere tutti gli sportelli delle finestre; e venuta l’ora della cena, si mettono a tavola.
Tutti guardavan Pippetto, tutti lo domandavano — Ma come ti salvasti? Ove fosti? Che vita fu la tua? Come ci se’ venuto? Bravo, bene, tu sei vero Romano, e non volesti mancare al cenone. Qui tuo cognato ci comperò il pesce tanto fresco e tanto saporito, che non l’ha migliore stassera il principe Borghese. Su, mangia, Pippetto, che nelle macchie d’Ostia più che rane non c’è — Pippetto, così stracco e scalmato com’era, si diluviava i maccheroni, e rispondea fra una forchettata e l’altra, e spesso, avendo la bocca piena, accennava col capo, cogli occhi, colla mano e tranguggiava. Vennero le triglie impanate ; vennero i polipetti in tacchetto, e per ultimo eccoti al capitone.
Mentre Pippetto trinciava il suo rocchio, il cognato gli narrava siccome i sette feriti da lui erano in perfetta guarigione, eccetto il più giovane quello che perdea le intestina, il quale morì entro due giorni di cancrena: e contavano tutto il tafferuglio che ne fecero i parenti loro e delle visite della Corte che avea spesso la madre sì di giorno e si di notte, sperando sempre di coglierlo in casa; di che la Cecilia avea preso una notte tanto spavento, che l’assalì una febbre violenta e penò da un mese , a guarirne. Che per ultimo la giustizia cessò le visite, perocchè l’oste del granchio e il garzone, chiamati parecchie volte in giudizio, aveano sempre testificato con giuramento: che Pippetto non gli avea provocati, e non fece in tutto che difender la vita sua.
Pippetto rispondeva — Cognato mio , va da Monsignor Fiscale, e chiedigli in grazia il salvocondotto, acciò ch’io possa difendermi a piè libero; e spero coll’aiuto di Maria Vergine della porticciuola di santa Cecilia , e della mia buona ragione d’ uscirne libero e franco — La preghi la Madonna? — disse la madre — Si, rispose Pippetto, ogni giorno le dico le tre Ave Maria, che m’ avete insegnato voi da piccino, e non le ho lasciate mai, se non oggi, che aveva il capo al cenone e al piacere di rivedervi. Ma sinchè non abbia il salvocondotto, non sono sì pecora da lasciarmi cogliere dalla giustizia, perchè dice il proverbio: Nè per torto nè per ragione non ti lasciar mettere in prigione; e stanotte stesso io la levo di qui e torno a’ miei covigli.
— Chi vuo’ che lo sappia? disse la Giacinta; deh non ci lasciare sì presto: riposati un paio di giorni, e poi coi miei panni, come l’altra volta, usciremo, che l’aria stessa non se ne accorgerà.
— Intanto mangiamo, rispose Pippetto : appresso poi piglieremo consiglio. Ma sai che questo capitone è come un pezzo di butirro che si disfà in bocca? e come saporoso! e come dilicato! e come stagionato a dovere! Bravissima, la mia Giacinta, oh per cuoca e’ non c’è l’eguale in tutte le minenti di Roma , e sì dicendo Pippetto tenea la forchetta levata, e stava per dar di morso al suo arrosto.
Tic e toc — Oh Dio chi sarà? dissero le donne. Tic e toc. Martino balza alla finestra, e chiama ,— Chi è la? — La Giustizia — risponde una voce gagliarda — aprite subito; e Martino vide tutta la casa circondata d’armati. Pippetto si lascia cadere il suo rocchio sul piatto ; guizza in piè, piglia il cappello , se lo calca in capo ; si scaglia in cucina; apre la finestra che risponde sugli orti; spicca un salto; dà un rivoltone per terra; si rialza e via per le vigne de’ Massimi. Trovato il muro, vi s’arrampica come un gatto, e salta giù nel viottolone che riesce a Porta Maggiore.
Pippetto per mala sorte era stato incontrato lungo le mura di s. Sebastiano da un parente di quei feriti , il quale venia correndo in un suo biroccio; e sebbene fosse già presso a sera, lo riconobbe: perchè fatto le viste di continuare suo viaggio, quando fu a un po’ di largo, volse il cavallo, e venia seguendolo dalla lunga per vedere se fatto gli venisse di spiare ov’egli tornava quella notte alla cena della vigilia. Vistolo entrare da porta s. Giovanni, affrettò; e il tenne d’occhio sinchè lo vide picchiare alla casa della sorella, e disse fra sè: il sorcio è nella trappola.
Alla prima stazione de’ carabinieri chiese del Brigadiere; gli narrò l’avvenuto; indicogli l’abitazione della sorella, e andò pe’ fatti suoi. Fu dato avviso a Montecitorio, spiccato il mandato d’arresto, assegnatogli una forte mano d’armati; e il Brigadiere li condusse al luogo. Ma siccome sapeva che Pippetto era un lesto fante, e gli sarebbe smucciato di mano come un’ anguilla , così mandò suoi uomini agli sbocchi delle vigne: laonde non sì tosto egli calò dal muro e fece alcuni passi, ed ecco intoppò ne’ soldati, che ammanettaronlo e condussero alle carceri nove. Ivi stette buona pezza in secreta, e menato in tribunale all’interrogatorio, non volle avvocato, e si difese tanto bravamente, e avvocò la sua causa con sì calzanti e poderose ragioni provando, ch’egli combattea per la vita sua contro un assalimento ingiusto e feroce che fu da’ giudici dichiarato innocente, e come tale assoluto. Prima però di tornare a casa volle ritirarsi a fare una buona muta d’esercizii spirituali d’otto giorni a’ s. Giovanni e Paolo dai padri Passionisti; perocchè nel fondo egli era poi un buon diavolaccio.
Questa è la storia di Pippetto, il quale sulla bottega del pizzicheruolo della Longaretta ragionava con mastro Egidio e col resto della brigata , adunatasi dopo la fuga del ranocchiaro.
— Ebbene, disse un de’ compagni, che voleano dunque da te quegli scontenti Mazziniani?
— Ora tel dico. Per quella braveria ch’avea fatto al granchio di que’ sette. . . già ne ricordate la storia, per la quale son chiamato per soprannome Pippetto Squarcia, i Mazziniani aveano fatto assegnamento sulle mani mie. Un sabbato sera che piovea forte, e la gente poco girava , io che in tutta la settimana non avea beuto un bicchier di vino; com’ebbi recevuto un po’ di moneta, volli rifocillarmi d’un mezzo fiasco ed entrai all’oste sotto l’arco de’Tolomei. Ivi, eran due in grembiale di cuoio a uso di maliscalchi , che pareano della mascalcia del Mascherone dietro al palazzo Farnese; ma eran tutt’ altro. Costoro vistomi appena entrare, dissero: Oh Squarcia, la buona sera a te: Dio ti dia bene. Garzone, un altro fiasco.
Io ringraziarli; ed essi fattimisi accosto, e presomi in mezzo a loro , dissero — Come te la passi? — Male a quattrini, risposi — E chi ne sta bene, Squarcia? I preti, i principi, i signori, i mercanti di campagna, i quali tutti affogan nell’oro, e ci fanno rincarare il pane ogni giorno. E noi? Noi a litigare il desinare colla cena, lavorando, anfanando, dirompendoci tutto il giorno per buscare pochi paoli rognosi : il fornaio non ci vuol dar più pane perchè è scaduto il mese: il calzolaio, il sarto, il friggitore hanno ad avere; la pigione di casa ci si moltiplica addosso, e l’esattore minaccia continuo di gettarci i nostri poveri cenci per la via , e ci conviene scasare o impegnare al monte sino al materasso e i cavalletti del letto. Ti par egli vita da cristiani cotesta? I signori invece a scialare, a godere, a sollazzar tutto il giorno senza far nulla: ell’è ora oggimai di finirla.
— Oh s’egli è per codesto, diss’io, il povero non uscirà mai di cenci.
— E io ti dico, che l’ora è sonata: noi ne’ palazzi e i signori ne’ tugurii : noi in carrozza ed essi a piedi : noi buona tavola ed essi pan di cruschello. Basta che abbiamo braccio fermo e cuor di leone. Senti amico : il coltello tu sai menarlo in brocco, e l’animo tuo non è di coniglio; sei Romano e basta.
— Io non v’intendo.
— Squarcia, tutto è ordinato : la mattina del 15 agosto s’ ha a menare le mani: da Genova ci giunsero otto bravi forusciti che saranno alla testa delle quadriglie; il capitano che ci guiderà è già in Roma; piomberemo loro addosso all’impensata in santa Maria Maggiore al Pontificale; corso quel primo sangue, ci avventeremo ne’ palazzi e ne’ monasteri : oh , Squarcia , la miseria non la vedremo più in viso. Intanto eccoti venti paoli; tu fa di trovarti ogni sera alla scalinata della barcaccia, ove troverai chi t’indetterà appuntino di quanto avrai a fare: sino al dì del macello ti correranno due paoli al giorno.
Io (che prima di venire all’oste per quella foglietta, era stato alla Madonna della porticciuola di santa Cecilia, ove Dio grazia vo tutte le sere dopo l’opera, sin da quand’era manovaletto di mastro Settimio) all’udire quella infernale proposta rimasi sbigottito; ma siccome son uomo esperto, senza punto mutar colore, risposi a viso fermo — Egli è vero che ho il braccio gagliardo e il cuor romano contro chi attenta alla vita mia ; ma appunto perchè son Romano abborro le azioni dell’assassinio. L’assalire improvviso una brigata di inermi è da vile, il farlo poi in chiesa, a piè dei santi altari è da sacrilego e rinnegato. Pigliatevi il Vostro danaro, ch’io non vendo la mia coscienza a nessuno , e chi la volesse con Pippetto Squarcia si faccia avanti. Presi il mio cappello e me n’andai a casa.
Ne volete udir una? La mattina del 15 agosto, festa di Maria Assunta in cielo, ch’ero già stato alla prima messa a s. Grisogono, me ne andava verso le cinque oltre ponte dal mio capo mastro, e veggo una man di carabinieri in cima alla contrada e un’altra in fondo con una carrozza ferma innanzi a una porta. Dissi fra me — Sì di buon’ora carabinieri! carrozze! hum! questo è un capiatur di certo — e facendo lo sbadato mi ritirai nel portone d’un palazzo. Non vanno dieci minuti, ed ecco uscire un Brigadiere con due merlotti vestiti da signori con eleganza, pallidi, muti, a capo basso, e li fa salire in carrozza, ov’entra anch’egli, e gli altri armati la circondano accompagnandola a s. Michele. Il credereste? eran proprio que’ due vestiti da maniscalchi, i quali bazzicavano per le osterie di Trastevere a guastare i nostri popolani e tirarli nelle congiure. Ma la Madonna ci ha pensato lei: perocchè appunto nella notte fra il 14 e il 15 fu scoperta quella congiuraccia, e n’acchiapparono in letto più di trenta. Eh che grugni da volere ammazzar tutta Roma.
Ma egli è da tornare al povero ranocchiaro. Intanto Edmondo preso a torsolate dai monelli della Longaretta, trovandosi in quel vestito nel campo Vaccino, e vergognandosi di tornare a casa, passando per le vie più frequentate di Roma, ov’era conosciuto da tanti, riparossi in casa di un suo paesano, che abitava dietro il tempio della Pace, e vi teneva rimessa di carrozze che noleggiava ai forestieri. Questi in patria era stato già cocchiere di suo padre; e messosi poi per corriere d’una ricca famiglia che viaggiava l’Europa, avea fatto un po’ di borsa e fermatosi in Roma. Com’egli si vide venir innanzi in quell’arnese il figlio del suo antico padrone — Eccellenza, gli disse, che vuol dire quell’abito? Ha ella commesso qualche ferimento in duello e fugge così travestito? La posso aiutare a trafugarsi?
— No, Alfredo, gli rispose, non ho nè ammazzato, né ferito persona; ma sono entrato in una smania crudele di conoscere una giovane trasteverina che m’ha ferito la fantasia.
Alfredo si strinse nelle spalle, dicendo, fra sè — I signori pel buon tempo soverchio e per l’ozio che li divora impazzano o fanno impazzare altrui: anche suo padre n’ha fatte delle belle a’ suoi tempi, e io fui spesso per lui a un pelo di scavezzarmi il collo — Indi riscossosi e guardatolo in viso con aria di compassione — Eccellenza, gli soggiunse, che va ella cercare in Trastevere, ciò ch’ella potrebbe avere assai meglio per tutto altrove? Colà non c’è che popoletto, e là non potrebbe trovare che qualche lanaiuola dell’opifizio di s. Michele, unta e bisunta che pute di morchia e di grassume; o qualche tessitrice che sa di bogima e di lezzo. E poi, signor mio, la non creda mica di poter uccellare in Trastevere alle pernici; ella incapperà ne’ proprii lacci, o le scoccheranno al piede le sue tagliuole, e buono se la ci riuscirà colla pelle intera.
— T’inganni, Alfredo, se tu presumi ch’io abbia torti intendimenti: qui non si tratta che d’una virtuosissima giovane ch’io mi muoio di conoscere e d’onorare: io vo’ solo vederla, sapere ove la torna di casa, e farle, ora ch’è per isposare, un po’ di dote in premio della sua virtù.
— La faccia a mo’ d’un pazzo, signor Edmondo: la non s’impacci in questi partiti che le tornerà buono. Il popolo romano è sdegnoso e superbo, e nulla che la cogliessero mascherato in quest’abito, io non vorrei essere sotto la sua camicia davvero.
— Io t’ho inteso: tu non mi vuoi aiutare, te ne ringrazio.
— La non dica così, che la mi fa torto, e nol merito punto; ella mi dica il nome della giovane, e qual cosa si farà.
— Io nol saprei dire; so ch’ell’è della parrocchia della Luce: l’ho intesa a nominare di fretta, e ho perduto il nome, nè l’ho voluto richiedere per non dare sospetto di me. Ell’ha un fratello e un amante, che si ferirono in sui furori del gioco, ma si perdonaron l’un l’altro e la cosa non andò in tribunale.
— Se la è cosi non ne verremo a capo: se la querela fosse ita in corte l’avremmo saputo questa sera, o domani al più lungo; ma cotesti Romani, se le ferite non sono gravi le si curano in casa chiotti chiotti; e guariti che sono, affogano insieme i risentimenti in un paio di fiaschi e turansi la bocca con un piatto di maccheroni e un arnione di capretto. Anzi, se non erano, divengono d’allora innanzi amici più che mai; e talvolta occorre che celiano insieme, dicendo: Eh mi tiravi al collo, compare, ma io ti guizzai sotto, e mi cogliesti alla spalla: era un bel colpo, sai? l’entrò due buone dita e mezzo; ma ell’era tutta ciccia, e non m’hai tocco l’osso della spina; che allora non si bevea oggi insieme questo buon vino. — Lascialo dire a me, ripiglia l’altro: tu me lo ficcasti nella trippa, e volle il mio buon santo, che la punta non intaccasse la milza; pel resto sarei già nel sotterratoio di s. Lorenzo. — Così fanno cotesti Romani: sono maneschi, ma sfogata l’ira, son generosi e si perdonano.
— Come faremo dunque, disse Edmondo, a trovarci il bandolo?
— Io ci conosco, disse il noleggiatore, due o tre carrettieri; cercherò di loro, ne piglierò lingua, e vedremo di farli braccheggiar tanto che leveranno la quaglia dal covo.
Intanto ella è padrone della casa mia, e io sarò sempre paratissimo a servirla; ma di grazia la non giri per Roma in quest’abito. Oh ch’ha ella fatto? ora m’avveggo ch’ell’ha una frittata di pomidoro sulla spalla: ha ella avuto già qualche scontro in Trastevere?
— Passai per un vicolo, e forse qualcuno le gittò per la finestra, e per caso le m’avran concio il vestito. Di grazia fammelo ripulire. Intanto eccoti cinque scudi per bagnare ed ugnere il gozzo a’ tuoi carrettieri.
Edmondo per non morire di noia sequestrato in casa d’Alfredo, mandollo al gabinetto di lettura in piazza san Carlo, e fecesi recare di molti giornali e tre o quattro romanzi della Revue des deux mondes, attendendo il risultato di quelle nuove ricerche. Se non che i carrettieri dopo tre giorni vennero ad Alfredo, il quale condusseli in un salotto, in cui rispondeva la camera d’Edmondo, e udiva tutto senza esser veduto.
— E così, amici, disse Alfredo, siete venuti a capo di scoprir nulla? Io v’ho pur descritto le fattezze della gio vane, i suoi capegli neri, la polacchetta a fiorellini cilestri sopra un fondo zafferano: è ne’ vent’anni; della parrocchia della Luce: volete di più? l’avrete trovata di certo.
— Scusate, sor Alfredo, rispose uno: i cristiani han tutti nome e cognome; senza quello come si scernono? Noi altri con riverenza vostra poniamo il nome insino ai nostri cavalli; il mio si chiama il morello, quel di compar Nicola lo stellato, e quello qui di padron Biagio il solimano e voi volete che noi troviamo una zitella, perchè ha il naso profilato e i capelli neri? Ogni viso di donna ha due occhi, una bocca e un naso: ogni testa ha la treccia e la scrinatura a pendoni, e in Trastevere poche sono le bionde, le lionate e le castagnine; son tutte di capelliera morata come l’inchiostro. Ell’è della Luce. Si: ma la parrocchia ha tante vie, tanti chiassetti, tanti vicolettacci, ch’è un labirinto. Abbiamo sguinzagliato le nostre femmine. Padron Biagio ha tre ragazze tutte di capei bruno e di naso affilato: io n’ho una in sui vent’anni, una traforella che trarrebbe il diavol dell’orcio: compar Nicola ha tutti maschi, ma ha una moglie sì parlantina, che la terrebbe a crocchio un passeraio, e il vincerebbe; sasselo questo cristiano quando la ci si mette: l’ultima è sempre lei. Or niuna delle nostre donne seppe trovar l’orma di quella lepre. Io con una scusa di cercar la mia Caterina, entrai alle zigarare: figuratevi! le saranno da seicento zitelle che accartocciano i zigari. Ce n’è costì eh delle putte? Non ne attinsi nulla. Ci siamo aggirati anco per tutti li stanzoni de’ telai, ove chi tesse, chi ordisce, chi incanna, e non ci venne mai trovato questo tesoro: sicchè, sor Alfredo, se non la battezzate, nè a noi basta l’animo d’averne indizio, nè crediamo che altri sia più fortunato di noi.
Alfredo diè loro un buon beveraggio, e se n’andarono; promettendogli di star sull’avviso, se per buona ventura scoprissero qualche cosa, e verrebbero a riferirlo. Edmondo si rodea fieramente del malo riuscimento della sua cavalleresca impresa, e davasi del dappoco giù pel capo, sì perchè avea dimentico il nome della giovane, e sì perchè per un vano rispetto non avea mai voluto domandarlo a Carluccio. Alfredo vedendolo di sì mala voglia, e dare a quando a quando nelle disperazioni, gli disse: Signor Edmondo, vogliamo noi affogare in un cucchiaio d’acqua? Uomo risoluto viene a capo dell’impossibile; mi sovviene d’un partito, che buon per lei se la saprà usarne con garbo.
In Roma, ved’ella, corre una usanza (e ne’ tempi addietro era più in voga) d’ire la notte sotto la finestra delle innamorate a farvi la serenata; in Borgo s. Pietro abbiamo Cecco di Nonna detto il mattonaro, perchè lavora alle fornaci fuor di porta Cavalleggieri: questi è il migliore sonatore di mandolino che udiste, mai, e rallegra le brigate la festa, alle ville, ove s’accolgono i Romani negli orti a bere e a cenare. Egli cercherassi due cantori di ballate e di madrigali e andrà con lei sonando per le vie intorno alla chiesa, della Luce: a queste notti la luna è grande, chiara e serena e vi si vede benissimo. Quando passa il mandolino e fa que’ trimpelletti soavi, che accompagnano la ballata, e’ non v’ è fanciulla che non esca il capo della finestra; e poi ch’ella conosce quel viso, abbia per fermo che lo vedrà.
Fu cerco di Cecco di Nonna: e rimasti con lui che troverebbe i cantori, la sera vegnente furono in ronda; ma senza aver trovata la Nunziatina; e invece occorse quel brutto scontro alla bettola dell’Arco de’ Tolomei, e poscia quelle chiocche d’Edmondo a mastro Menico in piazza Anicia che furono recitate nell’altro Capo. Ma essi aveano un bel cercare la Nunziatina, che la poveretta era in luogo ove la non potea farsi nè a uscio nè a finestra, e a poco ci corse che non la vedessimo più nè a piè nè in carrozza.
LA NUNZIATINA
Il popolo romano conserva ancora in certe sue costumanze le inclinazioni degli antichi Quiriti; e con tutto che la civiltà moderna abbia dimentichi o rimossi certi modi che sentono soverchiamente la forte natura de’ prischi Latini , tuttavia l’indole e la condizione sua lo ecciterebbe grandemente a gustarli. Sino a pochi anni addietro il suo più favorito trastullo era l’assistere colle mogli e coi figliuoli nel mausoleo d’Augusto alla caccia de’ tori; e più il toro accaneggiato infuriava, e maggiore era in quel popolo il godimento, il plauso e il tripudio.
Avendo Leone XII vietato quegli spettacoli siccome avanzo dell’antica barbarie, ora tutto il sollazzo della plebe si è d’accorrere al detto mausoleo, ridotto ad anfiteatro, per deliziarsi ai giochi ginnastici che fa una compagnia di giovani ne’ dì festivi. Il vederli abbrancare un palo, e per forza di muscoli rizzarsi e reggersi a quel pugno orizzontali; e intanto tendere il braccio, e aggorgarsi loro il sangue nelle vene, e risentirsene e rilevare i tendini, e croccar le giunture, e infiammare il viso , e tutta la vita in quel bilico violento muscoleggiare terribilmente, mette quel popolo in una inestimabile ebbrezza.
Que’ giovani atleti sono d’alta persona, snella e torosa, e per forza d’equilibrio reggono talora un uomo per ispalla e un altro per mano a braccio teso, onde veggonsi quattr’uomini sorretti da un solo , e quasi fosser pagliuzze , ognuno dei quattro gitta in alto e riprende e due e quattro e sei melarance, palleggiandole con un’agevolezza indicibile. Altri fanno gruppi e cerchi della persona, e s’annodano e snodano insieme con isforzi, e destrezze e pose, e scorci e rivolgimenti, che figurano al popolo l’antico lotteggiare nei circhi e nelle palestre della Roma de’ Cesari.
Similmente al Romano giova sopra ogni dire il trovarsi coi saltatori de’ cavalli, poichè hanno quei giochi del grande e dell’audace , e ai figliuoli dei vincitori del mondo piacciono gli ardiri, le malagevolezze, i pericoli e persino le temerità. Laonde s’affollano la festa al teatro Corea (che cosi ora si domanda il Mausoleo d’Augusto) e colgono infinito diletto dal vedere un uomo correre al galoppo sopra due cavalli appaiati tenendo l’un piò sulle groppe dell’uno e l’altro su quelle del secondo, e intanto agitar bandiere, o colla picca correr l’anello, o saltare una corda tesa e ricascar bilicato coi piè sopra i due corsieri. Altri spenzolarsi, altri fare il capitombolo, altri rizzarsi capovolti coi piè in aria e ripiombar cavalcioni. Altri correndo spiccare un salto e traforare un pallone di carta oppostogli, e cader diritti sul trascorrente destriero.
Ma quando poi il saltatore si scaglia correndo sopra una volta formata di punte di lancioni, e trapassa quelle irte punte con salto netto e spigliato, i viva e i battimano fendon le stelle: e usciti poscia del gioco, e seduti ai panconi dell’osteria, ne fanno un gran dire e un grande arruffarsi — Le lance eran sessanta, le ho contate io: no, le non giugnevano a trenta: Che! eri cieco? E tu eri briaco, e gli occhi ti vedevano a doppio. Briaco a me? che ti venga…. — Amici, grida un paciere, lasciamo le punte, ma il salto era mortalissimo. Eh che tombolo fatto per aria! Che paura, Madonna mia, dice una femmina, io chiusi gli occhi temendo che s’infilzasse, e io, mamma, soggiunge una puttina , ho chiuso il volto fra le mani e tremava tutta. Oh io non ci vengo più.
Nè la plebe romana dimenticò il suo genio induttivo al teatro; e vi s’affolla non solo la festa, ma eziandio ne’ giorni di lavoro, specialmente gli sfaccendati, i carrettieri, i muratori, gl’imbiancatori e tutti quelli che hanno opera da pieno giorno. Costoro non vanno mai ai teatri cittadini, ma a quello delle Muse in via del Fico, o d’Emiliani in piazza Navona: pagano i loro due baiocchi e s’impancano nella platea scamiciati o col farsetto sulla spalla, e sinchè s’alzi il sipario sguscian noci, sbucciano castagne, sgretolano avellane e nocciuole, o biascian lupini e semi di zucca.
Già su pe’ canti aveano veduto i cartelli dipinti; che son mascheroni fatti col granatino, e figurano i Reali di Francia in lotta co’ giganti e coi draghi alati; o Astolfo sull’ ippogrifo , o Rodomonte che duella con Rinaldo, o Marfisa che s’accapiglia con Bradamante , od Orlando che contro una frotta d’assassini abbranca un lastrone di macigno, e
il grave desco da sè scaglia
Dove più folta vede la canaglia.
Tutte coteste rappresentazioni sono recitate in volgar romanesco, e la plebe assistendovi parteggia per un paladino o per l’altro, e fa le scommesse d’una foglietta o d’un fiasco come qualmente Orlando stramazzerà Ferautte o Rinaldo da Montalbano darà sulle corna a Rodomonte. Essa ama poco le commedie d’amorazzi e di matrimonii: vuol duelli, vuol buglie, vuol capiglie di guerrieri e di scherani; vuole incioccamenti di spade, scagliamenti di dardi, accoltellamenti e mucchia di feriti e di morti. Più ne casca e più è contenta. Indi Pippo, il gobbetto, tradusse parecchie tragedie in Trasteverino, come la Francesca da Rimini, la Medea e la Didone, e v’accorrono e s’accalcano a vederle, e ne’ fondachi e nelle botteghe ne recitan poscia o ne cantano le scene intere, massime le più sanguinose: e quelli, ch’hanno un po’ di tinta di disegno, le delineano col carbone sui muri della Suburra, sulle cinte della ville intorno ai santi Quattro, alla Navicella e a s. Stefano Rotondo, luoghi remoti del Monte Celio.
Dette queste cose, è da tornare a Edmondo, il quale tutto arrovellato, sì per le serenate del mandorlino ite a male, e sì per l’assalimento di mastro Menico sulla piazza Anicia, e per le pugna sprangategli in viso, ricoverossi in casa d’Alfredo tutto scalmanato e anelante, temendo sempre d’essere inseguito dalla corte. Alfredo l’attendeva sonnacchioso e sdraiato sopra un sofà; e vistolo ritornare sì trafelato, disse: Oh ch’è avvenuto, signor Edmondo? Ebb’ella forse qualche brutto scontro co’ Trasteverini? Ha ella incappato nell’amante della sua incognita?
— Che amante! Alfredo mio: avrò veduto al suono della ribecca da trenta visi far capolino alla finestra, qual più qual meno, ma tutti visibilissimi; pure la mia colei dovett’essere in sul primo sonno e la non s’affacciò punto ; ond’io attediato e datomi per istracco, menai meco a cena il Mattonaro e i due canterini — E qui tacque delle sorbe ond’ebbe stroppicciato il grugno a l’un d’essi; e del suo correre per non dar nell’ugne della giustizia. Prese un lume e andò difilato a smaltire la bile in letto.
Il dì vegnente ebbe un lungo intertenersi con Alfredo per istudiare nuovi modi da giugnere al suo pazzo intendimento di pur trovarla; assicurandolo ch’egli avea quel ritratto sì vivamente scolpito nella mente e nel cuore, che ov’egli la vedesse anco al barlume, la ravviserebbe fra mille. Alfredo tuttavia badava a distorlo da quello strano e periglioso talento, che gli avrebbe cagionato mille dispiaceri. Egli era un parlare a’ sordi: tanto Edmondo s’era incapocchiato in quella sua bizzarria, che il mozzarla così a mezzo pareagli una dappocaggine, per non dirla vigliaccheria spiattellata.
Allora Alfredo veggendolo sì festereccio e caparbio gli disse: Egli non vi rimane che una via, s’ella vi riesce fallita, fate pure il caso spacciato.
— S’egli è per moneta, non resti: io son parato a spendere e a spandere quanto si voglia, purchè giunga a vederla.
— (Questo è proprio matto in mezzo al cervello, disse Alfredo fra sè. Che s’ha egli a fare coi signori? Contentarli: veggan eglino!) Ecco dunque, ripigliò, ecco, signor Edmondo, ciò che mi si volge pel capo. I Romani vanno pazzi pel teatro, e non troverete famiglia popolana che quando ha qualche grossetto d’avanzo, la non vada a sciuparlo al teatro Corea di giorno, e a quello delle Muse e d’Emiliani di notte. Egli vi bisogna adunque recarvi in quei ridotti popolari, e se la vostra giovane non è cosa fantastica ma reale.. .
— Realissima, interruppe Edmondo.
— Lasciatemi dire; s’ell’è di carne e d’ossa come le altre, non andrà molto che ce la coglierete di certo. Non vi consiglio il teatro Corea, avvegnachè di giorno si veggan meglio gli astanti; perocchè voi per quanto vi arruffiate e vestiate alla carlona, avete sempre sotto quell’abito sciatto un non so che di grazioso che vi tradisce gentiluomo: e se la plebe vi odorasse d’un po’ di maschera, voi potete irvi a riporre, e le spie del buon Governo, sospettando misteri e trappole, all’uscire vi farebbono un interrogatorio da non uscir netto. Sicchè fate a mio senno, andateci di notte. Ivi potete passeggiare coll’occhio a vostro bell’agio.
— La cosa mi va, disse Edmondo; gran mercè a voi: stassera mi metterò alla prova. A proposito! Mi grilla in capo un farnetico.
— (Ehm, disse da sè a sè Alfredo, come s’egli non farneticasse già alla sciammanata omai da un pezzo!) Be’, che vuol far ella, signor Edmondo?
— Fammi cuocere un quarterolo di bruciate; ma grosse e belle; proprio marroni; farammeli riporre in una cesterella col suo pannaccio sopra, che stien calde: e poi con essa io entrerò una sera alle Muse, un’altra all’Emiliani, e per tal foggia io avrò il più naturale pretesto d’avvolgermi per la platea e pel palcone, offerendo le mie bruciate a buon mercato. Gran che, ch’io non m’affronti nella Trasteverina che vo cercando?
— Un’altra! sclamò Alfredo. Ha ella viso di caldarrostaro?
Mentre Edmondo pazzeggiava, don Alessandro, avuto omai per le recite di Carluccio e di Pippo dipintore tanto in mano da creder vero quanto venivan dicendo delle stravaganze d’Edmondo, si risolvette di trovare il filo di cotesta matassa arruffata. Perchè una mattina appresso il coro di s. Pietro, senza parlare con persona del mondo, entrò nella risoluzione d’interrogare il Curato di santa Maria della Luce per conto di quella Nunziata; e colle sue mani conserte dietro le reni messosi per la porta Settimiana e per sant’Egidio alla volta della Lungaretta, entrò nell’androncello di fianco che conduce alla Sacristia della Luce. Ivi domandò del padre Curato; e dettogli ch’era in Parrocchietta a dar ricapito alle faccende correnti de’ suoi plebani, entrò a visitarlo. Il Parroco fattolo sedere, il do mandò gentilmente, che buon vento l’avesse ivi condotto.
— Ecco, padre Curato mio, disse don Alessandro, io vengo a voi per sapere se avete in parrocchia una giovane che si domanda la Nunziatina, che nell’ottobre passato voi trovaste nell’orto di Piscinula tutta mesta perchè, a cagione d’un ferimento d’un suo fidanzato, la non avea potuto uscire a sollazzo in campagna colle amiche a far l’ottobrata.
Sì bene che l’ho, rispose il Curato; ell’è una tessitrice di drappi di seta, e torna di casa quivi poco discosto: ma il suo fidanzato è guarito in breve, perchè la non fu che una scalfittura, e non ne fu data querela: anzi in parrocchia non si sa che dai parenti, i quali non ne fiatano per timore del fisco. Si sono rappattumati cordialmente; ed io gli ebbi tutti due qui in Parrocchietta , ed ho voluto rinnovare la pace fra loro. Figuratevi! chi gli tirò la coltellata fu il fratello di Nunziatina per una differenza nata improvviso in sul gioco; poichè pel resto sono sempre stati buoni amici. Che volete? son giovinotti di sangue caldo, aveano beuto un tantinello di più: insomma ragaz zate. Evvi egli forse per l’aria qualche nuvolo da parte della giustizia? M’increscerebbe all’anima: perchè (nol dico già per essere miei parrocchiani) ma credetemi, don Ales sandro, son due buoni garzoni. Toto, il fratello della Nunziatina, che fa il macellaro in via del Moro, è quegli che porta il troncone della Croce alle processioni della Confraternita: un pezzo di govinotto ch’è un toro, e si pianta nell’imboccatura di cuoio, che gli pende dalla cintura, quel tocco di Croce, ch’è una trave, e lo porta in bilico per tutta la Lungaretta come se la fosse un fuscello. Cencio poi, il fidanzato di Nunziatina, fa il carpentiere, ed è il sacristano della Confraternita: nelle processioni è un astiere del gonfalone, e quando si porta solennemente il santissimo Viatico agli infermi della parrocchia non manca mai di venire in cappa a sostenere il baldacchino.
— Non occorre, Curato mio, che vi affannate: non vi toccai del ferimento per altro, che per darvi un indizio che specificasse la Nunziata, non sapendo io come indicarvela altrimenti: e veggo che già m’avete inteso.
— Sì, voleste dire della Nunziata Celli, figliuola di mastro Simone carpentiere, che appunto ha Cencio per primo garzone. Uomo dabbene, e tipo de’ vecchi Trasteverini, il quale va tuttavia in calzon corto di velluto colle fibbie al centurino, colle calzette turchine, e colla fascia pavonazza: è il maestro de’ novizi della Confraternita, e da trent’anni in qua non ebbe mai una puntatura in Congregazione.
— E la Nunziatina, riprese il Mansionario, è ella fan ciulla di conto?
— Ell’è, vi dico io, una pastona col burro: bella e buona quanto non vi saprei dire più: la non è una santocchietta di quelle che ahimè non mi toccate! e le sono poi serpentose come le vipere, se non si va loro a’ versi, e cicalano tutto il dì su per gli usci, e trinciano i panni addosso alle pigionali e alle vicine con cisoie sì taglienti, che le discarnano insino all’osso. Oh no; la Nunziatina è un tantino collerica, se volete, pronta, ardita; ma la rivien subito e la si rabbonaccia come una conca di latte: modesta, che Dio ci guardi che un le dicesse o facesse; la non guarda in viso a nessuno, e le basterebbe la vista di dare uno sgozzone anche a un ufficiale che avesse dieci dondoli in petto. Non v’ è pericolo che manchi mai alla dottrina cristiana; anzi ell’è la maestra delle mezzanelle , e la m’aiuta per apparecchiarle alla prima Comunione. Per ciò le ottenni una dote di Borghesi, un’altra di s. Girolamo della Carità e le raggranellai una trentina di scudi da Monsignor Elemosiniere del Papa, che le serviranno per un po’ di corredo.
Per l’arte potrebbe accrescere il suo salvadanaio di qualche giulio, e aggiugnere qualche fronzolo ai vestiti di festa; ma quella benedetta fanciulla ha un cuore di reina, e la spende i suoi risparmiuzzi nelle sue scolare. A questa, che vede cenciosa, fa un guarnelletto di bordato; a quest’altra ch’è già in sul metter persona, e va scollacciata, compera una pezzuola da collo, ovvero le raffazzona una goletta: quella mancò domenica alla dottrina perchè l’era in ciabbatte, e Nunziata se la piglia seco, la conduce in via de’ Giupponari, e le fa misurare un paio di scarpe. Quella è pallida smunta; ha già quindici anni ed è uno stecchetto arido abbrustolito — Oh che hai , Tuterella mia? le dice — Ho fame, le risponde: patrimo è carcerato per una rissa, mamma ha le quartane e non può lavorare, io fo le cannelle e guadagno trentacinque baiocchi la settimana; son più le notti che mi corico senza cena che altro; e spesso tutto il nostro desinare è una fetterella di pan casareccio e cinque o sei castagne: mamma piange perchè la mi vede languire: v’assicuro, sora Nunziatina , che talora non ho forza da girare la ruota del mulinello. Qualche sera son ita di là da ponte, sono entrata a un panattiere per un po’ di pane, v’era il garzone, il quale nel darmelo volea baciarmi; e io scappa; e così m’avvenne a un salumaio, cosi a un pizzicagnolo: oh che birboni! che vegna loro l’anticuore — Non imprecare , dice la Nunziata ; ma facesti bene a fuggire; vieni a mangiare una buona zuppa — E per parecchi giorni ha diviso il suo pranzo colla Tuterella, che era divenuta un fiore.
Ma più bella è questa. Abbiamo in parrocchia una fanciulla di sedici anni, orfana di padre e di madre, la quale sotto i suoi cenci è un portento di bellezza: è onesta, ma stordita e capona: l’ho posta più volte all’arte; ma pe’ suoi capricci ora vuol fare la nastraia; poi non le piaciono più i nastri, e vuol incannare l’orsoio: lascia quello, e vuol acconciarsi colle lanaiuole, intantochè non la posso stabilire a un mestiere. Un giorno costei s’avviene in due pittori, che le mettono gli occhi addosso; e considerata la bella attitudine della persona, la proporzione delle parti sì ben intese, la grazia delle fattezze, la proprietà e vaghezza dell’aria, il profilo ben disegnato e rispondente, la richiesero di recarsi con esso loro allo studio per ritrarla, che le da rebbero mancia d’uno scudo. La scioccolona per buscare lo scudo, s’avviò con essi alla Lungara ov’eran di stanza. Cominciano dal farle ben lavare il viso, dal ravviarle i capegli, e poscia si mettono a ritrarla. Quando giunsero al mento uno di loro s’alza, dicendole — Ora bisogna che tu ti scopra una spalla per veder bene l’appiccatura del collo — e stende la mano per togliere l’ancinello; ma la Rita (ch’è il suo nome) pronta come una spada, gli afferra la mano, e dice: Aspettate, che ho la camicia rotta: vò a mutarla, e son qui in un attimo; e dettolo, rizzossi, e svignò come un lampo. La Nunziatina lo seppe e le godè l’animo di tanta verecondia; cercò di lei, lodolla , accarezzala, dielle una buona colezione; e acciocchè la non fosse più così andereccia, se la raccolse al suo telaio, le insegna cantare di belle canzoni della Madonna, le racconciò attorno alcuna sua roba e ogni festa me la conduce seco alla chiesa.
Don Alessandro l’udia con ammirazione, e richiese il Curato se la si sposerebbe entro l’anno.
— Che volete? rispose, la non ha ancora l’acconcio a ordine: non vi dico già che la manchi del letto nuziale, poichè suo padre ha compero i materazzi doppi di buona lana, e la lettiera di noce a sponde la c’è, e lucida e colle colonnette a pigna dorata; ma occorrono almeno sei paia di lenzuola, e un paio di mussolina coi falpalà e colle trine per le feste del battesimo e del comparatico. Il coltrone imbottito se l’è fatto, ma le manca la copertina bianca tessuta a soprariccio. Il più forte è la biancheria di dosso; ma quando avrò il sussidio di Monsignor Elemosiniere, la si farà un buon fornimento. Essa avrebbe desiderato spacciarsi per l’Epifania, ma veggo che appena sarà per Pasqua. Se non che ora la poveretta ha altro a pensare.
— Oh che c’è egli intravvenuto?
— Poco meno che non l’abbiamo perduta; ma ora per grazia della Madonna è fuori di pericolo. Coteste Trasteverine sono piene di fede, e ritraggono molto delle antichissime usanze dei primi secoli della Chiesa: imperocchè ove qualche padre o madre di famiglia, o qualche garzone o fanciulla ammalano gravemente, hanno l’usanza di pregare le vergini della contrada di raunarsi e condursi di brigata alla Madonna dell’Orto o del Panteon o specialmente di sant’Agostino, ed ivi supplicarla della guarigione; perocchè hanno questa credenza , che le orazioni delle vergini sieno più accette a Maria, che tanto ama ed apprezza l’angelica virtù, siccome il più bel raggio del paradiso. Coteste zitelle poi s’apparecchiano il più delle volte a quell’atto di carità purificandosi prima colla confessione, e ci vanno a piè scalzi. Giunte alla chiesa si prostrano dinanzi alla Santa Immagine, e se non v’è gran gente, una d’esse intona le litanie, e poscia tutte esclamano — Grazia, Maria Madre di Dio, grazia; vogliamo la grazia: non ci lasciate partir sconsolate: ce la fate eh, cara Mamma? — I divoti astanti, che lo sanno, le aiutano di loro preghiere.
Or avvenne che la Nunziatina , allorchè ci fu quella briga del fratello e del fidanzato, volendo che l’uno guarisse, e l’altro non andasse carcerato, il giovedì stesso che dovea far l’ottobrata, pensò di recarsi a supplicar della grazia la miracolosa Immagine della Madonna di sant’Agostino; e per dimostrarle più divozione, si tolse le scarpe, e v’andò in peduli. Era meglio che v’andasse scalza del tutto; perocchè attraversando per certe vie bagnate o fangose, la s’inzuppò le solette delle calze, e con quell’umido a’ piedi la si trattenne in chiesa a lunga per udir messa, farvi la Comunione e l’azion delle grazie. Tornò a casa, e non curossi d’altro. Ma che? l’umidità le intasò fieramente il capo, e poscia le scese alla gola dandole una forte infiammazione, che le cagionò la febbre.
Cominciarono a visitarla di molte donnicciuole , e ciascuna avea il suo rimedio, e le impasticciarono la gola o il petto di mille impiastri e farinelle ed ontumi. Finalmente vedendola peggiorare, siccome superstiziose che sono, cominciarono a dire: Qui per certo cova qualche malia; la zitella è affatturata, qui ci bisogna gli scongiuri. Una prese un mattone, arroventollo; gittovvi sopra alcune granella d’incenso, e dai segni o stelluzze che struggendosi lasciava, pronosticava intorno al male. Un’altra mise dell’acqua in un piattello, e intinto il dito nell’olio, lasciò cader dentro nell’acqua la goccia, e dal modo con cui veniva a galla, disse: Di fermo la zitella è stregata — Fra il popolo avvi certi santoni che hanno voce di possedere nell’occhio, o nel contano, virtù di sciogliere i legamenti e le fattucchierie; perchè chiamatone uno, e dettole sopra certe sue goffe cantilene, e fattole certi segni col polpestrello dell’indice sulla fronte, lasciolla che la poverina non potea più inghiottire.
Il padre venne triste a significarmi la malattia della figliuola; v’accorsi incontanente, vidi che il caso era grave, e dissi: Buona gente, qui non v’è tempo da perdere — Mandai al Presidente regionario per due portatori, e fattala porre dolcemente nella lettiga, l’inviai allo spedale di s. Giovanni Laterano. Ivi i medici accorsero solleciti al rimedio, traendole sangue, applicandole alla gola le sanguisughe, e promovendole colle fomentazioni il sudore: per sorte che l’angina a mano a mano venne sciogliendosi e dileguandosi. La Nunziata era già fuor di pericolo; ma come suol avvenire che le disgrazie vanno sempre appaiate, occorse che la sorella di Cencio, l’amante suo, che era amica di lei dall’infanzia, chiese la permissione di visitarla, e andovvi con un’altra giovane del vicinato.
Era l’usanza de’ Romani quando visitavano i parenti o gli amici allo spedale, di recar loro mille cosette da refiziarli: ma siccome il popolo non conosce altro ristoro che il massiccio, cosi ai convalescenti, in luogo di qualche arancio, o di frutte mature, portavano un pollo arrosto, un quarto di gallinaccio, o una lonzetta d’agnello, aggiuntavi una buona caraffa di vino, dal che nascevano disordini grandissimi. Da parecchi anni tutto questo è vietato severissimamente, ed oltre a ciò le Religiose, cui è affidata la cura delle inferme, ne avvertono quelle che entrano nelle corsie; e ov’abbiano involti o sportole o panieruzzi, le obbligano di lasciarli fuori del cancello d’entrata.
Giunta la Margherita, e chiesto della Nunziatina, la monaca di guardia le disse: che la giovane avea migliorato di molto, e già per un paio d’ore le si concedea di sedere sul letto: badasse di non recarle né ciambelle, nè altro. Pensi! rispose la Margherita, e apertasi lo sciallo che pendeale dal capo sulle spalle, mostrò che la non avea né cartocci nè fardelletti nè altro. Onde fu lasciata entrare.
Le accoglienze furono giulive, e il cicalio intorno alle comari, alle pigionali e a tutte le donne della vicinanza era interminabile. Ma la Margherita in mezzo a tante chiacchiere si traeva a quando a quando di tasca de’ zuccherini, e di soppiatto, fra piega e piega del lenzuolo, li lasciava cadere in mano della Nunziata, che di presente se li gustava: se non che quei canditi erano cerchietti e pallottoline piene di spirito di vino confettato, gustosissimi ma tanto veleno per l’inferma di gola. Che ne avvenne? Ciò ch’era naturale a seguirne; che la Nunziata ricadde più accesa di prima, e il male crebbe sì fortemente, che parca volgere alla cancrena, e…
Mentre il padre Curato narrava a don Alessandro questi accidenti, ecco di botto, senza picchiare nè dire — è egli permesso? — entrar d’improvviso nella stanza parrocchiale una donna colle mani in sul fianco, e farsi con baldanza sotto il mento del Curato, rossa in viso e tutta galluzza, dicendogli — Vedete, padre mio, se io avea ragione di dire che quel ranocchiaro de’ giorni passati era un ribaldo, che venia mascherato in Trastevere e con sinistre intenzioni, e voi mi garriste sì bruscamente perchè gli avevo attizzato addosso i monelli che lo pigliassero a mele fracida e torsi? Eh, padre Curato mio, la Lucrezia ha gli occhi lunghi e il naso acuto, nè la s’inganna, ch’io il ravvisai subito, e l’odorai di netto, ch’egli venia in Trastevere per qualche truffa. E voi? non è vero, siete una ciarlona, una mettimale, avete sollevato uno scandalo in tutta la contrada. Sì chi la scandalosa son io: e la Brigida e la Ceccarella che son state le prime, oh quelle sono due paste d’Agnus Dei. Eh Lucrezia sfortunata!
— Bè, Lucrezia, perchè tutta cotesta gracchiata? Disse il Curato con volto sereno e tranquillo.
— Anche mi domanda il perchè! Del rabbuffo che allora mi faceste, transea; ma voler dire che il ranocchiaro era un povero pescatore maltrattato da noi per capriccio, qui voi v’avete il torto aperto (perdonate se parlo male), sì che l’avete.
— Provatemelo, Lucrezia, perocchè sin ora le son parole.
— Ed io a’ fatti. lersera, per togliere un po’ di dosso la mestizia alla mia Chiaretta , che piange perchè il suo amante ha un poco d’indisposizione, la condussi meco, e con essa la Ceccarella al teatro delle Muse, ove facevansi i Paladini di Francia che in virtù delle loro spade salvarono la figliuola d’un Re, che aveano rubata li Saracini. Un battibuglio, vi dico io, da tremare; ma Orlando ne ammazzò dodici: eh che mucchio? ed uscì fuori con quella reginetta ch’era pallida come una pezza lavata.
Mentre dunque noi eravamo nel palchettone (perchè la Lucrezia quando ha seco le giovinole non la va mai giù in platea) io vedeva girare di panca in panca un caldarrostaro, e fermarsi innanzi alle donne, ed esibir loro de’ suoi marroni, dandoli quasi a uffo. Gli puntai l’occhio addosso, e mi parea e non mi parea: frugai col gomito la Ceccarella, e dissi — Attendi un po’ là a quel marronaro — Egli m’ha l’aria d’un pazzo, rispose la fanciulla, non vedete, Lucrezia, com’egli va di posto in posto guardando fiso nel volto ciascuna di quelle montigiane? A me però mi pare di ravvisarlo — Dunque gli è desso, soggiunsi io — Desso chi? — Il ranocchiaro; non ti par egli quel giudeaccio, che non volle piegare il ginocchio al Bambino d’Araceli? — Deh sì, sclamò la Ceccarella: oh guarda! proprio quel mostaccio dispettoso.
Ne passa voce ad altre Trasteverine, che il giorno de’ pomidoro furono presenti a quella sconfitta; e ciascuna squadratol bene, ripetea , ch’era lui in petto e in persona; e faceano i più nuovi comenti intorno a quel suo vendere a sì largo mercato, e di quell’avvolgersi, egli giudeo, fra i cristiani. E mentre dai pissi pissi, veniansi fra noi alle voci scolpite, e il nome di giudeo già s’udia sino da basso fra le torme de’ macellai, degli agnellari, de’ conciapelle e de’ fabbri, colui si trova di rimpetto a Renzo cantore. Perchè conosciutolo, cominciò a dire ai compagni — Vedete là quel grugno dalle caldarrosto? Quegli è che ha pesto e macerato mastro Menico in piazza Anicia ; quando ci condusse con Cecco di Nonna a cantar tutt’a due sul ribecchino le serenate. E il povero Menico fu a un pelo di perdere un occhio, e penò a guarire nello Spedale della Consolazione, per poscia ripiombare in carcere. E sentite lassù le donne che l’asseriscono giudeo?
Io, padre Curato mio, non ho potuto stare alle mosse; ma veggendo Renzo, che accennava ai compagni quel mariuolo, gli ho fatto cenno colla mano che salisse a noi per narrargli il fatto delle ranocchie; e Renzo ci venne. Nol avessi mai fatto! Poi me ne morsi le dita, perchè il piccione aveva già preso il volo. Imperocchè il farabutto, visto Renzo salire a noi; e li compagni di lui guardarlo in cagnesco; dovette aver detto fra sè — Qui non ispira buon’aria per me — e còlta l’occasione del cambio delle sentinelle a piè del palco scenico, s’intruse fra loro e il sergente, che tornava alla porta, e fra uomo e uomo smucciò fuori del teatro, dandola poscia a gambe come un daino.
Appena risceso Renzo in platea, cercò dell’occhio ove si fosse rannicchiato il caldarrostaio; ma nol trovando per ogni lato, ne domandò, la sua brigata, la quale rispose: Era qui ora; che vuoi? Mentre tu salisti nel loggione si alzò il sipario; uscì Orlando, e cominciò a menare la Durlindana: tutti i nostri occhi eran pur volti là; intanto colui s’è dileguato come un razzo.
— Andiamo, gridò Renzo, a sonargliene quattro: birbone! ha quasi sfracellato mastro Menico, ed è un giudeo — Un giudeo? strepitaron tutti: oh che voleva egli alle Muse? Acchiappa, acchiappa — E il dirlo, e l’uscire in frotta fu tutt’uno. Due tennero per la via del Fico, due per la Pace, due per la Vallicella, e gli altri si sparsero correndo per altri vicoli dietro a Monte Giordano. I due che correano pel vicolo del Corallo trovarono nel canto sotto la Madonnina la cesta che per correre più spedito avea gittato, e trovaronvi dentro sotto il panno un resto di que’ bei marroni. Corsero; ma l’altro gli avea avvantaggiati chi sa quanto, e ne perdettero la traccia. Vedete dunque, sor Curato, se io aveva ragione! È fuggito; ma ci darà, ve lo prometto io, fra le granfie, e te lo conceremo di simil fatta, che gli caveremo di capo la voglia d’accostarsi mai più a Trastevere.
LE MANCE E LE PROPINE
Trovandomi la state passata a Fano in casa d’ un gentiluomo mio amico , diceva Edmondo ad Alfredo , mi fu fatto sentire un maraviglioso villano sonare un suo bizzarro stromento, di ch’ io mi dilettai soprammodo. Quest’ uomo è un gagliardo lavoratore di terra in sui campi intorno alla città, e buon bifolco e ottimo in far nesti e condur solchi dirittissimi e profondi. Nel verno, standosi a veglia nelle stalle colla brigata, ei si diletta di rozzamente comporre sampogne, congiugnerle, dar loro l’inceratura e ornarle di piastre di rame; colle sgorbie incava, e co’ trapani trafora chiarine, pifferi e flauti con un artifizio e maestria inestimabile. Costui è musico per natura, ed ha un’anima sì fattamente armonica, che all’udire una sinfonia, eziandio variatissima, ei la ripete sulla sua sampogoa, o sulle corde del suo violino, senza dimenticarne una nota.
Ora costui, non pago a un solo istromento , immaginò di formarne parecchi in uno; e tanto acuì l’ingegno, che gli venne fatto d’accozzare insieme, e di sonare egli solo a un tempo i contrabassi dell’organo, gli acuti della sampogna, i dolci e soavi del violino, i tintinni de’ campanuzzi, li squilli degli oricalchi, i rumori del timpano, il baccano della fanfara.
— Diasco! credici! disse Alfredo. Li avrà sonati a muta a muta, ma non tutti a un tempo. – –
— Tutti a un tempo , ti dico. Avendo io mostrato curiosità non piccola di vedere e udire sì nuova cosa, l’amico fece dire all’uomo che per la dimane fosse al suo palazzo coll’organo; e intanto invitò di molti suoi conoscenti che intervenissero a udirlo sonare. Eravamo il dì appresso convenuti nella sala; ed ecco un paio di giovani robusti portare a braccia un carretto con sopravi lo stromento, il quale come fu in sull’uscio della sala, il suonatore lo tirò sulle ruote in mezzo di quella.
Era cotesto villanzotto uomo d’età fresca, di color bruno, ricciuto e tarpagnuolo, d’occhi vivi, di modi curiosi, e d’aria tra il modesto e il disinvolto, il quale inframmesso certe magliette negli uncinelli che dovean far giocare al cune leve de’ suoi stromenti, trassesi le scarpe; e messasi sotto una panchetta , sedette alla sua orchestra. Lo stromento era un palchetto, sul quale erano infissi nel somiere i cannoni a vento del contrabasso e delle voci fonde e sonore. Nel somiere venia il vento per un mantice sollevato da un pedale, che il sonatore calcava col piè dritto: a mezzo le canne dei contrabassi era fitta con due piuoli la sampogna; dietro i contrabassi erano appesi i campanelluzzi, i sistri, le bacinelle di bronzo, e più basso il timpano; tutti i quali per via di mollette e di controleve comunicavano con un secondo pedale.
Seduto che fu il sonatore prese in mano il violino, archeggiò alquanto sulle corde, e insieme colla bocca tastò le canne per sentire se il violino era bene intonato: indi fece una ricercata sulle corde, e uno scorrimento sulle canne quasi a preludio, e tutto in sè medesimo si compose. Gli uditori erano intenti, e non batteano palpebra. Il suonatore appoggiò il violino in sul fianco, accostò la bocca alla sampogna, pose il dito grosso del piè manco sopra un pedale de’ contrabassi, e le altre dita sopra due altri, ch’eran vicini, come i listelli d’una tastiera; pose il dito grosso del piè diritto sul pedale del mantice, le altre dita sul pedale de’ campanelli, e intonò una monferrina. Direbbe Dante:
Non avea membro che tenesse fermo.
Colla mano manca scorrea sulle corde del violino, colla diritta movea l’archetto, colla bocca soffiava nelle canne della samipogna, col piè dritto alzava il mantice, col sinistro intonava i doccioni de’ contrabassi. Quando suonava il delicato, quando il grave, quando l’acuto, quando il concitato e il gagliardo: e ne’ gagliardi colle dita del piè manco dava aria e voce sino a tre bassi a un tratto; e con quelle del piè dritto metteva in movimento tutti gli ingegni de’ campanelli, de’ sistri, del timpano e degli oricalchi, con un rombo, un frastuono, un fracasso che facea tremar le pareti della sala. E tutto ciò a tempo, a misura, con un accordo, con un conserto, con un’armonia che non falliva d’un apice, nè rompea nella minima dissonanza.
— Oh caro Alfredo, s’io avessi quest’uomo ingegnoso, e potessi farlo girare pei trebbi, pei crocicchi, per le piazze di Trastevere, non credi tu che vi accorrerebbon tutte le donne e le fanciulle d’ogni età e d’ogni mestiere? Io credo che sì; e avrei la più bella occasione di vederle a mio agio senza che punto se ne addessero, tanto sarieno intente a quella nuova musica; ed io troverei per certissimo quella che sì bramosamente sto ricercando. Ora vo almanaccando per trovare un colore specioso di farlo venire senza sospetto, scrivendo a quel gentiluomo, e pregandolo di mandarlo a mie spese.
— Cotesti son sogni, signor Edmondo; ed ella si farebbe mettere in voce per tutta Roma: sin ora per buona sorte ell’è campata da strani accidenti, che poteano pericolarla e cagionarle di brutte paure; e però vorrei che la uscisse di cotesto ginepreto , ove tosto o tardi vi lascierà qualche brandello di veste, per non dire di pelle. Oltre che il suonatore fanese, contadino e lavoratore essendo, avrà padrone , il quale nol vorrebbe scioperare togliendolo a’ campi per farlo giocolatore e scorrazzatore di città, con occasione certissima di sviarsi.
— Ma pure io vorrei venire a capo d’un desiderio, che agli occhi tuoi ha del bizzarro e dell’ ostinato, e ai miei del nobile e del costante. Oh gua’l sarà egli vietato oggi mai a un gentiluomo di beneficare una buona creatura, e premiarla d’un’azion virtuosa? qual codice lo contende? qual statuto il condanna?
— Il codice della discrezione e lo statuto della prudenza. Io per quella franca e leale servitù che, come creato di suo padre, le professo, la consiglierei di rimettersi ne’ suoi panni, d’usare colle nobili brigate, di vivere da gentiluomo, e attendere che le si porga una propizia occasione di cavarsi questa sua voglia senza nota dell’ onor suo e senza offensione d’una giovane dabbene.
— Indicami adunque tu per qual via potrei pervenire a questo mio intendimento senza che gli amici miei ne potessero sospettare; perch’io non amo di partecipare i miei secreti nè cogli amici, nè coi curiosi e gli sfaccendati.
— Oh manca in Roma occasioni di veder popoli ! S’ella avesse un tantino di pazienza, forse per l’annivers-ario del l’ incoronazione del Papa le riuscirebbe di vedere la sua Trasteverina. In Roma è questa usanza, che nel giorno, in cui ricorre la detta coronazione, la gente, massime di Borgo s. Pietro e di Trastevere, accorre tutta al palazzo Vaticano alla dispensa che fa l’Elemosiniere di Sua Santità a quanti gli si presentano innanzi: laonde accoltili tutti nel cortile di Belvedere, sfilano innanzi a Monsignore, che dà a ciascun capo un po’ di moneta.
— Doh popolaccio pitocco! Io ci metto il capo contro un morso di berlingozzo, che la mia Trasteverina non s’intrupperà fra quella bordaglia. Ell’è troppo nobile; ell’ha fattezze di reina, e da’ suoi sembianti spira una maestà incoronata.
— Oh di coteste reine la ne vedrà di molte, le quali non isdegnano le grazie del Vaticano,: quando invece sono sì superbe ed altiere con un uomo privato, che offerisse loro gli scudi. Esse hanno queste dispense in conto di strenne paterne, d’usanze di famiglia, di carezze dovute ai figliuoli. Il Papa è considerato dal popolo romano come capo della Chiesa universale, ma eziandio come padre loro specialissimo. Quando i Papi andavano a incoronarsi a cavallo, l’Elemosiniere portava in arcione due sacchetti di moneta mescolata d’oro e d’argento e ne gittava le manciate fra il popolo per munificenza reale. Ciò mi narrarono molti anni sono certi vecchioni, che videro la cavalcata di Clemente XIV, la quale fu l’ultima, perocchè il cavallo sinistrò, intraversando malamente; onde i Papi v’andarono poscia in cocchio trionfale; e però a’ nostri giorni coteste dispensazioni fansi a mano dall’Elemosiniere in luogo stabilito, e il popolo vi accorre, come a una paterna larghezza, senza vergognarsene punto!
— Sì sì, come vuoi, ma le sono pitoccherie da far arrossire ogni popolo ben creato, e cotesti romani tenderebbero la mano alle statue come Diogene, tanto sono avvezzi a fare gli accattoni, segnatamente coi forestieri. In Roma tutto è mance, e non vi si respira che doni, che propine, che beveraggi, che offerte, che dispense, che strenne, che tasse. Qui tutto si risolve in papetti e scudi. Dimmi, Alfredo, se le non sono improntitudini da movere a stomaco un petto di bronzo.
— I primi anni della mia venuta in Roma molte di coteste usanze suscitavano anche a me la bile, ch’io poi riversava nei crocchi e nelle raunate de’ nostri terrazzani, che venivano a svernare sotto questo bel cielo. Ma poscia ch’io colla lunga stanza di Roma ebbi conosciuto più addentro l’indole di questo popolo cominciai a darmene pace, la quale s’accrebbe in me quando mi resi cattolico insieme colla moglie mia, e cominciai a costumar più da vicino coi Romani.
— Come! tu ti se’ fatto papista? Se’ tu impazzato?
— Io vorrei, signor Edmondo, ch’ella impazzasse altrettanto, che la farebbe la più bella pazzia ch’ella potesse mai fare in vita sua; poichè l’assicurare l’eterna salute è il punto massimo.
— Quant’è che tu commettesti questa viltà, e vi trascinasti quella tua povera donna?
— Cioè fu ella, che mi v’indusse, e le n’avrò obbligo immortale; e se prima l’amavo cordialmente, ora l’amo e la venero come un angelo di Dio che m’aperse la porta di vita eterna.
— E si sa egli dai nostri? Bell’onore che tu fai alla patria!
— Sanselo quanti vogliono saperlo, perch’io feci le cose mie in pubblico sotto gli occhi del sole, e fui accolto con una benignità inestimabile nell’ospizio de’ Convertendi per esservi amorevolmente instruito. Ivi è un caro prete tedesco, uomo antico e venerando, il quale da oltre a quarant’anni si studia con ogni carità e pazienza d’ammaestrare i poveri protestanti che bramano di ritornare nel grembo di santa Chiesa. Da un altro Iato dell’ospizio è il quartiere delle donne, alle quali presiede un’antica matrona, che dal luteranesimo si converse alla verità, e venuta dalla Finlandia a Roma, dedicossi a questo nobile offìzio d’aiutare coll’opera e col consiglio le convertende. In quel santo luogo stati ambedue parecchi giorni, come fummo bene istruiti nella dottrina cattolica unica e vera a salute, femmo pubblicamente l’abiura de’ nostri errori.
— Ah ora veggo perchè in casa tua avvi la Madonna in capo alla scala colla lampana accesa: io mi credetti che il facessero i pigionali del secondo piano. Buono, buono! e’ mi toccò di ricoverarmi sotto il tetto dell’idolatria.
— Non dubitate che il tetto non vi cascherà in capo; e voi che chiamate idolatria il venerare l’immagine della Madre di Dio siete divenuto idolatro d’un ritratto di fanciulla che v’ha tolto il cervello; nè credo che voi già amiate quei quattro colori schiccherati dal pennello sulla tela, ma la persona rappresentata da quelli. Così noi non veneriamo nelle sante dipinture, che l’oggetto figurato in quelle.
— Va, va; io celiava, Alfredo; statti buono; non ti scorrubiare; ma dimmi invece, poichè tu se’ in sull’avvocar le cause spallate, che trovasti nel farti cattolico di buone ragioni da difendere coteste pidocchierie de’ Romani?
— Io non sono uomo da tanto, avvegnachè sin da giovane mi dilettassi di leggere la storia romana e sapessi quasi a memoria il Rollin; ma ragionando spesso con preti savi e dotti, conobbi di molte cose, alle quali io non avea mai vòlto il pensiero per investigarne le ragioni. Tra questi un certo don Alessandro mansionario di s. Pietro mi fece fare sopra cotesto punto di belle e giuste considerazioni.
— Don Alessandro! Certo; per lui i Romani sono il non plus ultra; e se il diavolo fosse romano, nella bocca di don Alessandro sarebbe un modello d’ogni virtù.
— Lo conosce ella, signor Edmondo?
— Se lo conosco! e sino dal primo vederci al museo di villa Borghese mi fece un risciacquo spaventoso per solo aver detto che i Romani non gustano le belle arti, e non frequentano le gallerie di Roma. Ma ch’egli poi trovi bello che i Romani asciughino le borse de’ forastieri , cotesta è nuova davvero.
— Perdonate; egli nol trova bello; e spesso ne borbotta; ma risale alle origini di queste costumanze curiose e incomode agli stranieri. Egli ragiona cosi. Il popolo romano fu per molti secoli il padrone del mondo. Colla sapienza del suo consiglio e colla fortezza del suo braccio vinse e domò tutte le nazioni conosciute, le fece obbedienti alle sue leggi, tolse loro di dosso la barbarie, ingentilendole della sua civiltà, e sollevandole all’onore della cittadinanza romana. Queste nazioni, anco lontanissime, aveano il popolo romano in conto di signore, e pagavangli tributo; né contente a ciò, quando voleano ottenere alcuna grazia dal voto popolare, mandavano presentare di ricchi doni i tribuni e le tribù intere. I re africani e i re d’Asia per gratuirsi la plebe sovrana le versavano in seno tesori, e così faceano le città e le provincie alleate: e attendete, che non si trattava già di migliaia, ma di milioni, i quali si distribuivano per ogni capo d’ uomo.
Sopravvennero poscia i nobili romani, i quali inviati dal Senato a Proconsoli, a Governatori, a Questori delle ricche provincie dell’impero, tornavano dopo i carichi in Roma, recando seco ricchezze sfondate: la prima cosa che faceano si era quella di banchettare il popolo, e di rallegrarlo colle feste del circo e del teatro. I Consoli, che vernano in Roma a trionfare delle vinte nazioni, si faceano portare innanzi i vasi traboccanti di moneta, che spandeano a gran profusione fra il popolo. Le grandi famiglie senatorie per isfoggio della loro opulenza faceano lauti conviti alla loro tribù; ovvero dall’Egitto, dalla Sicilia e dalla Sardegna faceano approdare ad Ostia parecchie navi cariche di grano, e consegnatolo ai forni pubblici, dispensavano per parecchi giorni il pane alla plebe. Cessata la repubblica, e rettosi lo Stato a monarchia, non vi dico le profusioni degli Imperatori per ottenere le acclamazioni del popolo, e per tenerlo cheto che non bramasse l’antica libertà e non si sollevasse in ammutinamenti, o si gettasse nelle congiure e nelle sedizioni delle parti.
Ora, diceva don Alessandro, cotesto popolo avvezzo per tanti secoli a vedersi tributario il mondo e ad esser pasciuto alle altrui spese, qual meraviglia se coll’andare de’ tempi non ha mai potuto smettere cotal suo privilegio? È natura di tutte le metropoli, ove ha trono il Monarca e risiede la Corte suprema, il vivere dei tributi delle provincie. Parigi vive a carico di tutta la Francia, Londra di tutta la Brettagna, dell’Indie e delle Colonie, Vienna di tutto l’Impero: pensate se Roma imperatrice del mondo non voleva che tutto il mondo la impinguasse e gareggiasse di accarezzarla e soccorrere a’ suoi piaceri?
— S’egli è poi per cotesto, egli è un buon pezzo, disse Edmondo, che la superba Roma perdette la signoria delle genti, le quali per ripagarla della dura servitù, in cui le avea tenute, scesero tempestose dall’aquilone a’ suoi danni, e quelle mura, che l’orgoglio romano chiamava eterne, e a cui prima i popoli stranieri s’accostavano con riverenza come a cosa sacra, furono furiosamente assalite, diroccate, e rese picciolo schermo al loro furore. Roma fu resa serva alla sua volta, le sue ricchezze rapite, le sue curie, i suoi fori, i suoi tempii, le sue terme, i suoi circhi, i suoi anfiteatri ruinati, abbattuti e ragguagliati al suolo. In luogo de’ suoi Cesari che le portavano le spoglie del mondo, vide i re de’ Goti, i re de’ Vandali, i re degli Eruli, i re de’ Longobardi, che la spogliarono di quanto ella avea tolto alla Grecia, all’Egitto, e all’Oriente, lasciandola ignuda e inferma a morte: intanto che Roma non ebbe più un palmo di terra, su cui poter libera piangere le sue sventure. E don Alessandro ci vien a ricantare l’abito naturale del popolo romano risultante dalla ricordanza della sua antica signoria del mondo, che l’induce a riputarsi creditore degli omaggi e dei tributi di tutti i forestieri che vengono in Roma, i quali due mila anni addietro erano i suoi vassalli! Questa mi par proprio la gentile risposta che danno gli arabi del deserto a chi domanda loro — Perchè rubate le carovane? — Ecco, dicono, Abramo diseredò Ismaele padre nostro, e lasciò tutte le sue ricchezze al solo Isacco: egli è ben giusto che noi abbiamo la parte nostra , e se non ce la danno, noi abbiamo diritto di togliercela. — Ma Abramo visse tremila e cinquecent’ anni addietro — E noi, rispondono, viviamo ora, ed ereditiamo le ragioni dei nostri maggiori — Ti par ella buona risposta, Alfredo?
— Eh signor Edmondo, don Alessandro non è ignorante come gli arabi del deserto; ed egli non ha terminato il suo ragionamento, dov’ella m’ha interrotto; ma continuò provando che i Romani, anche perduta la signoria del mondo universo, proseguirono sempre a goderne i tributi, e maggiori eziandio di quelli che riceveano al tempo de’ Consoli e degli Imperatori.
— Sarei curiosissimo di vedere con quali argomenti don Alessandro s’ affaccenda di provare tale e tanta stranezza.
— E’ non v’è nulla di strano, ma tutto regge a capello colla prova de’ fatti, contro i quali non vai dialettica. Io accompagnava in quell’occasione alcuni gentiluomini stra nieri a s. Pietro, e v’era fra loro alcun protestante: don Alessandro ragionando con loro sotto il grande atrio della basilica, diceva — Considerate, signori, se la cosa non è com’ io vi diceva. Egli è vero, che dopo l’andata di Costantino da Roma, l’Impero a mano a mano fu assalito dai barbari e messo al niente; ma Roma è rimasta la Sede dei Successori di s. Pietro, e madre di tutte le chiese; laonde convenivano a Roma i Vescovi dell’Asia, dell’Africa, della Grecia, della Spagna e delle Gallie, e le chiese di quelle nazioni mandavano ricche offerte alle tombe dei Principi degli Apostoli. Que’ barbari stessi che sterminarono l’Imperio e desolarono Roma, venuti poscia alla conoscenza di Gesù Cristo, riconobbero Roma per madre e maestra, e fecero a gara di offerirle i ricchi tributi della loro sudditanza, della loro riverenza e del loro amore. Il clero e i poveri di Roma riceveano larghissime offerte dai Goti di Spagna, dai Franchi, dai Borgognoni e dai Normanni delle Gallie, dagli Angli e dai Sassoni della Bretagna, dai Turingi, dagli Svevi, dai Baioari e dagli altri popoli della Germania, dai Frisoni, dagli Sveoni, dai Danesi e dagli altri popoli della Scandinavia. Di più molti re birbari venuti alla fede misero ai piè del Principe degli Apostoli le loro corone, e costituirono i regni loro in feudo della Chiesa romana. Aggiungete che continuarono per molti secoli i pellegrinaggi alla tomba di s. Pietro, e da tutte le parti della cristianità giugneano in Roma re, duchi, langravi, conti, abati, vescovi ed arcivescovi con numerose cavalcate cariche di preziosi doni per le chiese, e di molta moneta da dispensare ai Romani.
Dopo che i Papi eressero l’impero d’Occidente, eccoti gl’Imperatori romani scendere d’Alemagna per farsi incoronare a s. Pietro, i quali spargeano tesori fra il popolo romano che applaudiva al loro trionfo. Sopravvennero i giubilei che condussero sempre alla città eterna migliaia e migliaia di cristiani per l’acquisto delle sante indulgenze, e fra questi aveanvi principi opulentissimi, che largheggiavano in beneficare questo popolo fortunato.
E qui don Alessandro che, come sapete, è un burbero faceto, mosse alquanto a riso la brigata, dicendo: Sorti poscia i protestanti, i quali esecrano Roma, il Papa, e i papisti, e fecero tanto baccano per non più pagare il denaio di s. Pietro, non tennero poi la parola; perocchè ora invece di pagare l’annuale denaio a Roma, le pagano gli scudi e le doppie. Da più di quarant’anni in qua cotesti signori tramontani hanno preso il vezzo di venire a svernare a Roma, e v’ha delle stagioni in cui se ne noverano da trenta e più mila. I Romani apparecchian loro i quartieri d’inverno pieni d’ogni conforto e d’ogni eleganza di tappeti, di cortinaggi, di vaselleria , di giardini, di loggette, di terrazzi, d’agrumi ne’ salotti, nelle camere, negli anditi e per le scale; e se non glieli fanno pagare a iosa non sia. Indi il denaio di s. Pietro si trabocca da costoro ne’ nobili cocchi, ne’ cavalli da diletto e da caccia, ne’ cuochi, ne’ donzelli, nelle stiratrici, nelle fioraie, negli scultori, ne’ pittori, ne’ musaicisti, negli incisori di cammei; e più che mai ne’ venditori di vecchiumi recenti; imperocchè cotesti signori comperano talora a gran prezzi bronzi antichi, gemme antiche, vasi etruschi, fatti ierlaltro nelle officine di via Condotti, del Babbuino e di Piazza di Spagna.
— Ah ah ah, quanto è malignuzzo il nostro don Alessandro, gridò Edmondo! Ben ci sta. Malediciamo Roma nelle nostre contrade, e poi veniamo a visitarla come gl’innamorati., e cotesta sirena che ci affascina colla melodia de’ suoi canti, ci divora poi co’ denti insino alle midolle dell’ossa.
— Vedete adunque se don Alessandro dicea vero, asseverando che i Romani continuarono sempre di ricevere i tributi di tutte le nazioni; laonde per essi il chiedervi le propine non è accatteria, ma requisizione d’un debito che avete con esso loro, e come di tale ve lo domandano con un’aria non di pitocco ma d’esattore: e avutolo, appena che vi ringraziano a fior di labbro.
— E tu hai ragione, Alfredo, essendoch’egli m’è avvenuto più d’una volta, dopo una visita, d’aver lo staffiere per la mancia, e datogli alcun paolo, dirmi netto e rotondo — Signore, mi si viene di più: questa non è la misura della propina di sala. — Ma la più preziosa mi capitò con alcuni amici, signori di gran conto, i quali per visitare un palazzo ov’ erano dipinture stupende, richiesero un decano di loro conoscenza, acciocchè desse loro una lettera pel custode di quel palazzo. Diella molto cortesemente, e andammo insieme a vederlo. Il mio amico presenta la lettera al custode, il quale era un uomo alto e tarchiato di poc’oltre ai trent’ anni. Il custode apre la lettera , e finge di cercarsi le tasche — Oh, disse, non ho gli occhiali! Vorrebbe aver la bontà Vostra Eccellenza di leggerla? — L’amico legge alto — «Vi raccomando sommamente questi nobilissimi Signori, mostrate loro tutte le rarità del palazzo, ben intesi, accettando le vostre propine. Addio». — Vedi astuzia! Costui temendo, non forse credessero quei Signori, che quella lettera di favore li dispensasse dalla mancia, misesi al sicuro facendola leggere col pretesto degli occhiali, a loro medesimi; gioco ordinario di cotesti custodi quando s’inviano l’un l’altro i forestieri.
— Coteste girandole si fanno per tutto altrove, disse Alfredo, e anco negli altri paesi s’abbocca ogni occasione di buscar denaro. Ma parlando di Roma, diceva don Alessandro, che cotesto grand’uso delle propine ha le sue fonti nella carità della Chiesa, la quale sino dai primi tempi, in cui i fedeli mettean tutto in comune, essa dividea le offerte ai sacerdoti, ai diaconi, ai cherici minori, alle vedove, agli orfani, ai pupilli, e alla plebe cristiana. Inoltre Roma è città sacerdotale, e però come le città dei Leviti al tempo degli Ebrei campavano delle decime, de’ sacrifizii e delle offerte di tutte le altre tribù, così anche Roma sede del sommo Sacerdote, e metropoli della Religione riceve il tributo dell’universo cristiano. Ma direte, che i Romani abusano di cotesto spirito materno della Chiesa, e non badano che a viver di ruspo; al che rispondeva don Alessandro: di che non abusan gli uomini? Non abusan forse più spesso che mai della misericordia di Dio? Or dee egli per questo asciugarsi il fonte delle divine misericordie? Saremmo spacciati se Dio la pensasse come gli uomini.
— Ho inteso. Anche tu facendoti cattolico bai bene appreso la logica de’ papisti, che tutto difendono colla carità; e dove noi usando della ragione gridiamo all’abuso, all’ingordigia, alla soverchieria, alla sciattaggine voi altri impennate l’ingegno a trasvolar le nuvole per internarvi negli abissi misteriosi della divina sapienza, che tutto dispone a saldezza e gloria della Chiesa romana, volgendo i difetti medesimi a materia de’ suoi trionfi.
— Che dubbio c’è? Noi cattolici non neghiamo i difetti degli uomini , ma consideriamo la virtù sovrumana che ispirò la Chiesa nelle sue istituzioni, nelle quali niun sano intelletto potrà giammai scerner macula od errore. Quando io era ancor protestante usciva spesso de’ gangheri contro i frati di Roma, i quali fanno elemosina ogni giorno alla porta e v’accorre un nugolo d’accattoni. Guarda, dicevo, come tutti cotesti cappucci sfaccendati, non paghi essi medesimi del non far nulla, avvezzano anche la plebe all’infingardaggine e al vivere scioperato!
Ma quando ebbi la grazia di ricevere il vivo lume della verità, m’ebbi a pentire altamente d’aver detto ingiuria a quelli che meritano altissimo encomio: imperciocchè vidi che appunto quei religiosi che vivon d’accatto son quelli che più abbondano in fare le scodelle alla porta. Allora mi ricredetti de’ Romani, che voi dianzi chiamavate ghiotti di mance e di propine, dicendo a me medesimo — Or chi mantiene in Roma tutti cotesti religiosi mendicami? Non è egli il popolo romano? E sono migliaia; e ogni giorno questo popolo generoso dà loro di che mangiare sì abbondevolmente, che dell’avanzo nutrono tanti poveretti.
— Benissimo, riprese stizzoso Edmondo, ma i frati essendo cosi larghi, avvezzano la plebe all’ozio, nè curasi di faticare, dicendo — a buon conto un pane e una minestra non mi mancherà alla porta de’ Cappuccini, de’ Passionisti, d’Araceli e di cento altri conventi di monache e di frati. Questa è un’indegnità insopportabile.
— Avete ragione. È meglio lasciarli morire di fame, come avviene non di rado nei nostri paesi: i Romani hanno il torto di non volere che niuno muoia di fame e d’inedia : esigono le propine e le mancie dai forestieri, ma ne trasfondono buona parte ne’ poverelli, non solo per mezzo de’ frati, ma per cent’altre guise, che bisogna essere da lunghi anni in Roma per conoscerle, ed ammirarle. Un nostro paesano di cospicua famiglia cattolica, il quale venuto a Roma volle rendersi religioso mi diceva; che essendo novizio a sant’Andrea al Quirinale, usciva spesso per Roma ad esercizio d’umiltà e di carità colle bisacce in ispalla a chiedere l’elemosina pei carcerati. Signor Edmondo, io son certo che voi, di sì bel cuore e grande come siete, non avreste potuto tenere le lacrime per tenerezza a udirlo narrare le prove segnalate della generosità romana. Mi descriveva le rivendugliole e le erbaiole di piazza Navona sedute ai loro deschetti o a’ loro canestri, cosi attose, cicaliere, ardite, le quali mentre gridavano a gola — Oh le belle pere! le belle mele! com’è bianca l’indivia! — al vedersi comparire innanzi quel religioso giovinetto e verecondo a occhi bassi, cessavano dal gridare, e diceangli — Per chi domandate? — Pei carcerati — Eh poveracci, Dio li consoli: pigliate — e messa la mano nel paniere, davangli quando mele, quando pere, quando noci, quando castagne, o pesche, o susine, o un poponcello, secondo stagione; intantochè usciva di piazza Navona colle bisacce piene di frutte, di lattughe, di rape, di cavoli fiori e cavoli cappucci.
In piazza della Rotonda fattosi a’ banchi de’ camangiari, chi gli dava una fetta di formaggio, chi due provature, chi un tocco di ganascia in soppressa, chi un arancio e chi un limone , e chi due grossi pomi di terra e chi persino una bona fetta di polenta. I fornai e i panattieri lavangli quale un pane e qual due: i granaiuoli porgeangli un cartoccetto di riso, di lenticchie, di fagiuoli, di ceci o di fave. Ma il più bello si è, agli agnellari, ai caprettari, ai friggitori, a’ tavernai, ai venditori di selvaggina, ai macellatori de’cignali, de’cervi, de’ cavrioli, i quali essendo in grembiule metton la mano nelle loro tascozze, fattele alquanto sonare, cercano fra i giuli, fra i paoli, fra i grossetti il baiocco, e gliel gittano con faccia serena nella bisaccia.
Pure gli osti sono sempre acconci a offrire il loro baiocco; ed è bello il vedere quelle ostesse membrute che paion Cibeli in trono, le quali vedendo quei novizietti così modesti, dicon loro — Eh vo’ altri che siete principi e gran signori (lo sapemo, sapete?) beati voi che annate a domannà l’elemosina pei poveri carcerati, annate: eccove er baiocco, che Dio ve benedica. — Anco quelle macellare gigantesche, rubiconde e solenni, non sì tosto veggono entrare i novizi, aprono il cassettino e mettono nella bisaccia: ovvero si fa innanzi il macellaro col suo camiciotto bianco insanguinato, col suo acciarino a cintola, e con quel suo faccione carnoso; butta la mannaia sul ceppo, sale al banco, e senza dir motto dà il suo obolo, e si rimette al ceppo.
In somma narravami quel religioso , che eccetto forse qualche magazzino di mode, di galanterie, di stampe, o qualche caffettiere, o qualche crestaia, non v’è fondaco in Roma, non v’è bottega, non v’è bancuccio di trecca o di ferravecchi che non dia un po’ d’elemosina pe’ carcerati : e danno il mezzo baiocchetto insino a quelle vecchierelle ch’hanno un panieruzzo di nocciuole, e che nel darlo domandano i numeri del lotto, dicendo — Vo’ che siete religiosi di Dio fateme buscà ‘n ternetto, chè pozza paga la pigione, e vestì er mi nipotino ch’è guitto e gnudo.
Oh io vi domando, se voi, signor mio, che avete corso tanta Europa, trovaste mai popolo più nobile e generoso del cittadino romano? Egli non è alieno dagli umani difetti, ma chi ben lo considera, vede che le virtù li soverchiano di gran lunga; e gli stranieri, che vistolo appena in profilo, ne scrivono poi le sbardellate menzogne, oltre averne il torto grandissimo, si fanno compatire alla gente, che dà loro la baia.
L’INDIFFERENZA DE’ ROMANI
Intanto che Edmondo, alquanto rinsavito per le calde esortazioni d’Alfredo, spogliasi delle vestimenta non sue, e la Nunziatina attende a guarire, non si potrebb’egli fare una cortesia al signor Achard dandogli una lezioncella intorno a certe condizioni dell’indole romana, che per lui sono un arcano profondo, e quando studiasi di penetrarlo dice corbellerie strampalatissime? Noi siamo persuasi, che parecchi di voi gradireste di molto ch’egli ne fosse chiarito e l’avreste per una bell’opera di misericordia. E noi dunque all’opera.
Il signor Achard fece una corsa rapidissima fra noi nello scorso Giugno e l’intitola: Un mese in Italia; nel qual mese potè fare, come ognuno vede, studii profondissimi sopra quanto vide da Genova sino a Napoli; e parlare per apoftemmi della natura, dell’indole, delle costumanze, delle virtù, de’ vizii, delle inclinazioni e delle avversioni di quelle genti, e potè giudicare eziandio dell’esterno e dell’interno delle città, ch’egli considerò squisitamente e giudicò senza appello. Pensate! Il suo gran principio d’esame si è, che il correre come un can da caccia le vie d’una città è l’unico mezzo di penetrar l’indole e la fisonomia de’ luoghi, cogliendone il fiore. Egli l’ha còlto sì bene, che per lui i sontuosi palazzi di Genova non sono che gran quadrati di marmo ornati di grotteschi bizzarrie fregi barocchi ; alcuni di cotesti palazzi furon giocati in una notte da quei scialacquatori di Genovesi, come il palazzo Imperiali, e il palazzo di Domenico Spinosa (sic) vintogli dal marchese Serra. Vedete notizie di gran momento!
Se tanta erudizione squadernò sopra questa reina del mediterraneo, ov’ egli stette poc’ore, figuratevi che dirà di Roma, ch’egli potè scrutare per ben dieci giorni e di vantaggio! Di già appena entrato a gran notte (venia da Civitavecchia), la trovò un sepolcro, e non v’udì rompere il ferale silenzio, che il canto de’ galli, il belato delle capre e i ragli d’un asino. Di poi la mattina vegnente, appena uscito di casa, prese in uggia il luccicore dei marmi, che gli abbacinaron gli occhi, e pensò bene di chiuderli; onde a chius’occhi egli non vide in Roma, che un ammasso di casipole scagliate da un Titano briaco e cadute alla rinfusa tra le falde del Campidoglio e il fiume del Tevere; e se per caso, aprendo gli occhi, s’accorse di qualche solenne palagio de’ Principi romani, vide in mezzo a sfolgorate ricchezze antiche ond’eran piene le sale, che i pavimenti erano smattonati, che qui e là cadea scalcinato qualche riccione di stucco, e i loggiati avean la muffa. Vuoi vedere che costui prese i palazzi di Cimara e di Sora (quartieri de’ soldati) pei palagi di Borghese e di Doria? Di più egli non vide per Roma che dormienti, e il silenzio diurno pari a quello della più profonda notte. Se cotesti dormienti camminano, son tutti coperti di cenciume rattoppato: le nostre popolane poi perdono i brandelli delle vesti: si lavano una volta l’anno; si pettinano per Natale e per Pasqua; e le ciabatte che trascinano sono l’eredità di tre generazioni : per il che se vedete una popolana ben vestita, ben pettinata, in calzaretti, coi pendenti agli orecchi, colle anella in dito, coi vezzi d’oro al collo — Dite pure, scrive monsieur Achard, dite pure ch’ell’è un Modello da pittori — Poffare! il luccicore de’ marmi, l’ha proprio abbacinato davvero; altrimenti di coteste Modelle ne troverebbe a migliaia , massime le feste, poiché sono le popolane di Roma che passeggiano pe’ Monti e per Trastevere; e noi le diciamo Minenti appunto per l’eleganza e lo sfarzo del vestire.
Se non che sì fatte cenciose scarmigliate e in ciabatte, si tramutano sotto la sua penna, indi a poche pagine, in tante imperatrici. «Le donne dei borghi di Roma, egli scrive, hanno portamento ed atti d’imperatrici, al che dice non poco la saldezza dei loro profili che hanno talora dello statuino e del marmoreo. Puoi riguardarle a tuo’ bello e grande agio ch’elle non ti leveranno mai gli occhi in viso: nè abbilo per timidezza dal lato loro: no; ell’è indifferenza. Credilo, ogni civetteria è impossibile a coteste figlie di Roma» — Oh bene! lodato Dio, che pur l’onestà romana ha trovato il suo ammiratore, il quale in un giornale così solenne, la testimonia sì altamente a Parigi, alla Francia e all’Europa intera! Questa indifferenza de’ Romani l’ha proprio ferito sul vivo il signor Achard, e vuol spiegare cotesto arcano con tali
Bazzecole, arzigogoli e ciammengole,
direbbe il Bonarroti, ch’è una compassione a udirlo. Egli cominciava il suo ragguaglio del 4 settembre, dicendo: «V’ho detto che il silenzio e la gravità sono i due principali caratteri del popolo romano: se ne potrebbe aggiungere un terzo, ch’è l’indifferenza, se pur essa non vince i due primi». E sapete com’egli la spiega? Coll’immobilità, la quale va a terminare in una morte assoluta, che fa di Roma la tomba della vita.
Noi invece portiamo altra opinione, e non crediamo che l’indifferenza del popolo romano sia cagionata dall’immobilità e dalle altre cipollate, che ci mette innanzi il signor Achard, condite con più pepe che sale per movere a ghigno i Parigini. Dicono i filosofi che l’ansiosa curiosità è figlia dell’ignoranza, e l’indifferenza proviene da sazietà: ora se il popolo romano non si briga e non s’affaccenda di correre a vedere le novità, è segno manifesto che per lui non è nuovo ciò che desta meraviglia negli altri, e li fa agitare bramosamente, e accalcarsi e premersi per giugnere ad appagare la pungente curiosità.
Il popolo romano nasce nella grandezza e vien nutrito nella magnificenza: appena egli apre gli occhi si mira circondato da quanto è più nobile e sublime sulla terra, e questa sublimità ed eccellenza l’accompagna sino al sepolcro. Sin da giovinetto la madre nelle ricreazioni festive lo conduce nel Foro Romano, ove le prime impressioni che attraggon l’animo suo sono la vista del Campidoglio, delle ruine del palazzo de’ Cesari, delle maestose colonne de’ templi ritte ancora su’ loro piedestalli, dell’Arco di Tito, dell’Arco di Settimio Severo, dei fastigi di quegli arconi della Basilica di Costantino, sotto i quali i garzonetti romani giocano alla poma, alla palla e a lanciare in alto le selci.
Più sotto veggono le ruine dei templi di Venere e Roma con quei gran fusti di colonne che ne formavano il portico; e scendendo lungo le celle militari del Palatino, si scorge innanzi quel monte rotondo, ch’è il Colosseo, girar severo ed eccelso sopra i suoi archi e rinchiudersi in seno tanti cunicoli, tanti ambulacri, tante vòlte che sostengono tanti scaglioni e danno adito a tanti sfogatoi, per onde, come gonfio torrente, traboccava la plebe romana a mirar gli spettacoli dell’arena. Gli scheletri di quei gironi, i diroccamenti di quelle vòlte, le altezze di quei macigni campati in aria, i vani di quegli archi che s’incavalcano gli uni sopra gli altri, subliman l’animo dei garzoni romani a maravigliosi concetti di grandezza e maestà inestimabile. Il teatro di Marcello, i Mausolei d’Augusto, d’Adriano, di Cecilia Metello ; la piramide di Caio Cestio; gli obelischi; le lunghissime fughe degli antichi acquedotti; il Circo Massimo, il Circo di Caracalla, il Foro Traiano, il Panteon, il tempio di Vesta, il tempio d’Antonino, e mille altri avanzi della magnificenza de’ Cesari, accrescono nella mente della plebe romana l’ampio corredo delle nobili cogitazioni.
Ma forse nulla induce a validare nel Romano l’inesplebile fame di grandi cose, come la vista delle terme di Diocleziano, di Tito e di Caracalla. Il Romano spazia per quelle sale sterminate, gira per quelli emicicli, per quelle palestre, per quei tepidarii, per quelle essedre, ne misura gli spazii, ne stupisce le altezze, ne vagheggia gli archi, i portici e le colonne: tutto lo rapisce ed innalza, tutto gli addoppia in sè medesimo l’animo altiero, e inducegli disprezzo di quanto non vegga comparabile alle immortali gran dezze che lo circondano.
Il Romano scorre per sue le munificentissime accolte de’ musei vaticani, capitolini e lateranesi; entra nelle stanze di Raffaello, di Michelangelo, di Giulio, del Dominichino, dell’Albani e di Guido Reni, e in mezzo a quei portenti procede a capo alto e ad occhio sicuro siccome in casa sua propria; perocchè tanta dovizia di statue greche e di pitture romane, che adornano i palazzi pontificali, egli le ha per cosa di suo retaggio, e come di tale se ne compiace; appunto in quella guisa che un nobile signore gode in vedere che i forestieri vengono nelle sue gallerie e ne’ suoi giardini per istudio e ricreamento dell’animo.
E ciò rispetto ai monumenti dell’antica opulenza e maestà di Roma ne’ secoli della repubblica e dell’impero. Che se noi consideriamo la Roma cristiana, il popolo romano ha continuo sotto agli occhi tanta magnificenza di gloria, a cui niuna città del mondo è mai pervenuta, e non potrà mai pervenire. I fanciulli di Roma beono la grandezza e la maestà cogli occhi insino dalla puerizia, od entrino in Laterano, o in Santa Maria Maggiore, o nella Basilica Trastiberina, o in Santa Maria degli Angioli, o in sant’Andrea della Valle, o in sant’Ignazio, o in s. Carlo o alla Vallicella, o in cent’ altri augusti templi di Dio e de’ suoi Santi: ne’ quali gareggiano fra loro i pregi dell’architettura, della scultura, della pittura, delle vòlte dorate, delle colonne di finissimi marmi, de’ bronzi, degli ori, degli argenti e delle pietre preziose. Quand’entrano poi in s. Pietro in Vaticano hanno sotto gli occhi un mondo di meraviglie , in cui la maestà contende colla ricchezza, e più si guardano intorno e più l’anima si dilata e grandeggia.
Le quali cose vedute in Roma non riguardano che i materiali edifizii, gli ardimenti delle cupole, la sontuosità de’ portici e delle facciate, la sublimità delle interne elevazioni, l’ordine delle colonne, la sveltezza degli archi, li sfondi delle crociere, la eleganza degli ornamenti, la dignità degli altari, la copia delle statue, la maestria delle dipinture sovrane delle vòlte e delle navate, che riempion l’anima de’ Romani d’amplissimi e nobilissimi affetti. Ma se noi ci volgiamo a considerare il culto e i riti della religione, che spiegano sotto l’occhio de’ Romani tutta la pompa e la santità del loro dominio, dovremo argomentare quanto il popolo della città eterna dee informare il cuore e la mente a sovraeminenti concetti di grandezza. Il popolo romano non accamperebbe le maestevolissime feste delle sue Basiliche ai regii fasti di qualsiasi corte imperiale; perocchè la sola entrata del Sommo Pontefice in s. Pietro, portato sulla sedia gestatoria, non avvi maestà in terra che possa appareggiarla di gran lunga. Il Papa siede sopra un trono maestoso col triregno in capo, e coperto da un amplissimo manto di drappo d’argento a onde che gli scende insino ai piedi. Lo sollevano in ispalla dodici robusti portatori in zimarra di seta vermiglia aperta nel dinanzi e colle maniche a sgonfi; e procedono anteceduti dalle guardie svizzere, vestite d’elmo e d’ usbergo d’acciaio co’ lancioni in ispalla.
Sopra la gran loggia sono i trombieri, i quali nell’atto che il sommo Pontefice genuflette dinanzi al santissimo Sacramento, improvvisamente danno fiato alle trombe, le quali fanno echeggiare le immense volte della Basilica con un rimbombo cosi solenne, che la calca infinita si sente correre un santo ribrezzo per l’ossa, mirando innalzarsi di nuovo l’augusto Gerarca e procedere fra l’aleggiar dei flabelli, e benedire dall’alto il popolo genuflesso. La croce in asta va innanzi al trono, il quale è circondato dalle alte dignità della Corte, e seguito da un gran numero di prelati; ma a quel primo clangor delle trombe, a quel primo apparire di sì reverendo e ammirando sembiante, non v’è cuore sì freddo e scredente che non batta più vivo siccome a una divina visione; nè v’è capo che non s’inchini, nè ginocchio che non si pieghi, nè orgoglio che non si abbassi. I protestanti medesimi confessano, che Dio non può essere rappresentato in terra più nobilmente e molti si trovano prostrati contra ogni loro antecedente risoluzione, e si sentono cadere involontariamente le lacrime dagli occhi. Ci narrava Lady Ranelagh, che il suono di quelle trombe, e il venerabile aspetto di Gregorio XVI , che incedeva in s. Pietro nella sedia gestatoria, furono per lei come un lampo di Dio che l’abbarbagliò, la fe’ cader vinta a ginocchi, e rizzandosi si sentì cattolica: cercò d’un prete che l’ammaestrasse, e non ebbe posa sinchè non fu accolta nel grembo di santa Chiesa.
Pur tuttavia nulla può compararsi al sovrano spettacolo del gruppo del Papa nella processione del Corpus Domini. Bisogna dapprima immaginarsi quella gran piazza del Vaticano, quel maestoso portico di s. Pietro, quelle gallerie vestite d’arazzi, quel sublime colonnato che a quattro colonne appaiate circonda il cerchio di quell’amplissimo spazio; bisogna figurarsi di vedere andati innanzi a schiera a schiera tutti gli Ordini religiosi, tutt’i cleri di Roma, tutti gli ordini de’ magistrati, de’ prelati, de’ Vescovi, degli Arcivescovi, de’ Patriarchi e del sacro collegio de’ Cardinali in ricchissimi paramenti: poscia i drappelli di cavalleria greve con bellissimi destrieri morati; tutte le guardie nobili a cavallo; e alla fine le guardie svizzere in corazze ed elmetti lucidissimi colle sottovesti a divisa modellate dal sommo Michelangelo Bonarroti.
Dietro tutte queste magnifiche antecedenze procede il Santissimo Sacramento, sotto un gran baldacchino di broccato d’oro, le cui aste sostengono dodici patrizii romani. La divina Ostia è chiusa in un ostensorio d’oro posato sopra un piedestallo sostenuto e portato dai sediari del Papa, e co verto d’uno splendido conopeo; e dinanzi a lui sta in atto di genuflesso il Sommo Pontefice in un gran manto di tocca d’argento, che collo strascico scende insino all’orlo del trono gestatorio. Il Vicario di Cristo col capo umilmente inchino, e coll’occhio fiso nel suo Dio, che a trionfo d’amore riceve le adorazioni del popolo redento, desta nei riguardanti un senso di sì profonda riverenza e di sì celeste ammirazione, ch’è spettacolo il più sublime che gli uomini e gli angeli possano veder sulla terra. Tutta Roma v’accorre ogni anno e vi conduce i suoi figliuoletti, nel vergine animo dei quali s’imprimono le idee d’una grandezza, che niun popolo del mondo può ricevere altrove che in Roma.
A tutte queste cose si aggiungano le funzioni delle cappelle pontificie, che attraggono a vederne la maestà tutte le genti delle più lontane regioni, il Romano si trova fra tanta magnificenza di cerimonie, fra tanta melodia di voci, fra tanta ricchezza di addobbamenti, fra tanto splendore di faci, al cospetto del Pontefice Massimo, dei Cardinali in porpora, dei Vescovi seduti, come altrove gli accoliti, sui gradi del trono pontificio, e per giunta ha sotto gli occhi nella Cappella Sistina quelle portentose vòlte dipinte da Michelangelo, e quel terribile prospetto del Giudizio Universale, che più si mira e più riesce stupendo e impenna l’anima a spaziare nell’infinito.
Che se volgiamo il pensiero alle meste e sublimi funzioni della Settimana Santa che si celebrano in Vaticano, il popolo di Roma ha nuove immagini che gli sollevano il cuore a grandezza. Ei vede il Vicario di Cristo operar in figura di Cristo medesimo i divini ministerii della redenzione del mondo con atto cotanto umile e dimesso, che eccita compunzione nei petti anco ferrei e adamantini. La lavanda dei piedi, che il santo Padre fa il Giovedì Santo a dodici poveri sacerdoti nella Basilica di s. Pietro, v’attira in calca i Romani e le molte migliaia di forestieri, che convengono in Roma per assistere a quei sacrosanti riti. I dodici sacerdoti vestiti di bianco si veggono innanzi il Sommo Pontefice collo sciugatoio in mano, venire a uno a uno e inchinarsi a lavar loro i piedi e asciugarli con una carità ed amorevolezza tutta paterna. Indi rizzatosi sale, seguito dai Cardinali, al sovraportico della Basilica, ove i dodici apostoli vengono alla cena pasquale; ivi Egli intuona il Benedicite, e come tutti sono seduti a tavola, il Papa si cinge il suo zinnaletto, e mettesi in acconcio di servirli aiutato dai Cardinali e da’ Principi e Sovrani che per avventura si trovino in Roma. Il Pontefice pone innanzi a ciascuno i messi, leva loro i piattelli, versa loro a bere, e li serve in tutto come valletto, con una umiltà e divozione che move a pianto le dame e i cavalieri che assistono a quella tenera cerimonia.
Il Giovedì Santo, in mezzo a tanta mestizia, il popolo romano, visitando il santo sepolcro nella Cappella Paolina, si trova di tratto in un paradiso di luce. I Romani ascendono per la scala del Bernini nel palazzo vaticano (ch’è grandiosissima e illustrata da molte lumiere) alla cosi detta sala regia, la quale forma il più bell’atrio del mondo alla Cappella Sistina e alla Paolina; ed entrando in questa, rimangono oppressi da’ un mare di luce. Imperocchè sopra i disegni del Bernino fu rizzato un altissimo altare tutto di cristallo a faccette, a tavole, a punte, a gocce, le quali rifrangono e riflettono a mille doppii i lumi, che a parecchie centinaia illuminano le vòlte, le pareti della cappella e i gradi dell’altare, entro i quali è posto su in alto il santissimo Sacramento in una urna di cristallo. Chi ha queste magnificenze ogni anno sotto gli occhi non degna più d’uno sguardo anco ciò, che agli occhi de’ forestieri sembra cosa di gran momento.
A queste meraviglie s’aggiunse quella che travalica ogni concetto, ch’è la benedizione Papale di Pasqua: e il Romano che la riceve ogni anno, è vieppiù mosso che mai alle magnitudini che informangli la mente e ne fan l’animo grande. Comincia il popolo di gran mattino a condursi alla piazza di s. Pietro, e scorgevi pervenire le carrozze de’ Cardinali messe a gran pompa di livree e di bardature dorate. Diamo abitanti in Roma soltanto quaranta Cardinali, chè ve n’ha spesso di più, ed ecco almeno ottanta carrozze e censessanta cavalli morati di gran podere e di gran persona. Vienvi il Senatore di Roma con tutto il corpo de’ Conservatori in isplendide vestimenta e numeroso corteggio di carrozze e staffieri a divisa: almeno cento Prelati in carrozze da festa: i Principi e Patrizii romani in cocchi dorati e nelle nobili assise de’ loro casati: gli Ambasciatori e Ministri delle corti sovrane in grande sfoggio di livree e di cavalli. Quasi ogn’anno avvi Re e Reine di corona, che vengono allo splendore di quella festa col seguito di molte carrozze. Per ultimo migliaia e migliaia di signori forestieri, venutici da tutti i regni d’Europa; e se vi recito che giugneranno quella mattina oltre a due mila carrozze quelle che si schierano nella piazza di s. Pietro, non l’abbiate per amplificazione.
Tutte le milizie pontificie della guarnigione di Roma si schierano in gran parata da un lato e dall’altro dell’obelisco della piazza. Ora che v’è anco la guarnigione francese, vi si schiera anch’essa da un altro lato: colla fanteria s’aggiugne la cavalleria, e a quella l’artiglieria di Castello, che vi conduce tre batterie di cannoni con tutti i cassoni della polvere e delle palle, ciascuno tirato da sei cavalli , le quali serrano il retroguardo. A tutte queste cose forma una profonda cornice d’intorno il popolo romano colla folla traboccante de’ forestieri e dei foresi, venutivi da Monte Porzio e da tutte le terre dei monti laziali, che in tutto eccederà le sessanta migliaia: cotalchè in quella piazza e fra il giro di quei portici sterminati si conchiude una grande e popolosa metropoli.
Al comparire, sul loggione del portico di s. Pietro, il Papa col triregno in capo, e sostenuto nella sella gestatoria, quel mare di popolo si spiana, s’abbonaccia e più non s’ode un respiro. La sedia pontificia procede lentamente all’orlo del davanzale, e il Papa s’arresta un istante a riguardare quell’infinita accolta di gente, che tutta ha rivolti gli sguardi in lui solo. Si legge da un Prelato la Bolla delle indulgenze; finita la quale, il Sommo Pontefice alza gli occhi al cielo, solleva le braccia in alto, e intona le parole della benedizione. A quell’atto augustissimo tutti i popoli in un attimo sono prostesi al suolo in atto d’adorazione profonda; nè v’è incredulo od infedele, che non si senta conquiso da una forza celeste che l’atterra. In quel momento ogni cuore è cattolico, ogni occhio vede nel romano Ponteficie il Vicario di Cristo, che benedice in suo nome i popoli redenti. Chi si trova una volta a quel sublime spettacolo non lo dimentica più in vita sua; il Romano che v’assiste ogn’anno sino dalla sua giovinezza si stupirà oggimai di qualunque grandiosità gli possa cadere sotto la vista?
Ei guarda e passa, signor Achard, come interveniva quando voi passeggiavate forse coll’occhialino le vie di Roma. Or giudicate voi se la cagione dell’indifferenza, che voi leggevate nei volti de’ cittadini e delle donne di Roma, è causata dall’immobilità ch’è in un popolo spegnimento di vita. Ci trovereste voi città, in grazia vostra, ov’abbia maggior vita che in Roma? Ove la varietà, la grandezza, la magnificenza e la maestà sieno cosi comuni, che il popolo l’attinge largamente e se ne pasce con suprema abbondanza? Uomini di questa fatta non istupiscono più di nulla : che li stupori sono de’ piccioli cuori e meschini ; il perché dice Dante:
Non altrimenti stupido si turba
Lo montanaro, e rimirando ammuta,
Quando rozzo e setvatico s’inurba.
(Purg. CXXVI)
I cuori grandi o non si recano a meraviglia le cose ordinarie, o se incontra loro alcuna cosa che gli attragga, vien meno ben presto in essi lo stupore.
Lo qual negli alti cuor tosto s’attuta. (ivi)
Qui potremmo cessare di chiarirvi intorno alle cagioni dell’indifferenza del popolo romano ; ma perchè n’andiate persuaso viemeglio e conosciate appieno il grave errore in che avete dato di cozzo, vi preghiamo che vogliate arrogere al sin qui detto molt’altre fonti, che alimentano nel petto de’ Romani quel sentimento di grandezza, il quale voi giudicate superbo disdegno di novità, che riesce in una fredda indifferenza, somigliante al sonno e alla morte. Il che non è però vero; amando assaissimo li Romani di vedere le magnificenze che s’attengono alla religione , le quali sole generano la vera grandezza degna dell’uomo. Indi vedrete sempre quel popolo accorrere studiosamente ove alcuna gran festa si celebri, e prendervi parte caldissima, e goderne, e letificarsene e tripudiare. Bisogna trovarsi in Roma al tempo de’ Conclavi, e vedere se quel popolo esce d’indifferenza, e va e viene e interroga e s’accalca sotto le finestre del Quirinale! All’elezione poi del nuovo Papa, i Romani traggono giubilanti a quelle sontuosissime feste dell’incoronazione in s. Pietro, e del possesso in s. Giovanni Laterano, che adombrano i divini trionfi.
Sono splendide le descrizioni che leggemmo dell’incoronazione di Carlo X a re di Francia nella cattedrale di Reims, di quella dell’Imperatore Ferdinando I d’Austria colla Corona di Ferro a Milano, di quella dell’Imperatore Alessandro II, autocrate di tutte le Russie, avvenuta pochi anni sono in Mosca; ma niuna di queste è comparabile colla dignità, colla maestà, colla santità della coronazione d’un Papa, fatta nel più gran tempio del mondo. Nelle prime vedete i Re della terra circondati della maggior gloria terrena, in questa vedete il Vice Dio in tutto lo splendore della gloria celeste. Noi siamo sicuri, che se il signor Achard si trovasse in Vaticano ad assistere a una incoronazione di Papa, sarebbe tale e tanta la sublimità dei sentimenti che investirebbero l’animo suo, da rendersi poscia indifferente alla vista di qualunque altra magnificenza; sicchè, tornato a Parigi, gli amici gli griderebbero in capo l’indifférence est ton caractère.
Ma in Roma v’è una magnificenza ancora più solenne, e tale che maggiore non si può vedere che in paradiso; e questa si è la festa che fassi in s. Pietro per la santificazione degli amici di Dio beati in cielo. Non è lingua d’uomo che potesse dire le mirabilità di quel trionfo della Chiesa militante, che plaude per la prima volta in terra alla gloria de’ Santi. La Basilica di s. Pietro è tutta messa a ricchissimi e nobilissimi addobbi d’arazzi, di damaschi, e di velluti a grandi ricascate dagli archi e dalle vòlte di quelle sontuose cappelle. Sopra la cattedra di s. Pietro rizzasi un maestoso nuvolato sfolgorante di luce, in mezzo al quale è l’immagine del santo ricoperta tuttavia di un candido velo, che la toglie alla vista dell’infinito popolo accorso a venerarlo. Da tutti gli archi pendono centinaia e centinaia di lumiere di cristallo piene a più giri di accesi doppieri.
Il sacro senato de’ Cardinali, gran numero di Vescovi, d’Arcivescovi e di Prelati della Chiesa Romana, in tutto lo splendore de’ loro sacri indumenti, assistono alla lettura delle bolle della Canonizzazione: terminata la quale, e dichiarato ce predicato Santo a nome della Chiesa di Cristo quell’uomo, le cui eroiche virtù sono testificate da Dio coi miracoli operati in vita e dopo morte, si toglie immantinente il velo che ne ricopriva l’immagine. L’infinito popolo, che si trova presente, cade sulle ginocchia per venerarlo e chiedergli grazie; s’intuona il Te Deum alla piena armonia degli organi: le campane suonano, le artiglierie rimbombano, Roma saluta un nuovo Santo del paradiso.
Eccovi, signor Achard, l’immobilità di Roma che, a detta vostra, ingenera l’indifferenza del popolo, il quale, passando voi curiosamente per le sue vie, non vi guardava con occhio ammirativo, e le sue donne non vi faceano il visetto e i sorrisi. Cotesto popolo appena che fissi gli occhi negli augusti sembianti dei Re e delle Imperatrici che cosi di sovente vengono a Roma o per visitare le sue magnificenze o per farvi loro dimora: egli non v’ha forse Re in Europa che oggimai non vi ci sia condotto; e talvolta se ne trovano più d’uno a un tempo, come due anni addietro vi soggiornava l’Imperatrice di Russia, la Regina Maria Cristina di Spagna, il Re di Baviera, il Principe ereditario di Vurtemberg colla Principessa Olga sua sposa, il Principe di Sassonia e il Conte di Siracusa, ciascuno colle sue corti.
Il popolo di Roma ha poi li suoi Principi, i quali benchè ora non abbiano Stati, come per lo passato, tengono però vita reale: chè nei loro palagi emulano invero i Re incoronati. In qual metropoli d’Europa trovate voi Prìncipi e signori privati, che abbiano palagi sì ricchi di biblioteche, di statue antiche, di pitture de’ grandi maestri, di marmi preziosi e di sculture del buon secolo dell’arti come a Roma? Ove trovate voi l’Aurora di Guido della sala del principe Rospigliosi? il trionfo della Gloria di Pietro da Cortona nella sala del principe Barberini? il trionfo di Bacco d’Annibale Caracci nella sala del palazzo Farnese? ll passaggio dell’Eritreo dell’Albano nella sala del Duca Mattei? I dipinti del Salviati nel palazzo del Marchese Sacchetti? Ove i freschi di Raffaello, di Giulio Romano, di Sebastiano dal Piombo, del Volterrano, di Giovanni da Udine, del Fattoricchio, del Penni, del Colle, di Gaudenzio (nomi immortali!) che adornano le volte d’un solo palazzetto d’ Agostino Chigi, che fu poi detto la Farnesina? Ove le dipinture di casa Costaguti, in che primeggiano gli ammirandi pennelli del Domenichino, dell’Albano, del Guercino, del Cesari, e del Lanfranco? In qual reggia trovate voi le Gallerie del Principe Borghese, del Principe Doria, del Principe Colonna, del Principe Corsini, del Principe Spada, del Principe Sciarra Colonna, del Principe Ruspoli, del Principe Barberini, del Principe Massimi, nella cui sala ammirarsi il Discobulo che ti rammenta Mirone, e i freschi delle Terme di Tito, e li stupendi musaici antichi? Nè vi parlo di tutte le bellezze delle arti antiche e moderne di tutti i palazzi romani, che non è sì agevole il neppur toccarle di volo; e il popolo romano a certi giorni e a certe occasioni le vede, le giudica e se ne gioconda.
Non ho ancora discorso delle ville de’ nostri Principi, che sono in Roma o ne’ suoi dintorni; non della villa Lodovisi ch’è un emporio di statue greche e di pitture dei più eccellenti maestri; non della villa Massimi, della Altieri, della Gaetani, della Lante, della Mattei, della Strozzi, della Bonaparte, della Borghesi, della Albani, della Panfili, della Torlonia e di molte altre, nelle quali tutte avvi musei, gallerie, dipinti a fresco de’ sommi dipintori della scuola romana, e bellezze d’arte e di natura che sono lo stupore del mondo. E per queste ville passeggia il popolo romano, e innanzi a quelle statue, a quei busti, a quei bassirilievi (un solo dei quali potrebbe formare la gloria d’un palazzo reale) questo popolo fissa gli occhi avvezzi al bello e al grande, e ne discorre i pregi e ne commenda l’artifizio: e mirando quei miracolosi a freschi, dice risoluto: Questo è di Michelangelo; questo è di Raffaello, questo è dì Giulio Romano, del Caracci, del Domenichino, dell’Albano e di Guido Reni.
Oh il mio caro signor Achard, e voi cascate dalle nuvole, perchè il popolo romano procede per le vie con una certa aria d’indifferenza! Io vorrei pur credere che oggimai n’avrete scorto le intrinseche ragioni, e voi sarete convinto, ch’egli sarebbe anzi da stupire di molto, se popolo sì fatto mostrasse un’aria sollecita, curiosa e investigatrice di quanto gli si para dinanzi agli occhi. Che se per avventura non ve ne foste reso ancora capace, mostrerovvelo con un paragone, che finirà di persuadervene appieno.
GASPARETTO
Sopra un altissimo sprone di monte, che tra le città di Forlì e di Cesena si spicca repente quasi a baluardo degli apennini, l’Imperatore Federico Barbarossa edificò una gagliarda ròcca, la quale a quei dì era inaccessibile ad ogni assalto. Sott’essa a mano a mano muraronsi alcune case, le quali crescendo per tutto il girone del monte, ne surse la città di Bertinoro, ov’erasi accolto nel secolo XIII il fiore della gentilezza d’Italia. Quella ròcca fu per lungo andare di tempi il fiero ostello di molti grandi baroni di Romagna, sinchè dopo le lunghe guerre della Chiesa contro le citta dell’Emilia, ch’eransi rubellate al suo dominio, vinti e spenti i tiranni che le signoreggiarono, la ròcca di Bertinoro divenne la sede ordinaria de’ Vescovi di Forlimpopoli e Bertinoro. Questo sublime castello ha fuori della sala uno spazioso terrazzo, il quale da quell’altezza scorge le più vaghe e distese prospettive che mai occhio umano potesse accogliere in un solo girare. Imperocchè dal lato di mezzodì s’addossa agli aspri gioghi degli apennini, i quali s’aprono in isfondi cupi di valloni e di gole e di profondissime spaccature, che muoiono a piè d’erte e di balzi scheggiosi, di terribilissimi scogli accavallatisi gli uni sopra gli altri, a guisa di torrazzi e guglie e denti rugginosi ed aguzzi. Quelle schiene selvatiche, quei burroni inaccessi, quegli aggiramenti d’alpe che s’internano, che s’intercidono, che s’interchiudono a vicenda, ergendosi e montando sino alle nubi e divallando sino agli abissi; quel fracasso delle cascate, col mugghio de’ venti, col rimbombo delle fiumare, formano un variatissimo cangiar di scena che accoppia l’orrido col dilettoso.
L’apennino adunque forma alle prospettive della ròcca di Bertinoro come la base e il fondo su cui si appoggia l’arco amplissimo di tanta parte d’Italia che le si distende e dispiega dinanzi. Imperocchè da ponente l’occhio trasvola sino al territorio di Bologna, di Ferrara e di Comacchio, e salendo per tramontana scorge quant’è grande il litorale dell’Adriatico: vede le torri di Ravenna, e il porto di Classe, di Cervia, di Cesenatico e di Rimini, scerne la Repubblica di s. Marino, tragitta i poggi di Pesaro, e va laggiù laggiù da levante a percuotere nel promontorio d’Ancona.
Raccogliendo poi la vista dai margini all’interno iscorgi da quel maraviglioso terrazzo quant’è lunga e larga la Romagna, ch’è la più ferace e doviziosa contrada dell’Italia centrale, sì per le sue nobili e ricche città, per le sue castella e per le sue terre popolose e fiorenti, come pe’ suoi campi messi a perfetta coltura dagli industriosi agricoltori. Laonde dalla ròcca di Bertinoro tu hai sott’occhio Faenza, Forlì, Forlimpopoli , Cesena, Lugo, Mendola, Fusignano, con molte altre borgate e villaggi e casali opulentissimi di frumento, di vino, di canapa e d’ogni sorta biade; d’alberi fruttiferi poi e d’ulivi e di macchie di cerri, d’elei e di querce antiche cosi ubertosa, che a buona ragione puoi chiamarla Terra di delizie.
Da quella sommità della Rocca ti si spiana insino all’ultimo orizzonte quell’azzurra marina che vedi solcata da mille vele, le quali recano ai porti di Romagna le mercatanzie della Grecia, della Dalmazia e della Puglia, con un andare e venire di barche pescherecce, le quali viste così di lontano sembrano schiere d’alcioni che diguazzino a diletto per le onde tranquille. Ma dai valloni degli apennini vedi uscire, e poscia serpeggiare per quegli sterminati piani colle loro acque limpide e cristalline, il Rubicone, il Metauro, il Savio, la Marecchia, il Silaro , il Senio, l’Amone ed il Santerno , e metter foce in mare e far porti, e accoglier legni e rizzar torri e fanali.
Ora il signor Achard immagini che un cittadino di Bertinoro si trovasse alla Saletta nei piani del ferrarese, ov’ha un campanile assai alto, e fosse invitato a salirvi per goderne la prospettiva, che quei pianigiani tengono per la più bella, vasta e deliziosa di quel contorno. Mentre il compagno gli mostra per meraviglia le torri di Ferrara, e gli bada pur a dire che la vista scorre sì da lungi che, ecco là i poggi bolognesi della Madonna di s. Luca, quello da Bertinoro in luogo d’inarcare le ciglia, di far gli stupori e uscire in un — Oh che vaghissima scena, oh che immenso teatro! — guarda con fredda indifferenza, e sbadiglia. Il pianigiano l’osserva tra lo sdegnoso e il compassionevole, dicendo nel cuor suo — Costui ha un’anima di rapa; ha egli fatto una ruga in fronte per meraviglia? Brillarongli punto gli occhi per diletto? S’è egli scosso pure un tantino? Nulla: cotesta sua indifferenza mostra ch’egli non ha spiriti nel sangue, e il cuor suo è melenso e dormiglioso —
Vi garba il paragone, signor Achard? Vi par egli che calzi bene? Chi è avvezzo, sol che si faccia alla finestra , di vedere a un girar d’occhio tante, e sì svariate e sì grandi e nobili scene, potrà egli trasecolare mirando dall’alto d’un campanile qualche miglio di contorno? Dite il medesimo de’ Romani: e se volete fargli uscire d’indifferenza, veniteci recando nella vostra valigia una metropoli più bella, più grande, più nobile e sublime di Roma; che allora vi pianteranno addosso tanto d’occhi, vi spalancheranno tanto di bocca, e gli Oh! saranno più grandi e rotondi del colosseo; ma sino a tanto che ci venite voi solo, correndo le strade di Roma come un levriere e scrivendo le cose a rovescio, non vi leveranno gli occhi in viso.
Mostro così alla buona la verità delle condizioni del popolo romano; e fatto quel po’ di chiarimento a risolvere le fallacie e scaponire i detrattori di Roma; egli è oggimai da tornare a Edmondo, che il buono Alfredo avea studiato; come fedel servitore, di tor giù da quella matta impressione, che potea gittarlo in istrani casacci. Il perchè Edmondo a notte, ferma, ringraziato l’ospite, mosse alla volta del Panteon, e fattosi ai banchi della salita de’ Crescenzi, ivi comperò sei beccacce, quattro anitroni, due ottarde, un’oca salvatica, e le chiuse in un fazzoletto: ma quando fu all’imboccatura della via del Seminario a quel fondaco d’arnesi da caccia, scelse una carniera ponendovi entro quella cacciagione.
Fatto questo, diè volta verso la piazza, e accostatosi a quella bottega, che sta al dirimpetto della fontana, ov’è il taglio de’ cignali, de’ daini e dei cavrioli, ivi si mise fra i cacciatori che convengono colà insieme a narrare gli accidenti della giornata; imperocchè era suo intendimento di udirli, e cosi poter pascià narrare agli amici le mille avventure incontrategli in caccia; dando vista e colore d’aver fatto un lungo soggiorno nelle macchie d’Ostia e lungo quelle maremme.
Egli è a sapere, che tutti i cacciatori, di qualsiasi contrada, hanno sempre a mane i più incredibili avvenimenti a contare; ma in Roma, ove la caccia è una fiera passione per molti e un mestiere per non pochi , se n’odono di quelle che non hanno nè babbo nè mamma. Per tutto altrove i cacciatori, secondo condizione, vestono più o meno grosso; ma i signori, eziandio con abito da strapazzo, si conoscono per tali, massime ai farsetti, che in Italia sono comunemente ben assettati e d’un panno verdecupo con bottoniere a coppella di metallo forbito; in Francia sono di panno azzurro, e in Inghilterra di rosso scarlatto. Non così a Roma, che tutti vestono un farsettone di carfagno a gran tasche, calzoni di canavaccio a spina vestiti di vacchetta nera sin sopra il ginocchio, e sottovi stivali di bulgaro tanè o rossomattone, con un cappellotto in capo di feltro floscio colle falde accartocciate e con il coppo isfondato e gualcito. Nè i signori vestono altrimenti; e come tu incontri per la via Ostiense, o Portuense, alcuno amico venir correndo nel suo biroccino, tu nol ravvisi; tanto lo ti disforma quella telaccia da vela, in ch’è si grossolanamente rinvolto.
A Roma le caccie sono lontane, e però vi si recano in birocci a due ruote, con un fondo intrecciato di corda a nodi in luogo di pedana, sul quale mettono le bisacce del pane e della vettovaglia, e un paio di cani raccosciati: talchè a vedere que’ visi arcigni con quei giubbonacci indosso e cogli schioppi fra le ginocchia hanno aria di sgherri. Gli è vero che i più ricchi hanno in quelle corse cavalli barbereschi colle penne di fagiano nella testiera, e spacciano il cammino per que’ viottoloni traversi e dirotti, e sopra que’ ponticelli diselciati con un’agilità singolare; ma i più hanno sotto i birocci certe rozzelline maghere e strutte che penano a cavarli di quelle male fitte e di que’ guazzi che affondano le ruote insin quasi al mozzo. Giunti alle capanne de’ Norcini, danno stalla ai cavalli sotto le tettoie, e poscia entrano a mangiare a desco, pigliando lingua intorno alle’ migliori poste di quelle fiere salvatiche; e se l’anno corre buono più pei cignali che pe’ daini; più pe’ cavrioli che per le lepri o le volpi; e così ragionando mettono a partito la scelta delle macchie, o de’ maresi, o delle fratte più acconce a scovare la preda. Capitano alcuna volta alla stessa capanna parecchie brigate a caso e senza conoscersi; ma in caccia tutti sono amici; e cenato, e beuto, e fumato insieme la pipa, si coricano a dormire alla rinfusa sul fogliame secco, e prima dell’aurora sono già all’erta. Beono un tratto di rhum., gittansi la carniera attraverso, dan di mano alla loro tortigliona a due canne, e via; nè tornano che a notte ferma chi con cignali, chi con cervi, chi con damme, e lepri ed altra cacciagione, che la dimane inviano a Roma.
Venendo poscia essi medesimi a città, appena giunti, e senza neanco spogliare que’ canavacci, calano alla piazza del Panteon, ov’ è il ridotto de’ cacciatori e degli uccellatori. Questi hanno sempre mille casi delle allodole e delle calandre attirate allo specchietto e mentre balloccavangli intorno, un ladrone di nibbio loro piombò addosso e ne ghermì un paio: altre diedero nelle lungagnole, altre nelle ragnuole, altre nelle coltrine, e queste nel paretaio, e quelle nel frugnolo; ma tutte con mille avventure, con istrani modi e col fuggirne di molte, e coll’attrarne d’altrettante mediante le cantaiuole, e le allettaiuole de’ zimbelli.
I cacciatori de’ paduli ora dicon miracoli dell’occhio loro acuto e del braccio fermo, pe’ quali non isgarraron mai colpo — Io, dice colui, ho tratto a venti beccaccini, e con tuttochè abbiano quel volare a scosse, a tremiti, a serpeggiamenti, tuttavia di venti n’ho còlti ventidue — Doh a chi la vuoi far bere? Di venti, sei bravo se ne cogliesti una dozzina; ma ventidue! e volano a un per uno — Tant’è, risponde lo spaccone. Due passavano a caso e diedero nella schioppettata — Un altro recita le fortune dell’oche selvatiche, le quali si buttarono a torme in un pelaghetto, ed egli sparando un tratto n’uccise dieci e ne ferì quattordici; e il suo cane (eh quel cane vale un tesoro) le ciuffò tutte a una a una. E qui descrive le fughe, le stratagemme, e il tuffarsi sott’acqua, e il cane inseguirle, ed esse dar su lontano, e tentare il volo, e ricascare nell’acqua. Un’acceggia era volata tant’alto che la sembrava un punto; ma tratto colla sua tortigliona, colsela sotto un ala , e cascò di piombo in un cannicciaio fittissimo: pure il cane piloso, lanciossi come un dardo fra i calami, e tanto si ravvolse, e tanto fiutò, che trovolla diguazzantesi; e abboccatala, portolla ancor viva al cacciatore.
Ma il capannello di quelli della caccerella, (che così a Roma diconsi le cacce clamorose) vende carote ancora più inestimabili, e lancia campanili e spacca montagne, ch’è un mirabilio a udirli parlare con un da senno, che Ia verità in persona non potrebbe dir più davvero. Un cervo saltò una ripa di ducento piè d’altezza, e ancora così per aria fu investito da un colpo d’archibuso che lo uccise prima che giugnesse in terra. Un daino spiccò un salto cosi terribile che lo portò di tratto in sull’altra riva del ramo grosso del Tevere; e un cavriolo, volendo fuggire l’assalimento de’ cani, saltò sopra un cespuglione di marmeruche così fissamente conserto, che vi si piantò dentro con tutte le quattro gambe, come in un pantano, e vi fu còlto vivo vivo, gittandogli un laccio scorsoio alle cornette. Niuno di loro vi presta la minima fede, e hanno per bugiacce tutte quelle novelle, niente però di meno ciascuno ha la sua; e vuol che gli si creda, e sostiene — Che sì, che l’è proprio avvenuta tal quale: nè più qua nè più là per l’appunto —
De’ cignali poi le sono cose da stordire. A udir loro, ciascuno è salvo per miracolo. Uno narrava d’un cignalone antico, arcavolo di tutti quelli che si veggono appesi agli uncini de’ banchi della Rotonda, ch’essendo accaneggiato da tre molossi e da due bracchetti, saltò in un borro the scorreva lungo una macchia d’ontani: e piantato le groppe nel margine, e puntato i piè in terra, dirugginando i denti, e buttando gran bava dalla bocca, stava in parata da ogni assalto; e intanto rizzava quelle setolacce su per le schiene, e sbarrava un paio d’occhi pieni di fuoco. Uno de’ molossi più impaziente o più valoroso, vedendo la fiera in resta, e non trovando loco da pur assalirla di fianco, le s’avventa al grugno per abboccarla. Ma che? avendo ciascuno la bocca spalancata, il cane addenta il verro nella parte soprana, e ficcagli i più aguzzi sopra il naso; ma mentre il cane vuol immorsarlo, il cignale serra la mascella di sotto, e assanna quella del cane che riman trafitto da quelli spuntoni porcini. Erano due tanaglie attanagliate l’una dall’altra. Il verro grugnava con un fremito spaventoso, il cane guaiva con ululati acutissimi: ma niuno de’ due moveasi di piè fermo; niuno arrendeasi; niuno vacillava: quando ecco gli altri due molossi vedendo quella fiera capiglia, preso il destro, scagliansi, l’un di qua l’altro di là, agli orecchi del cignale. Il cane assannato volea dimorsarsi; ma dell’uscire da quegli acuti pungiglioni era nulla. Allora un de’ bracchetti, impertinentissimo, veggendo la fiera impacciata con que’ due addestratori agli orecchi, ah che fa egli? S’inerpica sul ciglio del fosso, e di là salta di botto sulle groppe del cignale per ficcarvi i denti ; ma lo trovò d’una cotenna sì massiccia e sì dura ch’egli era come un mordere il marmo. Il cacciatore sopravviene, e visto quel gruppo di Policleto, spara nel groppone dell’animale; ma la palla, come se avesse percosso un ancudine, ribalzò e, il credereste? in quello passando a caso di là un cerbiatto che fuggiva i cani, quella palla colselo diritto al cuore e l’uccise. Di sì fatti casi incredibili ne udireste su quella piazza un buondato; ed avvene di così sbardellati e sbracati da scuotere delle risa le colonne del Panteon, e da sgangherarne le porte di bronzo.
Quella sera Edmondo s’avvolse fra gli uccellatori ed i cacciatori, e colse tante avventure da intrattenerne gli amici per un mese, e far loro vedere che quei parecchi giorni della sua sparizione era stato per suo diporto alla caccia in maremma. Com’ebbe inteso abbastanza, si tolse di là, e colla selvaggina nel carniere avviossi al suo antico alloggiamento; ove trovò Doralice, la casiera, nel suo stanzotto, che sedeva dormigliosa da lato al finestrino che riesce sull’entrata di casa, dal quale risponde alle richieste dei vegnenti.
Quando la Doralice ebbe scorto Edmondo entrare improvviso, si scosse tutta, e riconosciutolo, uscì in un — Oh eccellenza! — Balzò dalla sedia e gli si fece incontro tutta giuliva, pure isquadrandolo da capo a piedi, e quasi non credendo agli occhi suoi, veggendolo in quel brutto arnese di panni. Edmondo per rompere quello stupore, diè di mano al carniere, e tiratoselo innanzi, e aperto la rete — Doralice, disse, v’ ho portato un poco della mia caccia, che vi godrete domenica con Gasparetto vostro marito, e colla Nina vostra nipote — e detto questo rovesciò sulla tavola la cacciagione.
— Uh quanta roba! gridò la casiera. Oh e’ v’è le beccacce, e’ v’è l’oca, e’ v’è gli anitroni. Cappita! dopo domani vuol essere una magnata, uff. . . Gasparetto si cava di grinze davvero: l’oca a lesso sotto le lasagne, gli anitroni a guazzetto, e le beccacce vorrebbon essere arrosto coi crostini, ma non ci ho il girarosto: sapete che farò, eccellenza? piglierollo in prestanza da Barberina, che l’ha per occasione d’alloggiare i forestieri. Ma intanto voi sarete stanco assai e sarà bene che sagliate alle stanze.
— Saranno poi a ordine? perocchè voi non m’attendevate.
— Eh la Doralice, eccellenza mia, non si lascia cogliere alla pigrizia: lassù tutto è in punto: le camere scopate, il letto rifatto, le masserizie nette dalla polvere; poichè ogni mattina io mi vi recava per aprire le finestre, darvi aria, e richiuderle a sera: troverete sul tappetino le pianelle, sul buffetto i vostri libri bello e aperti come li lasciaste. In somma e’ non vi manca nulla, se non l’acqua fresca ch’io vi porterò colla brocca nel salire ad aprirvi e accendere il lume.
— Brava, Doralice; oh la Doralice è la nitidezza in persona: e Gasparetto ov’è egli a quest’ora?
— Egli è al teatro Argentina in sull’entrata a somministrare i viglietti d’ingresso, sia per a terreno sia per su le logge: vacci per tempo, perocchè vi porta eziandio la musica e il violino pel maestro dell’orchestra, non che il trombone e il fagotto detonatori. Custodisce per giunta i bastoni, gli ombrelli e anco i ferraiuoli de’ signori ; le mantiglie e le pelliccette delle signore, che venendo dal caldo del teatro le ripigliano e se ne coprono all’uscire.
— Di manierachè vostro marito si va buscando molto bene la vita colle opere del dì e cogli ingegni della notte.
— II poveretto, Dio grazia e de’ buoni padroni, si raggranella qualche baiocco. Egli è uomo procaccino e servigevole assai, onde egli ne trae sempre qualche cosetta di giunta all’ordinario. Per esempio egli governa il pappagallo della prima ballerina, ed hanne tre paoletti la settimana; oltre gli avanzi delle ciambelle, de’ fiadoni e delle pinocchiate che la padrona gli fa comperare ogni giorno: che dioguardi se Gasparetto gliene desse tutti! gli verrebbero i bachi al povero pappagallo. Mena poi ogni giorno a passeggiare per un’ora in sul Pincio e a villa Borghese la picciola levriera della prima cantante, la quale ha una gorgerina d’argento con un cordoncino di seta vermiglia, con cui Gasparetto mio la conduce: e quando fa un po’ freddo la ricopre con una gualdrappina di velluto cilestro, o di cascemir scaccheggiato. La signora all’uscire di casa gli dà sempre un paolo, acciocchè comperi alla bestiuola i biscottini al zeffiro, e i confortelli alla sultana; ma con un baiocco di ciambelle la canina n’ha assai, gli altri nove se gl’intasca. E questo è il meno; perocchè avvenendosi nel marchese A, nel conte C, e nel barone B, questi pigliansi la piccola veltra in collo e le fan vezzi, e poscia dato chi un testone e chi un giulio a Gasparetto, dicongli — Va dal confettiere di piazza di Spagna e comperale i berlingozzi: e Gasparetto insacca.
— Intantochè per vostro marito è più la giunta che la derrata.
— Gli anni corron tristi, signor Edmondo, e chi non s’ingegna s’affoga. Gasparetto, non fo per dire, è molto saccente ed ha molte industriole. Egli tosa e rade a giubba di leone i cani barboni di cotesti signori Lordi, ed essi gli danno poi per lavarli sapone che sa di mille buoni odori: pezzi così! e sono rinvolti in certe belle carte dorate e dipinte ch’è un piacere. Tutta roba di Londra ve’. Che fa mio marito? Prima lava i cani col sapone nostrale, e poi dà loro suso una passatina con quell’odoroso, e il cane quand’entra al padrone olisce di musco come una serpe acquaiola. Tutte le altre saponette Gasparetto ritielle, indi se le vende ai ballerini, ai cantanti e alle contatrici che ne son ghiotte.
Gasparetto poi è sensale di stanze pei viaggiatori: appena qualche famiglia russa, inglese, tedesca, ed altre, giungono all’albergo d’Europa, della Gran Brettagna, di Russia eccetera, egli si profferisce ai camerieri o al maestro di casa degli arrivati, e fa loro vedere i più bei quartieri , con tappeti, e mobile, e comodità , e prospetti che sono l’eleganza e la delizia a mirare. Come abbian fatto i loro convegni coll’allogatore, Gasparetto si offre di trovar loro il cuoco, la lavandaia, la stiratrice, la vettura, e si trafora in ogni loro occorrenza. Dal padrone di casa ha la senseria; dal cuoco, dal vetturino, e dagli altri condotti riceve le mancie e le propine pattuite. Alle lavandaie e alle stiratrici vi penso io. Gasparetto s’informa se la signora ama di cavalcare, e trova certe bianche ginnette da maneggio con selle a corno. Se il forastiere ha il suo cuoco di famiglia, allora mio marito gli addita il macellaio, il pizzicagnolo, la fruttaiuola , il carbonaio, la lattaia, e da ciascuna delle poste rinverga, ove una libbra di carne, ove due fette di prosciutto, ove un panierino di carbone: il latte per la colazione, manco male, e’ ci viene in dono ogni mattina.
— Capperi, Doralice! ma ciò si chiama uno scorticare i forestieri, i quali non sanno la lingua, gli usi e i prezzi di Roma, e però sono uccellati, facendo loro pagar dieci quello che vale due appena; e per sopraggiunta Gasparetto ne gode la parte sua.
— Miserie, signor Edmondo. Gasparetto ora è infrollito: i belli anni sono volati via, e non tornano più. Figuratevi ch’egli era il Cicerone de’ due maggiori alberghi di Roma; e allora i viaggiatori non erano così scaltriti come oggidì, che a metterli tutti sotto il pressoio e’ non v’esce una ciotoletta di sugo. Allora era un grasso vivere. Gasparetto era amico del cuoco d’ogni albergo, e de’ credenzieri. Ma sapete voi quanta roba mi portava la sera? Quelle, vi dico io , eran cenette da nozze! Correan sotto il nome d’avanzi, ma erano avanzi che valeano l’intero; perocchè in quei cenoni dei Lordi, aveavi tanti serviti, che per ingoiarli tutti e’ vi vorrebbe una ventraia più larga del salone delle terme di Caracalla: onde quando erano alla metà della tavola i commensali cominciavano a sbocconcellare e a spizzicare alcuna portata, e rimandare il resto: giunti poi agli arrosti, si tornavano sulla credenza belli ed interi, se pure non si trinciava qualche petto di fagiano e qualche coscetta di beccaccia, pei più ingordi e pei diluvioni, che non vi mancano mai a quei conviti. Tutto il rimanente di quella bella grazia di Dio chi se la ciuffa? Il credenziere n’ha la maggior parte, il cuoco la sua, i valletti la loro; chi la si vende, chi la si mangia e chi la dona. Il mio Gasparetto ogni sera veniva a casa pien d’ogni bene, e cenavamcelo in santa pace, e la mattina rimaneami nello stipo qualche ghiotto bocconcino da donarne la comare, la pigionale, il ciabattino del vicinato; tutta gente da servigiuzzi all’uopo.
Sapete voi che certe sere mandavami pel ragazzetto di stalla, ben rinvolti nelle foglie di cavolo, quando un paio di fagiani, quando una mezza lepre, quando un buon tocco di cervo o di cavriolo, quando una crostata, un timballetto di creste e di fegatelli di pollastra, pasticceri freddi, e tri glie di mezza libbra, e rocchi di storione d’un palmo? Eh che macco a iosa! Gasparetto poi mai che tornasse a casa senza recare nelle tasche della giubba un paio di bottiglie o di Sciampagna, o di Bordò, o di Madera, o d’Alicante, e persino di Rhum; ma dello schietto di Giammaica: ed io la mattina appena scesa da Ietto me ne sorbiva una tazzetta che mi grillava in mezzo al cuore. Che se l’albergo di quei signori fosse vicino alla casa nostra, pigliava due coppe di cristallo con entrovi due mattonelle di pelato alla fragola, alla vaniglia, e al cioccolatte; ed io e la comare n’andavamo lietissime.
Non crediate mica tuttavolta, che Gasparetto ricevesse a ufo quelle ineziole: oibò: le si guadagnava coll’opera sua; mercecchè tanto il credenziere , quanto il cuoco vendeano que’ rilievi della tavola dei loro milordi a un oste di via della Vite e ad un altro laggiù dal teatro Aliberti, e Ga sparetto faceali ricapitare bene assestati e condizionati nei portavivande, e teneva i conti, e in capo alla settimana riscoteane il danaro.
Quando poi quei signori voleano fare una corsa a Tivoli, a Frascati, ad Albano, Gasparetto era il factoto dell’andata; pagava i cocchieri, ordinava i pranzi, dava le mance: quelle per lui eran giornate che valeangli un rifiato. Ma il guadagno maggiore veniagli dai musaicisti, dai venditori di quadri e d’anticaglie , perch’egli v’avea fatto di molti studii , e avea buona provvisione da quei mercatanti: e siccome egli parlava l’inglese, il francese, il tedesco e un poco anche il russo, cosi egli faceavi l’interprete, e lodava a cielo quegli oggetti, de’ quali chiedeansi prezzi ingordi. Cotesti signori s’innamoran di tutto; e vostra eccellenza sel sa, che hanne piene le camere di mille ninnoli antichi, e beato lei vossignoria, se vi foste lasciato guidare da Gasparetto mio: dunque cotesti signori s’innamoran di tutto, e in que’ bei magazzini di quadri fanno tanto d’occhi — Quella Sibilla di chi è? domandavano in inglese: e mio marito rispondeva — Milord , qui dentro son tutti Raffaelli , tutti Tiziani, Michelagnoli e Leonardi — Ah! bene; quanto vale? — Gasparetto ne domandava in italiano il mercante; il quale rispondeva — Nol posso dare meno di trecento scudi — Udite, Milord? Ne vuole cinquecento scudi , dicea Gasparetto — e dopo alquanto di tira, tira, veniano a quattrocento; e il quadro faceasi portare a casa. Gasparetto pagava; e quei cento scudi sopra il mercato eran suoi, oltre la mancia del venditore.
— Erano rubati cioè, e di tanta trufferia egli meritavasi la galera.
— Che volete, eccellenza ? Non sapeano l’ italiano quei Lordi, e aveano tanti danari da affogare, e gittavangli in cotesti gingilli. Immaginatevi! alcuni d’un musaico che raffigura il Panteon, e uno del tempio della Sibilla e un altro della piazza del Vaticano, commessi in belle tavolette rotonde di pietra nera di paragone , sborsavano seicento, ottocento, e insino a mille scudi. Non vi dico poi delle anellette a scudo, degli orecchini a pendente, delle borchie da petto e da braccialino, sia di musaico, sia d’intaglio od a cammeo: spendeano tesori, e non volete che al povero Gasparetto ne venisse qualche sterlina in tasca? Deh che coscienza avete, signor Edmondo? Non vi dico delle anticaglie di bronzo e di terra cotta, che le pagavano un occhio del capo; perchè gli antiquari diceano, che l’erano lucerne, piatti e vasi degli antichi Imperatori di Roma. Oh dovean eglino passar per le mani di Gasparetto senza un po’ di dogana?
— Breve, tuo marito truffava bellamente i forestieri; e di coteste frodi romane se n’è empito il mondo , che ne mena tanto scandalo.
— Perdonate, mio marito non è romano, eccellenza; ma non v’è più oggimai pericolo che i forestieri si lascino agguindolare; con ciò sia che allora i milordi e i monsù non sapeano l’italiano; ma ora ci capitano in Roma parlandolo meglio de’ Romani, e non vogliono più Ciceroni, ma si mercatano le cose da sè, e i Ciceroni oggi giorno non isguazzano più tanto.
— E tuo marito perchè non fa più quel mestiero, ch’è sempre buono?
— É stata l’invidia che l’ha rovinato. In quegli anni v’erano pochi Ciceroni, e ora n’abbiamo un diluvio, e si rodono e si mangiano vivi l’un l’altro. Gasparetto avea raggruzzolato qualche po’ davanzo e m’avea messo su una botteguccia da caffè, ben corredata d’argenteria, di vasetti e di guantiere d’argento. Allora avevo in casa due nipoti, la Nina che l’ho ancora, e la Mariuccia di due anni maggiore: ell’era la più bella e avvenente creatura che voi vedeste cogli occhi; ond’io pensando che l’era manierosa e dabbene me la feci compagna. Non vi potrei dire in quanta voga era venuta la mia bottega. Tutti i cuochi, i valletti e i cocchieri di piazza di Spagna ci veniano ogni mattina, e fra giorno ci capitavano brigate di scultori , di pittori, d’incisori che tornano in via de’ Condotti , della Vite, e del Babbuino. Vi fu chi mi disse — Sora Doralice nostra, lasciateci un po’ ritrarre la Mariuccia, ch’è una testa greca — Pensate, eccellenza! ell’è romana schietta e la facean greca! lo non volli, e sostenni sempre ch’è figlia d’un Romano, e non c’entra greci per nulla: e Mariuccia diceami — Ben faceste, zia mia —
Or veniva spesso al nostro caffè un giovinotto, corriere di certi duchi forestieri il quale guardava Mariuccia di buon occhio; e Mariuccia sempre contegnosa e modesta. Una mattina vo alla sua camera per isvegliarla e mandarla aprir la bottega: non la trovo, e il letto era già rifatto. Eh dissi, com’è mattutina la Mariuccia! una ragazza così faccente non si trova: esco, e veggo la bottega socchiusa, senza lumi, e a fuoco spento — Mariuccia? eh Mariuccia? — Niuno risponde. Accendo la candela dall’acquavitaro di faccia; entro, e veggo rubati tutti gli argenti, e manomesso ogni cosa. Rimasi intirizzita. Corro da Gasparetto, il quale si mette sulle ricerche: tre giorni dopo il Buongoverno seppe ch’era fuggita con quel corriere a Civitavecchia e imbarcatasi sul primo vapore per Marsiglia. Non se n’ebbe più novella.
— Qui però non ci ha luogo l’invidia degli altri Ciceroni per fare uscir di mestiere vostro marito. La nipote innamorata rubollo, e fuggissene.
— Udite il rimanente. Un anno dopo quella fuga Gasparetto era, in virtù de’ suoi risparmi e delle sue industrie co’ forestieri, rimessosi in panni, come suol dirsi, e gli altri Ciceroni scoppiavan d’astio e d’invidia. Or vedete giochi della mala ventura! Fra le ruinaglie del palazzo de’ Cesari sul Palatino uno scavatore trovò un canocchialetto, interrato e rugginoso, e portollo a mio marito. Gasparetto lo compera e lo rinetta del terriccio : indi sperando venderlo a qualche Lord per antico, entra da un antiquario, ov’erano per mala sorte, due Ciceroni, e dice — Vedete, sor Asdrubale, maraviglioso stromento! Fu trovato iersera fra le ruine del Palatino, ov’era, come sapete, la casa aurea di Nerone. Gli storici dicono che Nerone mise alle fiamme tutta Roma; e ne mirava l’incendio dalla torre delle monache di santa Caterina al Quirinale. Di certo quest’era il canocchiale che usava Nerone a sguardare quell’inestimabile abbruciamento — A quelle parole era presente il figliuolo dell’antiquario, il quale studiava al collegio romano, e all’udirle dà in uno scoppio di risa sghangherate , gridando — Ah ah ah il cannocchiale di Nerone! e i cannocchiali furono scoperti mille e cinquecento anni dopo: ah ah: bravo, Gasparetto, hai un tesoro unico al mondo. Non lo dare per mille scudi, sai?
Che volete, signor Edmondo? Que’ due Ciceroni, emoli suoi, cominciarono a dargli la baia, e a metterlo in canzone per tutti gli alberghi. Gasparetto non potea più presentarsi, che i portieri, i valletti, i ciceroni tutti chiamavanlo per motteggio — Gasparetto dal cannocchiale di Nerone — Le berte, i dileggi , gli scherni che gli faceano quei ribaldi sono innarrabili; tanto che visto ch’era divenuto il zimbello sin de’ ragazzi di stalla , per non essere più uccellato, si tolse dagli alberghi , e cercò d’acconciarsi come casiere in questo palazzo : e così campa da molti anni in sua buona pace —
Questa lunga cicalata della Doralice , ebbe luogo parte giù a terreno, parte accompagnando per le scale il nostro Edmondo, e parte nel suo salotto, mentre stava cercando le sue tattere, apriva e chiudeva stipetti, apparecchiava la camicia da notte e la biancheria pel domani. Finalmente Doralice gli disse — Buon riposo , eccellenza — Addio, Doralice.
LA CIECA SVEDESE
Edmondo trovò che il posare nel proprio letto è molto più dolce cosa che il coricarsi ne’ letti altrui, ed ebbe il più bel sonno e tranquillo ch’egli avesse gustato da un pezzo; perchè risentitosi a dì alto si trattenea in letto crogiolandosi e girando gli occhi attorno a mirare li suoi arnesi con quel piacere che provasi dopo lunga assenza a rivedere gli amici. In frattanto pensava i modi più atti di rifornirsi tutto, e ravviarsi bene i capelli, ch’avea tosi di dietro assai corti alla popolana; e dare alle mani quel po’ di morbido e di vellutato che trae la pelle dall’uso continuo de’ guanti ; e radere dal collo quella loietta nericcia che ammuffasegli intorno, quando altri tienlo ravvolto in certe caravattacce che sudando scoloriscono alquanto. Laonde volea entrare nella vicina casa de’ bagni, ed ivi ragguazzare e stropicciare e insaponare tanto da levarsi dattorno quel sito plebeo, ch’eraglisi fra carne e pelle insinuato.
Verso le dieci la Doralice venne a dargli il ben levato, e offerirglisi agli usati servigetti di camera ; onde le disse che a mezzo giorno desiderava il parrucchiere per farsi acconciare i capegli.
— Ma proprio davvero, sa ella, che ha bisogno di rassettarseli a modo: io non mi credetti mai che per andare a caccia si dovesse tagliare a cottica, come i carrettieri di Borgo Pio. La gli aveva sì belli, sì ben partiti, sì lucidi e odorosi! e’ fu proprio un peccato fonderli così.
— Che velete, Doralice mia buona? Alle capanne e ne tugurii di Fiumicino e di Campo morto non s’ha nè pettini nè tempo da pettinarsi, laonde per non iscapigliargli van meglio corti — Così dicendo lasciò Doralice a rifargli la camera, ad apparecchiargli calzette, camicie e panni da uscire a pranzo, e andossene al bagno.
Ma Edmondo s’avea pel capo altri pensieri che pur di caccia e di archibugio. La cicalata della sera precedente l’avea fatto entrare in nuovi avvisi sopra Gasparetto, il quale pareagli uomo destro, astuto, esperto e da trovare il nodo ad ogni ritortola e perciò sperava che gli scoverebbe la Trasteverina: anco la Doralice colla sua chiacchera accennava una goffaggine che mascherava una sagacità e sottigliezza serpentina da venire a capo d’ogni trama. E non andava errato per fermo, chè tra lei e la Nina sua nipote, eran due frugole da cavar la tarantola da ogni buco.
Tornato a casa Edmondo dal bagno, e trovato il parrucchiere e fattosi a somma diligenza ben compartire e foggiare i capegli, diegli commiato, e fece chiamare la Doralice che gli apparecchiasse gli abiti da uscire-.
— Avete fretta stamane, Doralice, le disse Edmondo?
—- Punto, rispose; perocchè Nina guarda la porta mentre la spenna e spiuma quell’uccellame che, buona grazia vostra, ci avete donato, e mangeremcelo domani con un mio compare e comare di s. Giovanni; quando c’è la Nina alla porta, faceste le pure dieci commissioni a un fiato, e’ non v’è dubbio che la ne sdimentichi una sola. Io sì che debbo pregare i committenti di scrivere le imbasciate col gesso nella tavoletta che tengo appesa al finestrino, e Gasparetto dee fare il medesimo: ma la Nina? che! quella è un demonietto, che ride, canta, lavora, ed è pronta come la punta d’una spada. Appena esce od entra un pigionale — Monsiù, gli dice, e’ vi fu un tale che vi vuole alla via tale al numero venticinque, terzo piano, scala a sinistra — quel signore Polacco v’aspetta a cavallo verso le sei sul Pincio. Questo è il viglietto d’invito a pranzo dal marchese di Rhuffst per dopo domani alle sette — Signora, la contessa Ninny verrà a prendervi colla sua carrozza al tocco: dal gabinetto di lettura fu mandato per voi un libro inglese, l’avrete in camera al vostro ritorno: la bustaia verrà domani a mezzogiorno a misurarvi la fascetta da ballo — Insomma , signor Edmondo, quella fanciulla è un portento di memoria. Essa fa eziandio le imbasciate ai pittori del terzo piano, che hanno sempre mille arzigogoli, e a ricordarsi di tutti ci bisogna un fastel di cervello; e persino ai pigionanti delle soffitte sa ridire ogni minimo che.
Inoltre ell’è una furbacchiotta con un occhio in capo, che non le fugge un bruscolo che vola; onde se la vede certi figuri domandar del tale, gli squadra in un attimo e risponde — Non è in casa. Se la vuol qualche cosa lasci il suo nome — A che ora tornerà? — Eh chi lo sa? — Se vede certi altri che con aria franca s’avviano verso le scale, balza in sull’uscio, e dice — Dove va ella? — Al secondo piano — Chi cerca? — Il conte tale — È fuori — E intanto avverte il cameriere che si badi, perchè verrà sì e sì; baffi neri; calzon mischio, soprabito verde. Ha tutta l’aria d’un cavaliere errante.
— Eppure a vederla, disse Edmondo, la Nina ha un’aria bonacciosa e bambagiosa da farle credere che il sollione viene in gennaio.
— Sì eh? Ell’è più astuta del fistolo.
Edmondo stava a udire tranquillamente , e intanto che la casiera ciarlava senza posa, egli era spesso sopra pensiere: finalmente quando egli fu in ordine di vestirsi, domandò la Doralice, a che ora tornava per solito a casa Gasparetto: e udito che, non essendovi quella sera il teatro, sarebbe tornato verso le due ore di notte, licenziolla. Allora Edmondo comminciò a entrare in cento almanacchi, e pareagli aver udito dalla Doralice tali valenterie di Gasparetto e di Nina, ch’egli per opera di cotesta genìa astuta, traforellazza, e da tramare ogni ghiribizzo, avea ferma fiducia d’uscire con buona ventura dai gineprai, ne’ quali erasi a vvoltacchiato sino allora per la pazza voglia di conoscere la sua Trasteverina. Intanto andò a pranzo; visitò qualche amico, che gli fece di molta festa; e prima delle due ore di notte fu a casa. Gasparetto era giunto di poco, e fattoselo salire col lume in camera, cominciò bellamente a parlargli de’ molti modi usati per ritrovare quella buona creatura, tacendogli però le sciocchezze di quei suoi travestimenti, e i battisoffia ch’ebbe a provare. Aveagli già narrato il caso di Carluccio pittore, del ritratto ch’egli fatto n’aveva, e del nome dimentico, e dalla sua ritrosia in do mandarglielo per non venire in canzone presso gli amici.
— S’egli v’è il ritratto, disse Gasparetto, la cosa è più agevole che non arbitrate; che s’io poi riuscissi a carpire di bocca il pittore anco il nome della giovane: è fatto. Voi saprete chi ell’è, ove torna, e il numero, e il piano, e gli anni suoi, e Vita e miracoli di lei. Scrivetemi in un fogliolino l’abitazione del pittore.
— Ma bada, Gasparetto, che il nostro Carluccio è furbo come una passera scopaiola; e punto ch’egli se n’avvegga, mi matterebbe per tutta Roma, e n’avrei la baiaccia da tutti gli amici.
— Non ve ne date pensiero, signor Edmondo: Gasparetto ha trovato il bandolo a matasse ben più arruffate che la non è cotesta.
— Se tu n’esci felicemente n’avrai buona mancia e d’ora innanzi mi troverai presto ad ogni tuo piacere.
— Saprestemi dire cori esattezza il sito d’esso ritratto nella stanza? Io debbo saperlo accuratamente e per l’appunto a non scerre l’un per l’altro.
— Attendi. Uno, due, tre, quattro, cinque. . . tè; gli è l’ottavo nella parete a diritta: pende in mezzo a una testa d’Aiace, e al busto d’una baccante degli affreschi di Pompei; la fanciulla è di mezzo profilo, e la ti guarda con un occhio sereno; di nera pupilla che nuota in un bianco di latte: di capelli morati coi pendoni a treccetta, e dietro le ricascano due nastrellini neri con bella grazia. Dunque attendi; numer’otto; notalo vè —
La mattina di poi Carluccio ode picchiare all’uscio dello studio; e aperto, vede un signore attempato, vestito di nero, con guanti paglierini, il quale gli dice — Parlate voi francese? — e udito, che un pochetto; ripigliò in francese — Ieri trovandomi a pranzo con un principe russo, ov’erano molti convitati, e ragionandosi de’ migliori dipintori di Roma, la principessa portava a cielo il vostro colorito e il vostro disegno, dicendo; che voi avete la vivacità veneziana nel primo e la castigatezza e severità romana nel secondo. La principessa è donna di gusto squisito, e però io m’invogliai grandemente d’avere alcun’opera del vostro pennello —
Carluccio sentiva un certo solletico a queste parole, che mostrò in un sorisetto e in un modesto chinar d’occhi, rispondendo a quel cortese incognito parole di grazie affettuose, ed offerendosi a servirlo ben volentieri dell’arte sua. Allora il forestiere cominciò a considerare la tela , ch’egli aveva sul cavalletto, ed era un’Amazzone ferita nell’atto di cader da cavallo: il maestro davale già gli ultimi tocchi, e il quadro era bello davvero.
— Oh sì, disse l’incognito, la principessa ha ragione: voi avete un colorire gagliardo; e le passioni di quel viso vicino a morte son delicate e al sommo espressive —
Carluccio gongolava, e lisciavasi la barbetta; pur sogguardando il suo quadro con una dolce compiacenza, mentre il forestiere volgeva gli occhi per la stanza ch’era piena di bozzetti, di modelli, di ritratti e di primi getti di pensiero — Ebbene, disse, che ritratto è cotesto? — È una Vittoria Colonna — E quel cipiglio scuro? — È un capo d’Ezzelin da Romano — Così andò aggirandosi finchè alla parete a man ritta vide un busto d’Aiace e pressovi un ritratto di donna.
— Oh bella testa raffaellesca! esclamò: tuttavia ne’ dipinti di Raffaello non ricordo averla veduta.
— Cotesta, disse Carluccio, non è copia d’autore, ma ritratto naturale.
— Come! avvi egli in Roma fattezze che vincono le greche? voi ci avrete aggiunto un bello ideale; tanto avete piena la mente delle opere antiche!
— Perdonate, signore, questo è il viso d’una nostra fanciulla popolana di Trastevere, di cui tolsi uno schizzetto a matita, e poscia l’incarnai, secondo l’impressione della memoria. Sì è bello; ma noi n’abbiamo in Roma d’assai più nobili e vaghi.
— A vostro grado; ch’io non vo’ venire in competenza de’gusti: ciascuno ci ha il suo: a me quella testa piace assaissimo e l’ho per mirabile. Io vorrei che me ne dipingeste una Giuditta colla testa mozza d’Oloferne in mano, in un quadro di sei palmi. E chi sa che l’originale non si chiami Giuditta?
— No: chiamasi Annunziata; anzi in casa e nella Parrocchia della Luce le fanciulle nomanla Nunziatina.
— Bene: Nunziatina sia, ma io la voglio Giuditta. Che bella testa! che aria solenne! Dite un po’, maestro, spiacerebbevi egli di farmela fotografare? Ma bene, e dal miglior fotografo di Roma, per ch’io la vorrei far vedere alla Principessa. Che ci vorrà egli?
— Pochi scudi; ma io vorrei, signor mio, che voi mi prometteste di non lasciarvela uscir di mano, perocchè il quadro non riuscirebbe più nuovo e cesserebbe d’essere originale.
— Ba! che dite? parvi egli? Darei un occhio piuttosto che far copia altrui di cotesta perla preziosa: sta in vostra mano il farne trarre quanti esemplari volete; ma io per me n’ho assai d’uno. Preme più a me che a voi. Quando potrei averlo? Se vengo domani giorno troverollo?
— Ove alloggiate, signore, ch’io possa mandarlovi? perocchè domattina io l’avrò a ordine.
— Non accade che vi disagiate; io sto in sul tramutarmi, e forse domani avrò chiuso il contratto d’un buon quartiere, essendo io risoluto di passare in Roma non pochi mesi —
Il domani l’incognito fu al pittore; gli pagò largamente la fotografia, e andossene con essa; ma egli non era giunto forse a piè della scala che il don Alessandro, il Mansionario, le saliva per visitare Carluccio.
— Oh bene, esclamò il pittore; v’incontraste per le scale con un forestiere vestito di nero?
— Appunto; e mi parve così alla sfuggita un antico Cicerone di piazza, che molti anni sono conduceva i forestieri in s. Pietro.
— Che! disse Carluccio: gli è un garbato signore d’oltre monti che non parla italiano e, se v’ho a dire, anche non bene il francese in che mi favellava; e ci ho gusto che siate venuto, perchè io rideva fra me e me d’una strana ventura intervenutami in questa pratica. Quel forastiere vuole una Giuditta al naturale, e siamo rimasti negli ottocento scudi, ch’io ne gli avea richiesto i mille: e guardando egli intorno i miei bozzetti, gli piacque smisuratamente una testa: indovinate di chi? Della Nunziatina. Ond’egli non è poi a stupire se Edmondo vi facesse intorno le pazzie che v’ha fatto.
— A proposito d’Edmondo, venivo appunto a salutarti a suo nome; poichè ieri dopo li vesperi di s. Pietro venendomi per ponte sant’Angelo verso la Chiesa Nuova m’affrontai proprio in Edmondo, che avea già imboccato il ponte dall’altra parte. Ci demmo una stretta di mano; ed ei volse cammino per accompagnarmi, dicendomi: ch’egli era tornato la sera innanzi dalle macchie d’Ostia, ov’era stato alla caccia de’ cignali; e recitommi i più strani accidenti avvenutigli per quelle sterminate lande e paludi, e i pericoli che corse e le fiere che uccise; soggiungendo che oggi verrebbe allo studio; e che intanto ti salutassi; e domani ci vuol con lui da Spilman a mangiare il daino e le anatrelle. Vedi, Carluccio! e noi facevamo sopra Edmondo tanti sospetti e ghiribizzi ! —
In questo mezzo tempo nello spedale di s. Giovanni la Nunziatina, essendo ricaduta dell’ infocagione di gola, penava a guarire, nè le si dipartiva da dosso una febbrolina, che covava sotto il fuoco delle vene; e dovechè per consueto i mali di gola acuti sogliono rimettere in breve pe’ salassi, in lei si era vòlto in una lenta infiammazioncella che non finia di guarirla. L’inferma era medicata co’ siroppi rinfrescativi; ma tuttavia per alcune ore del dì levavasi, girava perla corsia, lavorava un po’ di maglia pel suo intrattenimento, e facea cotali servigiuzzi alle suore, che l’amavano assai per la sua bell’indole e pietà singolare. Ella, quasi mezzo sacristana dell’infermeria divenuta, tenea forbiti e lustri i candelieri dell’altare, dava col piumino sulle ciocche de’ fiori per ispolverarli, e colla spazzola sul tappeto per ripulirlo; e quando i religiosi Crociferi, che sono i padri spirituali dello spedale, facevano la raccomandazione dell’anima alle moribonde, essa teneva la candela benedetta accesa insino al loro trapasso.
La maggior opera di carità, in che tuttavolta si esercitava era verso una inferma ch’erale vicina di letto, e pativa fieramente d’artritide che la teneva inchiodata in tutte le giunture, nè potea pur muovere un dito. Per giunta ella era cieca la poverina; talchè stavasi colca come un tronco, e guaiva incessantemente per l’acutezza delle doglie. Sinchè la Nunziata era in letto, andava consolandola di parole, e spenzolandosi alquanto, porgeale a bere come potea meglio; ma come cominciò a levarsi un tantino, tutto il tempo le stava d’intorno per accomodarle i guanciali, stendere la riboccatura del lenzuolo, e rassettarle i copertoni che cadeano alla banda: quand’era l’ora del desinare poneale la tovagliuola sotto il mento, e imboccavale con un amore di sorella quel pan grattatino a mezzi cucchiai; forbendole la bocca, tenendole la mano sinistra sotto il capo ad ogni cucchiaiata per rialzarla un pochetto, chè il brodo non le s’attraversasse in gola.
Quando poi la Nunziatina vide la cieca alquanto ricuperata, non è a dire com’ella fosse continua al letto di lei, e quante carezze le facesse d’intorno. Cominciò coll’acqua tepida a lavarle le mani, a mozzarle l’ugne che s’eran fatte soverchiamente lunghe, e perchè la non vedea lume spesso la si graffiava: appresso intingendo il becco del sciugatoio cominciò a lavarle la faccia, e perchè dagli occhi gemeale un po’ di cispa, la riforbiva di frequente coll’acqua di rose: il che recava alla povera ciecolina un sollievo inestimabile e non finava di ringraziarla, dicendo, ch’era un angelo di Dio inviato dal cielo a sua consolazione.
Cotesta inferma quando potè rizzarsi alquanto sul letto avea certi camiciolini da notte finissimi, e cuffiette galate, e camice di tela di Fiandra: gettavasi poi sulle spalle sciallini di seta, e sovr’essi un grande sciallo di lana di Persia a fioroni tessuti di vaghi colori. Tutte le inferme la riguardavano con meraviglia, e diceano fra loro — Cotesta per fermo dee essere qualche signora venuta in basso stato; e perch’ella parla pure a modo de’ forestieri, chi sa donde c’è capitata in Roma, e per quali sventure è caduta in tanta inopia che dovette volgersi alla carità dello spedale come noi altre poverette? e’così dicendo, e vedendola sì buona e rassegnata, aveanla in grande estimazione.
Un dì la Nunziatina, mentre con una pezzuola intinta nell’acqua di rose le venia strofinando gli occhi, ed essa ne la ringraziava con gentil modo e cordiale, fattasele all’orecchio le disse — Come vi domandate, buona mia?
Il mio nome è Brigida, rispose, ma mi chiamano Ida per vezzo, come voi altre dite Nanna alla Giovanna, e Nina alla Caterina.
— Perdonatemi Ida, s’io sono curiosa, voi non siete romana, perchè non parlate alla maniera nostra.
— No, sorella mia dolce, non ho la gloria d’essere romana, avvegnachè sia stata in Roma a lungo: io sono svedese e nata a Stokolm.
— Oh che nome! e’ ci vuole una lingua fatta a posta per poterlo dire: e cotesta vostra città è ella più qua o più là di Montefìascone, ove io ci ho de’ parenti e vi si fa di buon vino?
— Ell’è più là di due mila miglia, ed è una delle città più verso il polo dei regni d’Europa.
— Dio mio! due mila miglia! eh beata voi che poteste fare tanto cammino, ma colassù ci farà gran freddo; e poi mi dissero che così lontano non vi nascono più cristiani.
— Vi nascono; ma per loro ismisurata disgrazia non sono cristiani cattolici.
— E voi dunque, Ida mia, non siete cattolica? Eppure siete così buona, e dite le orazioni colle Suore, e da voi a voi pregate sempre.
Allora la buona Ida allungò la mano, e cosi brancicando trovò la faccia della Nunziatina, e cominciò a carezzarla giocondamente dicendo — Figliuola mia benedetta, com’è egli possibile di non esser cattolici quando fra voi romani si trovano delle anime belle come la tua, e si veggono i frutti di tante virtù e carità? S’io non fossi, mercè di Dio, già cattolica, diverrei tale incontante veggendo in te, così giovane come sei, tanta pietà per una donna forestiera, di cui non sapevi nè la nazione, nè il nome, eppure mi avevi tanta cura e sollecitudine intorno come se mi fosti figliuola, e mi aiutavi e imboccavi così soave e graziosa, disagiando te stessa, e privandoti di quel po’di sollazzo che prova l’inferma col favellare e intertenersi colle vicine. Cotesti atti non possono partire che da un cuore informato dalla carità di Cristo, la quale non può allignare se non nelle membra vivificate dal divin capo che tramanda in esse gli spiriti animatori d’ogni più eletta virtù.
Fuori della Chiesa Cattolica non avvi che rami aridi e infruttuosi, perchè divelti dalla vita vera che germina i frutti di vita eterna. Non ti voglio negare che anco negli eretici non vi sieno le virtù morali della temperanza, dell’equità e della compassione, talvolta eziandio in grado maggiore che ne’ cattolici: ma non essendo quelle virtù animate dalla grazia dello Spirito Santo, non si sollevano oltre i confini del naturale, nè più nè meno come le virtù che esercitavano i pagani privi del conoscimento di Dio; laddove i cattolici operando per Gesù Cristo, santificano in lui le azioni loro, connaturandole colla carità che le trasnatura in celesti.
— Voi parlate come i predicatori, Ida mia; ma io vi ho questo po’ di cura per amore dalla Madonna; perché mi dicea matrima, che ogni bene convenia farlo per amore di Gesù e di Maria, che n’aremo il merito da loro; e cosi per sin da bambina ho fatto l’obbedienza per piacere a Gesù e alla Madonna, e quando dicevo le bugie e mandavo gli accidenti, e facevo li peccati, ne domandavo loro perdono prima di coricarmi.
— Vedi s’è vero ciò che io diceva; che i buoni cattolici anche senza porvi mente operano, mediante la virtù della grazia, per l’abito santo dell’infanzia?
— Sicchè dunque Gesù Cristo mio, di questo po’ di bene, che vi faccio, me n’avrà merito e mi concederà che Cencio sia buono e mi sposi presto. Dite, Ida, è un pezzo che siete cattolica?
A queste parole Ida si stropicciò alquanto gli occhi col dosso della mano, e domandò la Nunziata se li presso vi fosse persona. La giovane rispose, che no; perchè le Suore stavano in guardaroba, e l’infermiera di guardia medicava i vessicanti a una inferma in fondo alla corsia. Allora Ida palpeggiando prese la mano di Nunziatina e le disse — Sappi, amica mia del cuore, ch’io nacqui nobilmente in Isvezia, e fui educata con gentilezza secondo mia pari.
— Io il dicea pure, esclamò Nunziatina, così alla decana come alle inferme, che voi eravate gentildonna. Vedi s’io avevo ragione!
— Odi me, riprese Ida, e impara da’ miei errori come deono comportarsi le savie fanciulle nelle loro affezioni. Io era appena ne’ diciott’anni, e a quanto diceano le genti, io era avuta per avvenente: ed avevo una chioma bionda come il mele, e tanto copiosa che, sciolta, giungeami quasi alle ginocchia; era poi colorita d’uno incarnato vivissimo, onde le parenti e le amiche diceanmi la bella Ida.
— E dicean bene. Pensate! siete bella tuttavia a quarant’anni; che quando le inferme vi veggono a sedere sul letto, e io v’ ho ravviato e intrecciato i capegli, e avete in ispalla quel vostro gran sciallo colla goletta rovescia intorno al collo, dicon tutte — che bella signora ! peccato che la sia cieca —
— Bene. Di cotesta leggiadria io era vanerella assai , perchè le cameriere m’adulavano; e le cameriere guastano spesso le padroncine. I miei genitori viveano alla grande, e aveano cariche in Corte; onde spesso la sera veniano a veglia signori svedesi e forestieri; e aveavi musiche e balli. In uno di questi balli fu presentato a mia madre un gentiluomo, bellissimo, nobilmente vestito, e coperto il petto di croci cavalleresche, e diceanlo conte di Kalitva. Egli per fare onore a mia madre volle danzare con me, e quella sera mi chiese tre volte, con molta invidia delle fanciulle di mia conoscenza.
Questo giovane tenea gran vita in cavalli e slitte ricchissime, e livree sfarzose, e conviti e cacce, per tale che tutti aveanlo per opulentissimo. Aveva atti e maniere piene di gentilezza, cantava e sonava maestrevolmente, ed era amato e onorato da tutti. Cominciò a usare in casa nostra con una certa frequenza, ed io che già sino dal primo ballo era presa di lui, vedendo ch’era meco molto grazioso, m’accesi di lui sì fieramente, ch’io non aveva più pace se non quando potea vederlo. Nel nostro paese, quando gli uomini vengono a veglia, sogliono baciar la mano alle dame, sicchè una sera pigliandomi la mano per baciarla, mi lasciò cadere fra le dita un vigliettino. Figuratevi, Nunziatina, quanto mi batteva il cuore!
Quello fu il principio di tutti i miei guai; perchè s’io fossi stata una giovane giudiziosa, o non doveva riceverlo, o ricevuto, dovea con fiducia figliale consegnarlo a mia madre. Ebbi la sciocchezza di tacere, e d’intavolare una reciprocazione secreta di viglietti affettuosi. Ma le madri assennate e sollecite hanno sempre l’occhio desto sopra le figliuole per loro bene, e attendono che non mettano il piè in fallo; perchè mia madre essendosi avveduta che la notte mi coricavo assai tardi, una sera, ch’io la credeva già in letto, mi colse che rispondeva a Ratislao ; che così nomavasi l’ amante mio. Oh, Nunziatina mia, che rossore provai in quel momento! avrei voluto che si aprisse la terra, e mi sobbissasse. Mia madre prese il pacchetto de’ viglietti di Ratislao, tolsemi la mia letterina, ch’era già terminata; mi disse — Ida, andate in letto — e senza aggiugner parola ritirossi nella sua camera. Io rimasi fulminata.
La mattina vegnente entra nella mia camera assai per tempo la cameriera, dicendo — Presto, signorina, che papà l’aspetta nel suo studio — Oh! dissi nello svegliarmi, Papà? E mi ricorse subito al pensiero il caso di iersera; onde co minciai a tremar tutta e non avea forza di rizzarmi sul letto. La cameriera m’aiutò vestire, e quando fummo all’abito, m’apprestò quello di cordellone di seta grigia — Ma questo è da viaggio — , le dissi — Metta questo — , rispose, e intanto ch’io l’abbottonava dinanzi, tirò fuori dell’armadio la mia pelliccia di martore. Scendo da papà tutta pallida e vacillante sulle ginocchia. Papà non mi diede il buon giorno, nè il solito bacio in fronte, di che io fui atterrita e non osava alzare gli occhi — Venite, meco — disse con severo sembiante; e senza poter salutare mamma nè il fratello, scesi le scale e trovai la carrozza che ci attendeva: salì con noi anche la cameriera, e partimmo per Upsal, ove papà aveva un bel palagetto d’estate in sulla marina. In tutto il viaggio non disse una parola, e quando fummo giunti alla villa e smontati, era già preparata la colezione dai famigli, che papà avea colà mandato la notte.
Mentre i messi erano in tavola, e i due valletti usciti ad apparecchiare il caffè, quel silenzio mi piombava sul cuore, e mi sentivo morire: tutto a un tratto alzo gli occhi in viso a mio padre, che mi amava tenerissimamente, e veggendolo così accigliato, diedi in uno scoppio di pianto irrefrenahile. Papà si scosse, e pareva che anche a lui spuntasse una lacrima sugli occhi, che avvallò di forza. Beuto il caffè, ed usciti i famigliari, papà chiamò la Edvige mia cameriera , e voltosi a me , disse — Questo palazzo e questo parco che lo circonda sono i confini, dai quali non uscirete, Edvige, m’avete inteso; e quando uscirete nel parco non sarete mai sole, ma sarà con voi Canuto, il vecchio guardacaccia — E così detto, mosse per iscendere alla carrozza. Io volevo gettarmi ginocchioni a’ suoi piedi, abbracciargli le ginocchia, dirgli — Ah papà mio, perdonatemi — Nulla: rimasi intirizzita, e lo lasciai partire senza aprir bocca.
Mio padre tornato a Stokolma prese lingua intorno a Ratislao; e niuno sapea dirgli chi fosse, donde venuto, di qual condizione, di quali attinenze, che fosse venuto a fare in Isvezia: usava famigliarmente co’ grandi, vivea con isfarzo, e giocava fieramente ne’ pubblici ridotti di gioco, facendo per ordinario vincite disorbitanti. Qualche Ambasciatore susurrò all’orecchio di mio padre, esser lui de’ capi dell’Illuminismo germanico, e arrolatore della setta: altri accertava ch’ei fosse un famoso foruscito di Prussia, e condannato a morte per delitti di stato gravissimi. Tutte queste cose fermarono mio padre nella risoluzione d’opporsi al mio matrimonio con lui.
Io viveva in Upsal in una malinconia profonda e non mi dilettava nè di sonare il pianoforte, nè di disegnare, di che per l’addietro io era vaghissima, e dipingeva paesaggi con vivezza e con grazia forse più che ogn’altra nobil donzella di Stokolma : in quella vece leggevo romanzi caldissimi che avevo trovato nella camera di mia madre, i quali soffiavan nel fuoco e m’accendeano viemaggiormente la fantasia. Se le madri sapessero quanto questi libri seducenti, caduti in mano delle loro figliuole, fanno di guasto alla mente ed al cuore; credimelo, Nunziatina, non si arebbero a piangere tante cadute d’anime innocenti, tante risoluzioni funeste, tante vergogne, e tanti guai di famiglie che, senza il malanno di quei libri, sarieno state onorate e felici.
Ogni mattina nel pratello, che circonda il palazzo, veniva una pastorella di quindici in sedici anni, menandovi cinque montoni a pascere; ed io ne pigliava piacere; e perché ell’era poveretta le donavo alcuna fetta di pan bianco e burro della mia colezione. Era già quasi un mese ch’io vivea solitaria, quando una mattina la pastorella, nell’atto ch’io le dava il pane, si trasse del seno un foglietto, e mel porse. Io intesi un tal guizzo al cuore che mi tolse il respiro; e riavutami alquanto, le chiesi chi dato gliel’ avesse. Rispose, che un giovane signore che aveva incontrato fuori del parco. Questi era appunto Ratislao, il quale con brevi, ma caldissime parole, invitavami a fuggire l’esilio, ed essere felice con lui. Ah, Nunziatina, come talora le fanciulle imprudenti si lasciano vincere, anzi conquidere da certe parole lusinghiere, che trafiggono come una spada a due tagli! Quelle frasi di sposa, di felice, di ti amerò sempre, travolgon loro il cervello, e traboccanle in precipizio.
Richiesi la pastorella se quel signore attendea la risposta, e mi disse: che si. Io corsi in camera, scrissi colla matita — vengo; dimmi il come e il quando — La fanciulla fu lesta a portargliele; e Ratislao, datole un po’ di mancia, le disse; che domani l’attendesse quivi all’ora medesima. Lo passai quel dì e quella notte in una tempesta di cuore inestimabile, fingendo calma in sembiante, e stando sempre a lato la mia cameriera, siccome era usata di fare. Venuta la dimane, io attendeva sul verone mostrando di leggere, intanto che la cameriera tratteneasi ne’ fatti di camera; ma appena udito il fischio della giovinetta, che si parava dinanzi le sue bestiuole, scesi, le diedi il pane, e n’ebbi la lettera.
Quella fu la mia condanna di morte. Ordinavasi in essa con me il modo di scendere alla marina: Ratislao sarebbesi trovato nella ripa di sotto con una navicella a dodici remi; una nave a vapore stava in assetto di partire per Amburgo; là ci saremmo sposati. Intanto il pacchetto, che m’inviava per la pastorella, conteneva la scala di seta, da fermare alla mia finestra, per iscendere senza pericolo: egli aveane un’altra lunghissima che dall’alto sasso, il quale pendeva sul mare, m’avrebbe calato nel paliscalmo — Coraggio; Addio —
Io aveva la mia camera ne’ mezzanini sotto le camere di mia madre, e sopra i salotti del pian terreno, e però l’altezza non era eccessiva. La mia cameriera dormia in una cameretta di là dal mio abbigliatoio. Nel ritirarmi dopo la cena mi lasciai spogliare e porre in letto conforme era usata di fare; ma non sì tosto intesi la donna essere già coricata; adagio adagio ripresi i miei panni, e cosi al buio mi fui rivestita, aspettando la mezza notte. Quel giorno avea atteso a considerar bene gli occhietti dei due puntoncini, che fermano le finestre al muro quando sono aperte, perchè non isbattano al vento; e vidi ch’eran saldi nel telaio. Ebbi altresì l’avvertenza di chiudere a stanghetta l’uscio dell’abbigliatoto.
La torre di Upsal, avvegnachè lontana, in quel silenzio delle cose, s’udi sonare la mezza notte: io avevo già intromessi gli uncini della scala negli occhietti della finestra, e la scala stessa calata abbasso: era il mare tranquillo, né bava d’aria sentiasi spirar sulle onde chete e spianate del golferello sottoposto al palagio; quand’ecco al luccicore delle stelle veggo la navicella di Ratislao spuntare il promontorio. Io scendo intrepida, e in un attimo sono in terra. Un rematore posa un’antenna al sasso della ripa; un mozzetto vi s’arrampica leggermente, e giunto sul ciglio va cercando un brancone per attorcigliarvi la scala: come l’ebbe legata a dovere, Ratislao la salì, mi baciò la mano, e m’aiutò scendere in mezzo ai marinai nello scalmo. Intanto il mozzetto tirata su l’antenna, appoggiolla al davanzale della mia finestra, e come uno scoiattolo fu in cima : staccò gli uncini, e riscese rapidissimo colla scala di seta. Anco Ratislao era di già in barca; il mozzo staccò la scala, rimise l’antenna ritta dal sasso al legnetto, e sdrucciolovvisi dentro; cotalchè non era rimaso niuno indizio, ch’io fossi fuggita per la finestra.
— Oh Dio! esclamò la Nunziata, che pericoli! il vostro buon Angelo v’ha proprio aiutata, perocchè rischiaste di fiaccarvi il collo.
— Figlia mia, io fiaccai l’onore e la pace, che non potei più gustarne stilla pel rimorso che mi lacerava l’anima. Prima di fare un brutto passo il demonio dipinge all’immaginazione le cose con rosei colori e con luce gioconda; appena fatto, i bei colori e la luce dispaiono e lascian luogo alla notte, all’orrore e al terrore di morte.
— Usciste poi a bene, e vi fu almeno buono e amorevol marito?
— Udrai Nunziatina. Fra mille sospetti e pericoli d’essere inseguiti e raggiunti dai legni di guerra, che il Re di Svezia ci aveva mandato in caccia, giugnemmo in Amburgo, ove un ministro luterano mi sposò con Ratislao, ch’io credeva scismatico greco. Dapprima io penso che mi amasse di cuore, consolandomi della perdita de’ genitori, delle amiche e della patria; ma non riputandosi sicuro nelle città anseatiche, montò meco sopra una nave inglese, e sbarcammo a Edimburgo di Scozia, ov’egli prese albergo nella via di Canongatte. Non eran passati due mesi della nostra dimora in Edimburgo, e già in casa veniano gran personaggi, e teneansi adunanze secrete, e stavano grand’ora di notte chiusi nelle camere più remote, dalle quali usciano ad uno ad uno in silenzio senz’accompagnamento di servitori, e avendole carrozze in contrade fuor di mano.
Io passava i giorni e le notti soletta e in preda ai miei rimorsi, pensando sempre a mio padre che mi amava tenerissimamente, a mia madre ch’era sì sollecita di me, a mio fratello di cui era la gioia, ai pianti, ai rammarichi, alle disperazioni loro, alla vergogna mia; ed ora vedeami sola, senza conoscenza e priva d’ogni conforto. Una sera dopo la mezza notte Ratislao esce da una di quelle misteriose adunanze, entra in camera col viso pallido e contrafatto, e mi dice — Ida, raduna quanto puoi delle cose tue e delle mie; e senza altro dirmi dà mano egli stesso alle nostre valige, me le pone in camera, piglia il cappello, ed esce di casa. Dopo due ore torna con quattro facchini, m’aiuta serrare il bagaglio, mi fa mettere in dosso la mia mantiglia, e m’accenna di seguirlo.
Io tremava in tutte le membra, e sebbene appoggiata al suo braccio, non potea trascinarmi per la via che metteva al porto: giuntivi, e saliti a bordo di un vascello a vapore, quello in poco d’ora salpò, e prese alto. La mattina presso all’aurora, veduto mio marito dormire, ed io non avendo potuto chiuder occhio in tutta notte, salsi sovracoperta per alquanto riavermi alla brezza del mare, e mi posi a sedere sopra una panca. Di lì a un quarticello salirono due viaggiatori, i quali dopo aver passeggiato alquanto sedettero anch’essi poco discosto, e diceano fra loro in lingua tedesca da me bene intesa — Udisti, Franz, ciò ch’è avvenuto a questi giorni in Edimburgo? — Non saprei, rispose l’altro — È stato avvelenato nel thè un giovane Lord nobile e ricco oltremodo il quale essendo aggregato alla setta degli illuminati di Scozia, pare che abbia tradito il secreto. Dicesi che frequentasse certe congreghe secrete in casa d’un famoso capo dell’illuminismo, ch’è un avventuriere prussiano, il quale spacciandosi in Isvezia pel conte di Kalitva, rubò una donzella nobilissima e fuggì con essa. Il giovane Lord sentendosi morire, sembra che palesasse questa orribile trama — Come il sapesti? disse il compagno — Mi trovavo iersera in casa del Console d’Hannover, e un Commissario di Polizia suo amico venne a raccontarglielo.
Immagina, Nunziatina, che velo mi cascò dagli occhi! E quali tetri pensieri mi si ravvolgessero in mentel Non rimasi morta di subito, perchè Dio non volle. Come fummo pervenuti nel porto d’Anversa, Ratislao mi condusse in un buono albergo, e mi disse, che andassi a letto e riposassi dai travagli del mare; egli intanto andava all’offizio dei passaporti. Prima di coricarmi volli il mio baule in camera per trarne alcuna cosa nel rivestirmi; perocchè gli altri erano posati in uno stanzino di fuori. Io per la stanchezza presi sonno, e non mi svegliai che verso la sera: m’alzo, e chiamo i valletti, e domando se mio marito fosse tornato. Mi risposero, che sì, poco prima del mezzogiorno, ed avea fatto già portare il bagaglio altrove, nè più era tornato; io rimasi smarrita, e attesi fra mille angustie, ch’ei rivenisse. Scoccò l’ora della cena, e fui invitata a scendere nella sala comune, ove trovai di molti viaggiatori, ma fra essi non vidi mio marito.
Breve, l’attesi per tre giorni; il mastro dell’albergo ne fece ricerca alla polizia, ai Consolati, agli uffizii delle diligenze: niuno potè averne novella. Quando apersi la prima volta il mio baule vi trovai due rotoli in oro di dugento talleri l’uno, postivi da mio marito in Edimburgo, e in un taccuino, che io avea collocato sotto la biancheria, eran chiuse due cambiali sopra Londra pagabili a vista; una era di cento lire sterline, un’altra di cinquanta. Che dovea fare? Il meglio sarebbe stato ritornare a casa, e gettarmi ai piedi di mio padre e di mia madre; ma l’orrore della vergogna la vinse, e risolvetti di andare a Parigi. Ivi continuai a studiare il paesaggio nell’Accademia, e dopo un anno mi condussi a Firenze, ove alla scuola de’ fiamminghi e degli italiani, che decorano la Galleria de’ Medici, divenni pittrice di paese, commendata e ricerca dai forestieri, campando dei miei pennelli assai orrevolmente.
Tu puoi credere, Nunziatina, ch’io aveva mutato nome e condizione: e appresso a qualche anno ch’io era a Firenze volli visitare la Svizzera per disegnare quelle maravigliose prospettive de’ monti e de’ laghi de’ piccoli cantoni, dei contorni di Ginevra, di Losanna, di Berna e del lago di Costanza. L’anno vegnente mi condussi a Roma, ove la grandezza e la magnificenza gareggia colla vaghezza e coll’eleganza. I soli prospetti del Pincio, vedutivi dal ponte sant’Angelo, colla pineta di villa Medici che fa loro corona tra l’accademia di Francia e la Trinità de’ Monti, mi valsero tante copie l’una più leggiadra dell’altra, ch’io ne guadagnai di molto valsente; senza dirti poi ciò ch’io ritrassi delle stupende scene dell’Aricia, d’Albano, del lago Nemorense e dei colli di Marino e di Frascati, che dai viag giatori mi si pagavano largamente.
Io aveva lo studio in un sovrappalco altissimo d’un palagio con bella e vaga luce, che mi calava dolce e tranquilla sulle tele, ed ivi passava l’intere giornate. Vicin dello studio albergava una buona famiglia romana, la quale nella state tenendo aperti gli usci, io vedeva una graziosa giovinetta a’ suoi lavori d’ago sedere continua, e cantare con dolcissima e affettuosissima voce alcune canzonette della Madonna, che mi movevano a tenerezza e mi rapian l’animo a pensieri celesti. Alcuna volta passando mi facea motto, ed io l’invitava nello studio a vedere le mie dipinture; perchè a poco a poco io venni in molta dimestichezza della madre e della figliuola; la quale entrava talvolta col suo lavoro a tenermi compagnia mentre io dipingeva. Essa parlavami sovente della Madonna con tanta grazia e semplicità di modi, che bene le si vedeva in viso quanto il suo cuore ne fosse amoroso; similmente avea concetti bellissimi e caldissimi per provarmi l’affetto inestimabile che Gesù porta alle sue creature; e diceami i suoi contenti quando la si confessava, e le sue delizie quando s’accostava a ricevere l’Eucaristia. Poi io udiva la madre e la figliuola dire le orazioni insieme la mattina e il giorno, e recitare il rosario, e fare le novene a un loro altarino.
Queste cose moveanmi la mente a confrontare la vita de’ protestanti con quella de’ buoni cattolici; e ne’ luterani vedea un gelo mortale, e in cotesti invece una vita, un calore , una pace e una elevazione d’affetti , che noi non possiamo comprendere. Ma quando io dissi alla mia cara Giustina, ch’io era luterana, la povera giovinetta mi guardò come smarrita, calò gli occhi, e nel calarli le scesero due lacrime per le gote. Nunziatina, quelle due lacrime, che vennero spresse da una carità pura e sublime, furono per me più eloquenti di tutti i libri del mondo. Essa non osava quasi più di parlarmi; ma io vedeva tutta l’angustia dell’innocente anima sua e me ne dolea al cuore. Un giorno mentre io dipingeva, tenendo aperto l’uscio, intesi la Giustina dire alla madre — Mamma, è ora della novena a Gesù Nazzareno per la conversione della povera Ida — A quelle parole mi cadde il pennello di mano, e alla mia volta piansi anch’io d’un dolcissimo pianto.
Quel pregare per la mia conversione pareami un atto così alto e divino, che non potea muovere se non da una luce dello Spirito Santo, ch’è spirito di verità e d’amore. Dicea fra me — Che interesse hanno queste due buone amiche di vedermi cattolica più che luterana? Le amerei io forse di meno? Veggon esse, che avvegnachè luterana le amo assai: dunque la loro preghiera è tutta volta al mio bene; esse desiderano che anch’io goda quella pace ch’esse fruiscono; che ami il Signore con quell’amore vivissimo ch’elle si sentono in cuore; ch’io gusti anch’io le dolcezze de’ Sacramenti, la soavità della preghiera, il gaudio dell’anima pura che vive in Dio. Allora mi sovvennero più che mai tutte le mie passate amarezze, i miei traviamenti, il vuoto crudele ch’io sentiva da tanti anni nel fondo dell’anima; e con questo un desiderio cocente di sentire le consolazioni di Dio.
Giustina dopo la sua novena a Gesù Nazzareno venne col suo lavoro nello studio, e cuciva, e talora mi guardava pietosamente, mentre io dava certi tocchi al fogliame d’un bell’albero; io intanto sentiva nell’intimo del cuore un tumulto smisurato, e una interna voce potente, che mi di cea — Parla — Mi vennero dieci volte le parole alle labbra, e dieci volte le ringoiai. Tutto il paesaggio, che avea sotto il pennello, mi parea che si movesse , agitasse, annebbiasse e dileguasssi sotto quella nebbia folta che me lo rapiva agli occhi. Allora, tuttavia tramestando un colore sulla tavolozza, mi volsi a Giustina, e le dissi — Cara mia, mi vorresti cattolica? — Giustina imporporossi come una rosa del Bengala, e saettandomi con uno acutissimo e giulivissimo sguardo, rispose
— Dio il volesse, Ida mia!
— Chiamami tua madre. —
LA BUFALA
Tutte le umane cose sono dalla natura formate sotto diversi risguardi che variamente le colorano, come la luce che trasverbera i suoi raggi per gli angoli del prisma, il quale ad ogni muover d’angolo vi dà nuovo colore, e il colore medesimo isfuma in differenti gradazioni di tinte. Laonde gli uomini savii e prudenti non considerano mai le cose sotto un solo rispetto; ma le volgono ad ogni luce, e secondo gli aspetti differenti esaminano tranquillamente di qual colore si vestono; imperocchè avviene il più delle volte (a quella guisa che ne’ prismi) che un lato vi riesce in un color verde, un altro in un colore d’arancio, un altro in un colore vermiglio: ed è sempre la stessa luce, ma divisa ne’ suoi raggi, ognun de’ quali diversifica dall’altro, e tutti insieme riflessi vi danno il candore, e tutti insieme assorbiti vi danno il morato.
Così è a dire di que’ forestieri che ci espongono a voce e in istampa i loro giudizii sopra i cittadini romani, avendoli considerati sotto quell’unica mostra che cadde loro sotto gli occhi; laonde voi udite soventi querele, che a Roma tutti fanno grasso il venerdì e il sabbato, che tutti non si dan carico del mancare alla messa i dì delle feste; che a Roma non si crede nulla, che a Roma nelle case si lavora le feste come negli altri giorni ecc. ecc. — Adagio a ma’ passi. Chi dice e chi pubblica ne’ libri coteste fanfaluche stette in Roma due, tre, o quattro mesi al più; e ciò ch’egli ha veduto fare ov’egli viveva a scotto, crede e giudica che si faccia da tutta Roma. Per ciò don Alessandro ha voluto distinguere i varii popoli che sono in Roma senza esser romani; poichè la Roma de’ forestieri e degli artisti non ha punto che fare colla Roma, che si dice dagli esperti, la Roma Papale.
Troverete anche in questa le sue corruttele, come interviene ov’ha uomini di carne e d’ossa; ma se considerate le cose sotto il diritto lume, vedrete che la probità, la pietà e il verace sentimento cristiano supera di gran lunga nelle famiglie romane i rispetti contrarli: onde ciò che avvenne alla pittrice svedese, incontra eziandio a quei forestieri, ch’hanno la buona ventura di abbattersi a conoscere e usare di presso e intimamente con sì fatte famiglie, le quali sono in maggior numero che altri per avventura non si credeva.
Continuandosi adunque la Ida colla Nunziatina, le disse — Giustina senza menare una gioia smaniosa rizzossi composta, e andò senza aspetto a chiamare sua madre; ma io, che m’era fatta sull’uscio, la vidi, passando innanzi al suo altarino, gittarsi a ginocchi, alzare le braccia alla immagine di Maria, starvi pochi momenti, rialzarsi, ed entrare a sua madre, dicendo — Mamma, la Ida vi domanda — A me batteva il cuore come un martello; e giunta che fu nello studio, e chiestomi graziosamente: che volessi? io la guardava muta, e non le dicea verbo: del che essa meravigliatasi, dopo alquanto mi disse — Ida, vi sentite male? — No, Teresa mia, le risposi; ma vorrei da voi un piacere — Dite — Desidero, che mi mettiate nelle mani d’un buon sacerdote cattolico — La Teresa senza uscire della sua serenità, mi rispose, che ben volentieri: la vi penserebbe; e trovato chi abbisogna, pregherebbelo di venire a vedermi: intanto s’io gradissi di leggere la Dottrina Cristiana del Bellarmino me la darebbe; e voltasi a Giustina mandò pel libro.
In somma, che t’ho a dire, Nunziatina mia bella? Ebbi il prete, uomo amorevole, dotto, pio, paziente e benigno; fui bene istruita nella dottrina cattolica, e Giustina, mentre mi andavo ammaestrando, conduceami ogni mattina alla messa; alla benedizione dell’augustissimo Sacramento; ai più celebri santuarii della Madonna, nè più nè meno come s’io fossi già cattolica. Io mi sentiva rinascere ogni giorno viemeglio alla pace del cuore: e quando vedea la Giustina comunicare, e raggiar quel viso d’un lume sì soave e celeste, io l’invidiava, e la chiamavo beata, e mi parea mill’anni di gustare quelle dolcezze ignote e que’ misteriosi colloquii di Dio. Se non che quand’era poi sola, tornava a’ miei dubbii, alle mie tempeste, le quali duravano spesso sino alla venuta del sacerdote, che i dubbii mi chiariva colla dottrina, e le tempeste m’abbonacciava colla grazia de’ suoi modi e colla mansuetudine e dolcezza delle sue parole. Quando fui bene ammaestrata, io chiesi di fare l’abiura in una cappella di qualche Conservatorio, e vivere in esso alcuni giorni prima e dopo, a cagione di starmene più unita con Dio; il che ottenni agevolmente; e non ti potrei dire quanti belli esempi v’ho scorto, e quanta costanza vi attinsi nell’operare il bene.
Circa dieci mesi innanzi, che ciò avvenisse, avea letto nel giornale di Stokolma la morte di mio padre, e quattro mesi appresso quella della madre mia, ed io li piansi amaramente, e mi sentiva uno stimolo fortissimo di tornare in patria; tanto più ch’io non sapeva se l’unico fratello ch’io ci avea fosse ancor vivo. Iddio però avendomi tocco il cuore, e datomi la grazia di raccogliermi nel grembo della Chiesa Cattolica, in cui soltanto è salute di vita eterna, volli prima d’ogn’altra risoluzione convalidarmi e raffermarmi nella Fede e nella pratica del viver conforme allo spirito della Chiesa. Quando parvemi d’essere avvalorata abbastanza da reggere col divino aiuto alle persecuzioni, che da tanto tempo travagliano i cattolici di quel regno nobile ed infelice, partii di Roma e mi condussi in Isvezia.
Dapprima non mi volli manifestare, e pigliai voce dei fatti di mio fratello, il quale seppi ch’era in sullo spendere gagliardamente; e giocava e sparnazzava il suo all’ impazzata, per tale che i parenti prossimani erano ricorsi al Re, che gli imponesse un curatore. Quand’io coll’intramessa de’ buoni amici antichi di casa me gli scopersi per la sua Ida, che da giovinetto egli amava cotanto, non ti potrei dire con quanta allegrezza mi accolse, assegnandomi un bel quartierino in palazzo, e cameriera e valletti. La cameriera diputatami era figliuola d’un vecchio staffiere, e pareami che la m’avesse preso affezione: di che io , essendo nelle mie camere, non ini tenea molta guardia in fatto delle mie pratiche di pietà cotidiane, e de’ miei libri, i quali erano quasi tutti italiani; nè niuno della famiglia potea intenderli.
Avevo fra le altre cose un crocifissino d’oro benedetto dal Papa colle indulgenze di santa Brigida, e in articulo mortis, e della Via Crucis, che tutti i venerdì io metteami dinanzi sul tavolino, e ivi inginocchiata faceva orando e meditando le sante Stazioni della passione di Gesù. Egli è vero, ch’io mi metteva a questo divoto esercizio, quando la donna mia era colle compagne in guardaroba; tuttavia un giorno la mi vi colse, ed io seguitai senza dar vista di farne caso. E forse la non ci avvertiva; ma come Dio volle io dimenticai un giorno la mia chiavicina entro un forzieretto d’ebano, in cui solea tenere alcuna gioia, e le anella, e la mia corona di malachite, il crocifissin d’oro, e una bella copia della Immacolata Concezione del Morillo miniata in avorio e cerchiellata a filograna. E siccome le cameriere son curiosissime de’ fatti delle padrone, còlto il destro, ch’io pranzava con mio fratello, essa rovigliò il cofanetto, e sotto quel po’ di gioie trovò le sante immagini e la corona.
Non ci volle altro. Costei alla tavola delle donne cominciò a bucinare: che la Signorina era di certo papista.
— Che! disse la decana; la Ida quand’ell’era piccina, e veniva il vecchio ministro dottor Wolfango a insegnarle la credenza di Lutero, la ne sapea tanto, che il ministro chiamavala la dottoressa, e mi diceva a me: Questa puttina a dodici anni la ne sa più di quella bestia del dottor David, che si stima più dotto di Melantone.
— Ed io, riprese la mia fante, v’accerto, Susanna mia, che la signora Ida è papista; perocchè le ho trovato il crocifisso, il rosario, l’immagine di Maria, un anello colla croce, e poi una scatoletta d’argento con entrovi tanti ossicini, che i papisti chiamano reliquie. Ne volete di più? Quando l’aiuto vestire io le veggo al collo una medaglina d’oro coll’effigie di Maria e del Cristo: nell’uscire del letto la si segna sempre della croce: e non sono tutte coteste superstizioni di que’ dannati di papisti?
— Quand’è così, dissero tutte, egli bisogna accusarla al ministro Baruch, perocchè ci va l’anima nostra se noi aremo più consuetudine con esso lei: nè accade scusarci col dire: che noi siamo ai servigi del padrone, ch’è evangelico e la Ida c’è in grazia del fratello: tuttavia ell’ha le maledizioni del padre Lutero addosso, e servendola, ci si possono appiccare alla pelle come la lebbra —
Il caso è che costoro fecero un chiasso del malanno; il ministro Baruch ne fu avvisato, e venne in casa nostra, e fece un risciacquo in capo a mio fratello, che lo intronò. Mio fratello non credea più in Lutero che in Calvino, ma era un volteriano senza religione di sorte; nulla però di meno riputandosi ad onta l’esser fratello d’una cattolica e tenerla in casa, ne menò molto scalpore, e giurò a Baruch, che direbbe, e farebbe roma e toma. Fu significata la cosa al parentado: si tenne consiglio di famiglia; e si volea venire a mali partiti. Alcuno mi difese, dicendo: che noi siamo nati liberi, e possiamo appigliarci a qual risoluzione meglio ci talenta: altri impugnarono coteste ragioni, siccome dottrine di Rousseau; e sosteneano che le leggi di Svezia vietano l’esser cattolici sotto pena del bando e della confisca de’ beni. La conclusione fu, ch’ io me ne tornassi dond’era venuta. Io chiesi la mia dote, e il fratello negommela di punta, dicendo: ch’io era proscritta dalla legge, e avessi in somma grazia, ch’egli non mi accusasse ai tribunali: per solo amore fraterno mi darebbe di che fare il viaggio in Italia. Una buona zia donommi di molte belle robe, e fra esse questo sciallo di Persia.
La Nunziatina a questo passo non potè contenere le lacrime, le quali cadendo sulla mano della cieca la intenerirono grandemente; e per consolar la fanciulla, le disse — Iddio, vedi Nunziata, non mi abbandonò punto; e venuta a Roma ebbi tante commissioni, ch’io dipingendo ne traea di che vivere agiata, e fare alcune limosine, in ispecie ai parrochi pei loro poverelli, e ai frati che ogni sabbato veniano colle bisacce allo studio. Così la durai sino a tre anni addietro, quando il Signore si compiacque di mettermi a dure prove togliendomi a mano a mano la vista. Era in sullo scorcio di luglio all’Aricia a passarvi meno affannosa la state; e la mattina disegnava que’ certi annosi e pittoreschi del parco Chigi, e la sera da una pendice di Colle Pardo ritraea quel bellissimo prospetto della chiesa di Galloro, dietro la quale spuntavano le torri del castello del Principe e la cupola della Collegiata aricina, che nuotava in un mare di luce vaghissima per la caduta del sole nel mare tirreno.
Un giorno v’andai di buon’ora e il sollione percotea forte la selva de’ castagni, ma io avea teso il mio ombrello, e sfavami dando le masse d’un albero, quando udii un grido acuto dietro il dosso del manto: perchè rizzatami, corsi ratta a vedere che fosse; e trovai una pastorella, cui un cagnuolo avea sbrancato abbaiando le sue pecore, e quelle s’erano messe in volta e corse giù pe’ burroncelli per rinselvarsi: onde che la fanciulla correndo per aggiungerle, inciampò in un broncone e cadendo la s’era confìtto uno stecco nel pesce del braccio. Io corsi a trargliene; ma il sangue spicciava sì forte, ch’io dovetti col fazzoletto addoppiato a molti giri badare a lungo prima di stagnarlo. Quel sole così cocente mi fece sobbollire il sangue nelle vene del capo, e mi venne una scesa agli occhi, la quale sì ostinatamente rappigliossi intorno alla virtù visiva, che in pochi mesi m’ebbe spento il vedere: onde non avendo più potuto dipingere m’andai consumando a poco a poco il peculio ch’avea messo a parte de’ miei guadagni. La sola consolazione che m’addolcisce tanta sventura si è il pensiero ch’io accecai per un atto di carità, e m’incolse tanto male sotto gli occhi di Maria Vergine di Galloro che, medicando quella mammoletta, m’era di rimpetto oltre la valle; nè Maria l’ha permesso altrimenti che per mio bene, e mi conforta della sua grazia —
Queste cose narrava alla nostra Nunziata la buona ciecolina, che Iddio purgava come l’oro nel crogiuolo; e davale tanta pazienza e serenità di cuore, che tutte le inferme ne rimaneano edificate. Se non che nell’incrudire della stagione i dolori delle giunture le salirono al petto, e l’oppressero di maniera ch’ella ne fu aggravata a morte, con infinito cordoglio della giovane Trasteverina che l’assistette sino all’ultimo respiro, e la pianse come figliuola amorosissima.
Mentre la Nunziatina era quasi in piena convalescenza, fu portata allo spedale una fanciulletta, figliuola d’una tessitrice sua vicina, la quale essendo per umori scrofolosi consunta da una febbretta etica, fu posta nell’infermeria di s. Giacinto, ove curasi la tisichezza. L’affettuosa Nunziata, ch’era per la sua bontà molto graziosa alle Suore, chiese loro di visitare quella cara giovinetta, ed ottenutolo, saliva a tenerle un poco di compagnia, e ravviarle i capegli, e a portarle qualche confetto.
L’infermeria di s. Giacinto è un’ampia sala con finestroni sfogati per darvi aria che la rinfreschi a dileguare i viziali vapori, ch’esalano da tanti corpi contaminati. Chi desidera avere una ragion pratica della vanità umana, entri in quella corsia delle tisiche, e molte illusioni gli si torranno dalla mente circa la bellezza, che suol movere per gli occhi il cuore ad amar disordinatamente, e dare nei maggiori eccessi, ne’ quali questa terribile delle passioni suol traripare gli amanti: imperocchè per ordinario i tocchi da tisia sono sempre gioventù fresca de’ più verd’anni, che illanguidisce e disfiora, come la rosata giunchiglia sotto la bruma mattutina. In quelle sale vedi una lunga fila di letti con entrovi le più belle e dilicate giovani, sui graziosi sembianti delle quali si distende un pallore, una magrezza, un abbattimento, una mestizia, che ti piomba sull’anima. Quegli occhi, ancora sì vivi e neri, s’incavernano nelle livide occhiaie, e ti guardano d’uno sguardo brillante, come la fiammella della lampana, che scintillando si spegne. Quelle rose delle gote, non sono fiori, ma brage accese della febbre ardente che lor bolle nelle vene e ne dissecca e distrugge le polpe come la cera al fuoco. Quelle mani tornite un giorno sì gentilmente, ora son lunghe , aride e scarne: le folte e crespe chiome bionde e morate ora son viscide e flosce pel sudoretto acre che le ammuffa: tutta la persona, per lo innanzi così complessa e in carnata, ora è sparuta, istecchita, e un sacco d’ossa.
Quelle poverine, non poche delle quali teneansi per belle e vezzose, hanno in orrore lo specchio, e ne fu veduta più d’una svenire di puro spavento nello specchiarsi; eppure quasi tutte hanno speranza, come suole avvenire ne’ tisici, di guarire e rincarnarsi. Oh ch’è egli a vedere tante vittime d’amori contrastati dai parenti per interesse, o traditi dalla perfidia, dall’incostanza, dall’impegno, dalla seduzione, dalla vigliaccheria di chi spasimava per esse, e venne lor meno della fede! Queste infelici brucian del fuoco della febbre, e di quello vie più cocente del cuore, e non trovano conforto a tanta arsura, nè refrigerio a tanta angoscia. Ivi non è che il sacerdote di Dio, il quale abbia parole di consolazione, e con esse infonda quel balsamo che mitiga le più crudeli ferite e allevia i più profondi abbattimenti dell’animo.
Altre di quelle tapine scadono, e consumano il fior dellagiovinezza nelle erapule e nella dissolutezza, che le accascia e disnerba, infrollendo loro le carni addosso e corrompendone i sangui, sicchè gittate a marcire in un covile, son raccolte dalla carità cristiana negli spedali. Altre invece, appassiscono prima di sbocciare la natia vaghezza nel giardino del mondo, vinte e inaridite in sullo stelo per qualche vizio dell’infanzia e della prima adolescenza. Misere! che smorzano la scintilla della vita prima ancora che s’accenda.
Non mancano altresì nelle grandi città (e Dio volesse che fosser poche) fanciulle di buona e salda costituzione, che volgono alla tisia per la lunga inedia, a cui sono condannate da una povertà secreta, che in sul metter persona le fa lungamente languire. Nè il patimento della fame è solo; che forse la maggiore agonia di quelle infelici si è il vedersi la madre o il padre, nati civilmente e avvezzi un dì all’agiatezza, gemere in un fondo di letto privi d’ogni soccorso. La giovinetta piange e si desola nel cuore suo, e attende a dividere il tempo fra le cure della tenerezza figliale, e gli sforzi dell’assiduo lavoro, prolungato le intere notti per guadagnare appena di che sottilmente ristorarli d’un tozzo di pane. Quelle ambasce, che trapanano cupamente le viscere di quelle care e amorose creature, finiscono di consumarle; e benchè di buon naturale e gagliardo, scrosciano sotto il pondo che le opprime, e giunte ai vent’anni, una lenta tabe polmonare le declina al sepolcro.
La Nunziatina adunque recandosi a visitare quella sua garzonetta, la intrattenea dolcemente e porgeale conforto ragionandole di Dio, che l’inferma, siccome d’anima buona, sentasene tutta dilettare. A canto la proda sinistra del suo tettuccio era una diavolona di femmina sui trent’anni , grande, ossuta, con due mascelloni a bugna, di capelli rossi e sparpagliati giù per lo viso, che davanle aria d’una versiera. Costei era sempre dispettosa colle infermiere, borbottona, rampognevole, garosa, nè apria bocca senza imprecare, maladire e bestemmiare rabbiosamente. Quando le s’accostavan le Suore entrava in certe smanie crudeli, che faceanle digrignare i denti, e contorceasi per modo che le croccavan l’ossa come d’un carcame scommesso : allorchè poi li padri Crociferi attraversavano la corsia, e s’accostavano ai letti di ricontro per confessare e amministrare gli altri sacramenti alle inferme, costei volgeva il grifo dal l’altro lato, o ficcava sotto la testa o facea loro le gogne.
Costei era una schiuma di ribalde quanto immaginar» si possa; imperocchè ell’era nata di ladri, e allevata tra i furti, le frodolenze e le crudeltà: la madre sua era morta nell’ergastolo, e suo padre, fuggito al remo, e gittatosi alla strada, fu ucciso in una capiglia colla corte del criminale che lo sorprese in una imboscata. A’ sedici anni essa tenea già mano ai contrabbandi laggiù da porta Latina, e da porta s. Pancrazio, e da porta Salara ; caricandosi tal volta d’una mezza vitella, d’un montone e d’una cerchiata di merluzzo come il più gagliardo facchino. Ella non avea mai posta ferma: due notti dormiva sulla cordonata di Monte Caprino; un’altra sulla rupe Tarpea, o ne’ vicolettacci de’ Morticelli, e dello terme di Tito, sempre in tresca col pattume più sozzo e vituperoso di Roma, dando di spalla a tutte le ribalderie, a tutti i malefizii, a tutti i furti, a tutte le truffe che si commetteano dagli scherani e dai ladroni di giorno e di notte. Era la più destra maneggiatrice di grimaldelli, fabbricatrice di chiavi false, sconfìccatrice di usci e di serrami.
Siccome poi era grande e aiutante della persona, così nel 49 intruppatasi colle bande più fiere scagliossi a capo basso, nelle più arrischiate fazioni. Que’ masnadieri chiamavanla per soprannome la Bufala; tanto era pilosa, e d’occhio truculento e di collo taurino e d’omero rilevato. In quella tunica soldatesca e in quei calzoni rossi procedea burbanzosa, trascinando uno sciabolone che balzellava picchiando su per le selci e facendo un fracasso infernale: non usava moschetto, ma una grande alabarda falcata, che avea uno spuntone aguzzo di tre palmi.
Fu cotesta diavolessa, che nell’assalto notturno di una villetta urbana, trovato nella famiglia un prete, diegli della torcia a vento sul capo, dicendo per istrazio: che quella fiamma era il miglior rasoio da chieriche, perchè faceale grandi senza l’insaponata. Un’altra volta ita con un branco di scherani a una vigna di religiosi per foraggiare, costei visto il vignaiuolo, ch’era appunto un religioso travestito, e nol conoscendo per tale, afferrollo pel farsetto colla sinistra, e colla destra squassando l’asta della zagaglia, come una Bellona, gli disse — Mi vien detto per certo che tu ritieni chiusi e nascosti quinci entro di que’ cani de’ tuoi padroni: tracceli fuori che vogliamo fare trinci e fette di tonno da mettere in salamoia; ma prima vo’ loro cavar il cuore con queste mani e mangiarmelo crudo crudo. Assassini! qua; fuori; ove son egli cotesti maledetti? —
Il vignaiuolo senza punto scomporsi, e senza mostrare che la conoscesse per donna, le rispose: cittadino soldato, potete cercare tutta la casa e non ne troverete ombra. Allora cotesta furia cominciò ad entrare e rovistare per tutto dal solaio alla cava, sfogandosi colle immagini di Maria e de’ Santi; che trafiggeva e squarciava colla punta dell’alabarda, e radeva le incollate sugli usci, bestemmiando come un demonio. Nè avendo trovato persona, s’avvenne di scorgere fra la ciarpa un vecchio cappellaccio de’ religiosi, col quale sfogò le sue ire sforacchiandolo col puntone dell’asta, appunto come fanno i cani quando vien loro dato fra’ denti un cencio; che lo strappano, lo strambellano, rignandogli addosso, e saltacchiando e scorrazzandogli intorno.
Ma questa furia quando ebbe veduto i Francesi già entrati per le breccie di porta s. Pancrazio, pensò bene di serbare la pelle a nuove prodezze; e cansatasi bellamente dalla mala parata, gittò via la tunica militare, l’alabarda e il pennacchio rimettendosi in gonna, o sofficcandosi sconosciuta in certe casipole, che riusciano in sul fiume dietro a s. Paolino. Ivi in certi bugigattoli d’uno sfasciume di stalla essa avea nascosto e fitto sotterra un gruzzoletto di doppie e di gregorine che avea ruspato, parte d’involo e parte di truffa: ondechè la briffalda, fatta massaia, pensò d’aprire una botteguzza d’acquavite e di zigari verso il ghetto.
I suoi avventori erano il più trecconi, paltonieri, mozzi di stalla, giudei, stracciaroli, trippai, macellaretti e gentaglia di simil fatta, che la nostra bottegaia sapeva pelare e radere a dovere: se non che altresì eglino davanle talora il cambio facendole sparire qualche bottiglia di rhum, qualche cucchiaretto d’argento o qualche mazzuolo di zigari. Di che l’Amazzone dava in escandescenze crudeli: e se, perch’era sagacissima, interveniva ch’ella cogliesse alcuno sul fatto, quel tapino da una volta in su non s’ardiva di passare per quella via, tanto, di pugna e calci e graffi, te lo condia per le feste. Or avvenne, che un mariuolo ebbele rubato una sera un paio di zigari mentr’ella mescea l’acquavite a un caprettaro; ond’essa avvedutasene, abbrancò il pestello del mortaio, e guizzandogli addosso come un lampo, l’afferrò pe’ capegli e gli pestò il mostaccio sì fattamente, che gli s’era gonfiato come uno staio, e ne portò le ammaccature e i lividori per oltre a un mese.
Ma una ne fa il tavernaio ed un’altra il ghiotto, dice il proverbio; perchè il mariuolo, appena egli fu sdoluto, che cominciò a pensare della vendetta, e volle farla a misura di carbone. Costui avea posto mente che la Bufala desinava la sera, ma in sul mezzo giorno faceasi portare dalla vicina osteria una buona minestra con un pane e una foglietta di vino: veniala recando una ragazzetta in una zuppiera tonda entro un panieretto; laonde il brigante appostoli una mattina, e come la vide venire aizzolle addosso un cagnuolo ringhioso. La puttina cominciò a stridere e rannicchiarsi; ma colui fingendo di racchetare il cane, le corse incontro, dicendole: non aver paura. E il dirlo, prenderle la zuppiera di mano, gittarle un pizzico di morfina e, cacciato via il cane, ridargliela, fu tutto un punto. La fanciulletta seguitò suo cammino, ed egli svignossela pei traghetti, e fussi dilungato da quelle contrade. La Bufala prese la minestra, la quale essendo assai brodosa, e non avendola finita di mangiare, l’azione della morfina non l’uccise in poco d’ora; ma le guastò sì fattamente le viscere, che da quel momento innanzi andò sempre consumandosi e struggendosi come la neve al sole, sinchè si ridusse allo spedale di s. Giovanni.
Cotesta rea femmina piena di mal talento contro Dio, contra il prossimo e contra sè medesima, non avea mai un momento di pace, e si rodeva continuo, e smaniava come un’ossessa. La Nunziatina visitando la sua fanciulletta, la vedea triste, e chiestalene la cagione, la poverina le disse all’orecchio — Questa donna mi fa paura; e talvolta mi guarda con certi occhi così torvi, e dice tanto male parole, ch’io ne tremo tutta. Quando io rispondo alle litanie della Madonna, che la Suora intuona al nostro altarino dopo la caduta del sole, essa mi beffa; quando s’avvede che io recito da me qualche Ave Maria, la mi dice sciocca: quando il sacerdote esce colla messa, costei borbotta, e pronunzia certe brutte cose che le mi paiono bestemmie a me. Nunziatina mia, prega la Suora che mi levi quinci, e mi metta laggiù al numero diciotto.
La giovane le rispose; che avesse un po’ di pazienza; e intanto ne parlò colle Suore; ma che non sa fare la carità? La Nunziatina avea somma compassione di quell’infelice, che vedea struggersi ogni giorno e venir meno senza rimedio, e rincresceale al cuore di vederla sì iraconda ed iscredente senza poterle giovare; perocchè il parlarle di Dio era uno gittar zolfo sul fuoco. Che fece? Zitta e ebeta, senza dar vista di nulla salì alla Corsia di s. Giacinto, e sedutasi a canto della sua fanciulletta cominciò a leggerle per un quarticel d’ ora le vite delle Santa Vergini.
Da prima la Bufala n’avea dispetto; indi ne’ giorni successivi tratta alla curiosità de’ fatti, cominciò a poco a poco porgervi alquanto d’attenzione; ma la Nunziatina facea le viste di non attendervi; se non che terminata la lettura, nell’alzarsi, le dava un arancio mondo e cogli spicchi divelti a rosa: di che l’inferma, che avea le fauci sempre aride, sentiva gran refrigerio. Appresso la Nunziatina con dusse la lettura in sulla vita di santa Maria Egiziaca, di santa Taide, di santa Pelagia, le quali furono gran peccatrici, e tocche dalla grazia, e riconosciutesi delle loro dissolutezze, ne chiesero perdono a Dio e vissero in ammirabile penitenza. La Bufala, udendo leggere quelle smisurate ribalderie di quelle cortigiane, e com’esse poi per la grazia dello Spirito Santo le piansero sì lungamente nelle spelonche e negli orrori dei deserti, campando di radici d’erbe, dormendo sulla nuda terra, vegliando le intere notti nell’orazione; non sapea trovar luogo, tanto era vinta dallo stupore e tremore che sentiasi correre per l’ossa e pel san gue. La Nunziatina vedea che costei a quando a quando metteva il capo sotto le lenzuola, e sospirava e gemeva, e allora che traeval fuori, n’avea gli occhi rossi.
Ma come fu giunta leggendo a quel tenerissimo passo, che descrive santa Maria Egiziaca in quell’immenso e arido deserto così scarna, disseccata, e coperta dal capo a’ piedi de’ suoi capegli, che parea un’ombra; ed ivi fu trovata da quel santo Padre a cui narrò i suoi peccati e i quarant’anni di penitenza; e gli chiese in grazia che le portasse il santissimo Sacramento; ricevuto il quale, morì portata dagli angeli in cielo; la Bufala cominciò a tremare, e gittate improvviso le braccia al collo della Nunziatina, singhiottendo le disse — Deh, buona giovane; chiamami il sacerdote — Quella nol si fece dire due volte; ma rizzatasi immantinente, corse giù dal Padre Crocifero, e glielo condusse.
Parea proprio che il Signore l’avesse trattenuta nello spedale qualche giorno di più per salute di quell’anima; perocchè il giorno dopo vedendo i medici la Nunziatina omai bene avviata nella piena convalescenza, la licenziarono; e venuta sua madre a riprenderla colle amiche, a sommo rammarico delle Suore e delle inferme, che per le sue belle qualità l’amavano tanto, uscì dallo spedale, e si ricondusse alla casa paterna.
IL RITRATTO
Come Gasparetto ebbe ricevuto da Carlo pittore il ritratto della Nunziatina in fotografia sì recollo a Edmondo, il quale non è a dire quanto contento ne avesse, e quanto l’andasse considerando, e lo commendasse di perfetta somiglianza con quello che pendeva dalla parete di Carluccio. Indi chiese a Gasparetto in qual modo avesse potuto indurre il pittore a concederglielo così agevolmente: perchè inteso tutta la trama della Giuditta, si cacciò a ridere, e disse — Gasparetto, tu hai vinto la mia aspettazione; ma se tu hai stretto il convegno di ottocento scudi pel quadro, io intendo che tenga il patto.
— Che dite, signor mio? Noi ci abbiamo cavato la fotografìa, e basta: voi ora lasciate fare a me a scovare la lepre: intanto sappiate che la giovane è chiamata la Nunziatina: e voi ne vedrete cogli occhi vostri l’originale.
— Gasparetto, io non son uomo da ciurmare nissuno. Il quadro è commesso; Carlo farallo, e io pagherollo, e sarà l’ornamento più bello delle mie stanze. Eccoti il prezzo della fotografia; ed eccoti dodici scudi di mancia; tu trovami la Nunziatina e farai buona giornata.
— Perdonate, eccellenza, ripigliò Gasparetto; per la Nunziata sarà negozio mio; ma io bramerei un favore, ch’io spero vorrete accordarmi; poichè non vi costerebbe in tutto che due parole. Sappiate che io ho un amico, il quale abbisogna della vostra protezione per una disgrazia, ch’egli incorse proprio all’impensata: questi domandasi mastro Menico; ed è un chiavaro valente nell’arte sua; uomo dabbene, e di lieta condizione; buon amico, e canta a aria con bella voce e meravigliosamente intonata; sicchè egli è chiesto di spesso a cantare ne’ cori popolari in tulle osterie fuor di porta, e nelle serenate degli innamorati: cose innocenti e da gioie popolane, che ora in Roma, causa i tempi tribolati, vanno scemando.
Ora vedete avventura! Un certo popolano, vocato mastro Peppe, giovane assai benestante, s’ incapricciò d’una popolana appunto di Trastevere, e però cerco il Cecco de Nonna che suona il mandorlino come un Nume, il richiese che andasse con lui una sera a suonare con due cantori la serenata sotto le finestre. Come andasse la cosa nol vi saprei dire; ma la giovane non si fece mai alla finestra: di che mastro Peppe ne fu d’una gran mala voglia. Chevolete? Entrarono a bere nell’osteria, e qui mastro Menico disse a caso non so che, onde mastro Peppe recosselo ad ingiuria, e stigato dall’ira gli sputò in faccia: poscia pagò l’oste e andossene.
Mastro Menico sentì di quell’affronto una stizza, che die vel dica; perchè uscitogli dietro per dargli due sgozzoni ben assettati, mastro Peppe gli si voltò incontra come un leopardo; e avvegnachè fosse mingherlino e mastro Menico un colosso, nulla però di meno lo incaricò di pugna e calci sì fattamente, che stramazzollo in terra, e gli suonò il resto: indi se ne fu ito pe’ fatti suoi. Mentre il povero chiavaio era così in terra e penava a rizzarsi, eccoti quattro carabinieri, che te lo ricolgono, e menanlo diritto alle carceri nuove, ove il meschino geme da tanto tempo.
— E di mastro Peppe che fu? Chi era egli cotesto mastro Peppe?
— Chi lo sa? Per quanto si cercasse non ne fu trovato mai indizio: chi l’ha per ispia, e sotto vista di mescolarsi colle brigate, attinga nella sua spugna quanto vede e ode per ispremerla poi, chi sa dove? Altri lo presumono un ladro; perocchè avea di molti danari in tasca, che non è a credere che un popolano possegga tant’oro da scialacquare; figuratevi! Per la spesa di pochi paoli, gittò all’oste una gregorina come se la fosse un baiocco, e andossene. L’oste non l’avea mai veduto; Cecco de Nonna non lo conosce, i due cantori furon pagati innanzi tratto, e non ne seppero di vantaggio; sicchè può egli esser altro che ladro e furo —
A quelle parole Edmondo sentì salirsi al viso un rossore, che tradiva il rimorso e la vergogna d’avere prostituito la sua nobiltà, trascinandola per le bocche plebee, e insozzandola pel fango de’ trivii e delle taverne. Gasparetto accortosi di quell’alterazione, disse — Veggo che a vostra eccellenza monta la collera in faccia a vedere cacciato in carcere quel brav’uomo per cagione di uno ignoto di mala voce: e però io lo raccomando alla vostra protezione, supplicandola di fare una buona parte con don Alessandro mansionario, tanto amico di vostra eccellenza, il quale è nelle buone grazie là di quei Signori del tribunale.
— Ne parlerò benissimo con don Alessandro, ch’ è si buono e sì generoso, il quale quando può giovare al prossimo non si risparmia davvero.
— Ditegli, ch’è un povero padre di famiglia, carico di figliuoli che campano del suo guadagno, e da ch’egli è in carcere, la moglie e i figliuoletti sono attenuati e strutti di fame: quella povera donna ha impegnato sino al materasso, ed essa e quei tapinelli dormono in terra sopra un covoncello di paglia. La mia Doralice alle due femminucce dà ogni giorno un po’ di minestra, e la Nina, il credereste? piglia il solo caffè per serbare la sua pagnottella a quelle povere ragazzine. Ora la moglie è giù da Doralice che piange, e ci ha portato da vendere uno di que’ piattelli dipinti nel cinquecento, che ricercano tanto i forestieri; l’avea in casa da molto tempo, forse recatovi col corredo di qualche avola, come si usava per lo passato.
— Dimmi, Gasparetto, che figure v’ha egli? parti di buona mano?
— Egli v’ha nel tondino uno scontro di due cavalieri in giostra che si investono colle lame: pel rimanente è di mezza mano e non v’è nulla da scialare.
— Va, recami il piatto, e venga anche la moglie del tuo mastro Menico; io vedrò con don Alessandro che vi s’adoperi intorno per liberarlo —
Quando quella povera donna fu dinanzi a Edmondo, vedendola sì sparuta e sì mal condotta, egli ch’era uomo di cuor nobile e affettuoso, sentì una stretta di compassione; e conoscendo d’esser stato il primo ad offendere mastro Menico, avrebbe voluto ristorarlo; ma in modo che nè egli s’avvedesse, lui essere stato quel mastro Peppe che sopra ira gli sputò in volto; nè che la sua famiglia, caduta per sua cagione in tanta inopia, soffrisse il rossore d’una elemosina: onde preso il piattello in mano, e fatto mostra che la dipintura fosse d’autore valente, diede nelle meraviglie, e cominciò ad esclamare — oh bello! — Quanto ne domandate, buona donna?
— Quanto piace all’eccellenza vostra, rispose: io non ci capisco nulla; voi, vostra signoria, fate voi; io sono una povera moglie che ha il marito in carcere, non per ruberie, sapete, ma per un po’ di vino che gli diede al capo, entrò in una scarmiglia con un pezzaccio tristo, che lo fece balzare in prigione: onde pensate che per fornire quel pover uomo d’un po’ di grazia di Dio, e torgli dinanzi la broda dei carcerati, e’ mi conviene sgranellare un paolo ogni giorno; e intanto io e i figliuoli, che ce n’ho un mucchio, ci riducemmo a un po’ di cruschello tanto da tenerci vivi ; tuttavia mi fu forza impegnare la biancheria, le vesti, i vasi di rame, e per ultimo sino al Ietto. Io mi raccomando a vostra eccellenza ; datemi ciò che stimate —
Allora Edmondo, che sentiasi serrare il cuore, diede alla donna venti scudi in quattro gregorine d’oro, che quella poverina mirava estatica: poscia le disse — Portatemi tutt’i viglietti del pegno, ch’io vedrò di ricuperarli, e per la liberazione del marito lasciate fare a me — La donna credea di sognare, e baciava la mano d’Edmondo, e la bagnava di lacrime, e non sapea dire parola; tanto la piena della consolazione aveala sopraffatta. Se non che noi non sapremmo chi più ne godesse, o lei o Edmondo, perch’egli provava tanta letizia che non sapea capire in sé stesso: nè si tenne pago di quel soccorso, ma tanto brigossi che fece uscire di carcere mastro Menico; e sino a che egli stette in Roma continuò a fargli del bene.
In questo mezzo tempo Gasparetto avea preso da canto la Nina sua nipote, e fattole vedere il ritratto della Nunziatina, e narratole il desiderio d’Edmondo, le disse — Tu dèi studiarti per ogni guisa di trovare in Trastévere la giovane, che tu vedi ritratta in questo quadruccio: e fa che la cosa non abbia indugio, che buon per te e per me alla bella mancia che n’avremo. La fanciulla si domanda la Nunziatina ; ma tu avanti pur di nomarla, vedi se nella contrada la conoscono al primo sguardo: tu se’ sperta, e m’hai inteso.
— E a qual fine, se è lecito, volete voi aver contezza di cotesia giovane; avete voi alle mani qualche buon maritaggio? Eh, già; voi cercate d’allogare le sconosciute, che vi s’attengono appena in Adamo, e vostra nipote è sempre nel dimenticatolo, n’è vero? Ma intendo bene: le altre non vi chieggono nè la dote nè il corredo: io poveretta vi servo da tanti anni, mi consumo per voi altri; sono oggimai ne’ ventisette, e non si parla mai neanco di farmi un po’ d’acconcio. Bella cosa eh? Avevate pur tutto il tempo di farmi avere dal Curato la dote delle Orfane, e la dote della Nunziata, e quella di s. Girolamo della Carità: non fosse altro vi si caverebbe il letto maritale, le lenzuola, e qualche dozzina di camicie. Ma Nina è la dimentica: buono però che io m’ ingegno da me; pel rimanente: Nina, aspetta.
— Be’ se tu giugni a trovare la Nunziatina, io spero che n’avrai tal presente dal signor Edmondo, che te n’uscirà materasso e guanciali.
— E quando io avrò rinvenuto cotesta gioia , che ne verrà egli di buono al signor Edmondo?
— Chi può colpire nel segno coi capricci di certi signori? E se la si volesse sposare in moglie e farla di tessitrice contessa, che vi sarebb’egli a dire? Noi ne vediamo di cotesti mogliazzi di serve e di villane più che mai. Ognuno ci ha i suoi gusti, e prosit. Oh su via escine, e non voler cercare il terzo piè alle galline —
La Nina cominciò a pensare i traghetti da correre per giugner tosto al suo intendimento; e le sovvenne di Ceccherella, (quella scoiattoletta, di cui parlammo nel capitolo del Ranocchiaro), colla quale fu a scuola da piccina, presso una buona vecchia nei vicoli di sant’Agata. E perocchè ambedue erano cervelline e non sapeano posare un minuto, così allora viveano in istrettissima amistà come due passerette sulla medesima colombaia; ma poscia fatte grandicelle Ceccherella si fu accontata colla maestra di tessere, e la Nina ringentilì presso la zia vestendo da paina e laureandosi in utroque, come fu detto ne’ capitoli precedenti.
Venuta la domenica, e la Nina acconciatasi di tutti i suoi vezzi, con un cappellino di velluto color di rosa e con uno sciallo cilestrino a fioroni, se ne andò soletta per la via di ponte Sisto a trovare Ceccherella, ch’era appunto seduta sull’uscio con tre compagne ragionando delle prossime nozze di Rosalba. La Ceccherella era in capegli, e vestiva una polacchetta d’indiana verdepomo guernita di cordoncin bianco; nè aveva anella in dito, nè penzigliavanle dagli orecchi le gocce, paga a due cerchielli schietti, siccome a povera tessitrice. La Nina gittò le braccia al collo di Ceccherella, baciucchiandola e carezzandola con un amore e un’enfasi da mangiarsela viva; di che le compagne erano in gran meraviglia, non sapendo chi si fosse quella paina sì degnevole e affezionata.
Ma la Nina, vedendo la Ceccherella alquanto peritosa, cominciò a gridare — Oh Ceccherella mia, non mi conosci più? Son la Nina, che andavamo a scuola insieme dalla sora Cecilia là da sant’Agata: ti ricordi ch’ io ero tanto chiassona e andavo a dare li pizzichi alla Lena, alla Lalla e alla Tota? e la sora Cecilia mi metteva in ginocchio colle mani incrociate sul petto, ed io le faceva le cornette; e voi altre ridere, e la maestra gridare — State zitte, anticori. —
— Oh sora Nina, sì che ora vi riconosco! Mi ricordo che la sora Cecilia la diceva, che noi due invece di sangue avevamo nelle vene l’argento vivo. Ma venite dentro, sora Nina mia bella, che troveremo una scranna; noi poverette sediamo sull’uscio: che volete? dentro Roma si vive da signori, e noi qui di Trastevere andiamo alla buona. Oh e che buon vento v’ha condotto alla Lungaretta?
Andavo a s. Michele, ov’è una giovanetta fra le zitelle, ch’ è figliuola d’una mia amica, e passando di qua, e risovvenutomi di te, volli farti motto per rappiccare l’antica conoscenza.
— Bontà vostra: sedete, posate pure il vostro involtino qui sulla tavola: ci manca un piede, ma appoggiata al muro la sta ritta.
— A proposito dell’involtino, vi ci ho dentro il ritratto di una bella Trasteverina ; ma io credo che sia dipinto a idea, e non tolto dal vero. Ci vuol altro a trovare un viso sì leggiadro, com’è ivi ritratto!
— Che dite, sora Nina ? Non fo per dire, ma in Tra stevere vi ha de’ grugnetti, che dentro Roma si, bàciati la mano, e trovali se ti basta la vista. Abbiamo la Nannerella, abbiamo la Susanna, abbiamo la Nazzarena, che son tre sorelle : mi dicea mamma che’I sor Pinelli quando faceva li rami di Meo Patacca veniva sempre in Trastevere a ritrarre le nostre giovinotte, e la Nuccia, fidanzata di Meo, l’è proprio la mia mamma, disegnata dal sor Pinelli. Eh che intaglio di testa! Mi dicono che gli inglesi ora comperano quei profili a un mucchio di scudi l’uno.
— Come vuoi, Ceccherella, ma questa mia ha una grazia. . .
— Ben, lasciatecela vedere questa maraviglia. La Nina, che aveva la fotografia involta in un bel faz zoletto di seta, cominciò a rialzarlo canto per canto, e quando l’ebbe scoperto, tutte quelle fanciulle uscirono in un O più tondo della bocca del pozzo, esclamando — V’è ! proprio questa è la Nunziatina! ell’è tutta lei maniata — La Brigida- gridò — Quella fronte alta e spanta, quei grandi occhi, quel mentolino sì ben tornito con quel soggoletto, che appena si pare; son cosa sua: o Nunziata mia, come ti veggo tutta te! Quanto se’ bella!
La Sabina a quelle esclamazioni non dava retta, e parea compresa di meraviglia e di sdegno; finalmente esclamò anch’essa — Come mai, Nunziatina mia dolce amica, tu che fosti sempre cosi savia e contegnosa, ti se’ condotta a lasciarti mirare in viso come le modelle di Via Laurina? Che si dirà delle pari nostre? Chi ci avrà più in conto di modeste, se la più composta e probata giovane di Trastevere ha fatto copia del suo volto ai pittori? Oh Nunziatina mia, ov’eri col capo quando ti lasciasti sedurre a tanta profanazione?
— Uh che c’è egli a predicare? interruppe la Ceccherella; Cencio il suo fidanzato, prima di sposarlasi ha voluto il suo bel mostaccio in un foglio: che v’ha egli a ridire? E se il mio Toto mugnaio vuole il mio visetto in carta e’ se lo pigli.
La Nina diè luogo ai commenti; poscia rivoltasi alla Sabina, le disse — Chetatevi, buona giovane, che la povera Nunziata non ci ha una colpa al mondo; se pure colpa la volete chiamare, ch’io in vero non ce la veggo punto, altrimenti l’arte della pittura potrebbe irsi a riporre. La Nunziatina fu ritratta ad insaputa di lei; e però quando voi dite che queste sono le sue fattezze, io ti prego, Ceccherella, di dirmene alcuna cosa, perocchè essa è una vistosa fanciulla per fermo.
— E buona, ripigliò la Sabina, ch’era impaziente di giustificarla presso la Nina. Voi non sapete fior di giovane ch’ è la Nunziata: ella savia, ella modesta, ella pia, ella sempre lieta: nell’arte del tessere ha poche pari, ed è maestra di molte, e adopera con esse più da sorella che da maggioringa: essa ha poi un cuor da Cesare, o benchè la sia poveretta, la donerebbe alle più povere di lei sino alla camicia, massime se le sono giovinette appariscenti e da pericolare. Per queste belle prerogative la si fa amare da tutti, e il mese passato la ci ha fatto piangere assai, perocchè abbiamo rischiato di perderla.
— Oh davvero? disse la Nina. Voi mi fate paura : le avvenne forse qualche disgrazia?
— Fu presa da un’angina sì subita e sì crudele, che ce l’ebbe quasi a strozzare: fu portata allo spedale di san Giovanni, ed ivi penò tanto a guarire, che si temeva d’un ulcere in gola. Finalmente, come Dio volle, si fu riavuta, ed ora sta meglio che mai, e ci tiene allegre; perchè l’è d’una ilarità e d’una facezia singolare. Canta con una voce da rossignuolo; ma canzonacce da quella gola non escon mai, e la non vuole che le sue fattorine le cantino; che guai! Persino nelle ottobrate (in cui talora s’odono certe strofette un po’ troppo grassoccie) la Nunziatina canta le Glorie di Roma. In somma per compiuta fanciulla è dessa.
— Abita lontano di qui? disse la Nina, io la vorrei pur vedere.
— Vedete là dirimpetto le sue finestre, rispose la Ceecherella, e se la fosse in casa ve la chiamerei incontanente; ma ell’è ora alla dottrina cristiana in parrocchia, ov’è maestra delle grandicelle; non tarderà a venire, essendo già presso l’ora di terminare. E in fatto poco stante la videro venir verso casa.
— Eccola, eccola, gridò Cecchérella : vedete onor di fanciulla : come porta bene la vita; com’è composta, come ha l’aria contenta — e cosi dicendo, fattasi in sul limitare dell’uscio, e spenzolatasi fuori, cominciò a chiamare: O Nunziatina, vieni, vieni : siamo qui una brigata che t’attendiamo.
— La giovane accostossi, e disse sorridendo — Uh che fretta! lasciatemi riporre in casa il fazzolettone da capo.
— No, no, vieni subito: vedrai, Nunziatina, che bella cosa. Ma bella, sai, bella come te.
La Nunziatina, ch’era graziosa e agevole colle amiche, entrò dicendo: Sarà una delle tue, Ceccherella: e in così dire fu nella stanza ov’era la Brigida, la Sabina, e la Nina; perchè salutatele, fu invitata a sedere. Ma la Ceccherella, sempre avventata, tolto di subito il quadruccio del ritratto, e tenendolo con ambe le mani, si pianta ritta dinanzi alla Nunziatina, dicendo: guarda e specchiati. La Nunziatina alza gli occhi, mira un po’ fiso, e li riabassa tutta peritosa e divenuta rossa come una fiamma viva.
A quella accesa incarnazione la Ceccherella, senza moversi punto di luogo, cominciò a entrare nelle più pazze risa, gridando — Nunziatina, dammene a me un poco di quel tuo vermiglio: come se’ rubiconda! che vedestu in questo specchio? eh, la conosci? ti par bella ? Vedi se Cencio tuo l’ha fatta da paino! Ti ci ritrovi, Nunziatina mia? Su, alza quegli occhi; andiamo; che smorfie son queste? Guardala in viso la povera Nunziatina.
La giovane ricompostasi alquanto, disse: io non credo che Cencio m’abbia fatto questa celia: io dirollo a mio padre, e mastro Simone non è uomo da berte. Chi m’ha ritratto ne renderà conto a lui — Così dicendo rizzossi da sedere; ma le amiche sue le furono addosso, e con una dolce violenza la rimisero sulla sedia, volgendosi alla Nina , e pregandola di chiarire la Nunziata del fatto: la quale narrò schiettamente, che l’Ottobre passato un buon maestro dipintore vedutala in un orto la ritrasse ch’ella punto non se ne avvide; nè il fece per altro che per avere una testa da figurare una Giuditta: si desse pace, che non vi furono sinistre intenzioni. Anzi, già ch’essa aveva avuto la bella ventura di fare la conoscenza di lei, le offeriva quel ritratto da donare al suo Cencio, o da lasciarlo a mastro Simone suo padre, acciocchè quand’ella fosse a marito vedesse continuo la sua cara Nunziatina —
Come resistere a sì ben composte e dolci parole? La giovane accettò il ritratto, e ne ringraziò la Nina; e le altre compagne le fecero di molta festa intorno, dicendole: che la Nina è un’antica amica di Ceccherella, e per sua amorevolezza s’era alquanto voluta fermare per rivederla, venutavi sin dalla via del Babbuino.
— Nè sarà l’ultima volta, riprese la scaltra, che avea i suoi secreti disegni; anzi avendo conosciuto sì garbate fanciulle, come siete tutte voi, se non vi disgrada io tornerò domenica su quest’ora, che voglio che facciamo una buona merenda nell’orto dietro all’arco de’ Tolomei. Ho fatto un servizio a una pasticciera di Campo Marzo, e la m’ha promesso una bella pizza di marzapane con quattro fiaschetti d’Alicante: oh ce la vogliamo trionfare insieme fra la verzura. Cinque bicchieri li troveremo.
— Siam poverette, disse la Brigida, ma sino a mezza dozzina di bicchieri ci possiam giugnere.
— Sì, un bicchiere di più servirà per mio zio , soggiunse la Nina, che ci recherà la pizza e l’alicante: vogliamo stare allegre, vi dico io: oh beata me che ho trovato sì buone e care giovinette. Ma io dimoro lontana, e adagio adagio me ne vo ritornare. Addio: à rivederci domenica; dopo il catechismo, già si sa, perchè la Nunziatina nol perda: prima il dovere e poscia il sollazzo.
Mentre l’astuta era già in via pel ritorno , le quattro Trasteverine facean crocchio cianciando della Nina, de’ suoi bei modi, del suo bell’abito a quadroncelli verderossi alla scozzese, del suo fare spigliato alla cittadina: quando la Nunziatina picchiatosi in fronte: ah, disse, ho dimenticato di domandare alla Nina in qual modo le fosse venuto a mano questo ritratto.
— Che va’ tu a cercarne? rispose la Ceccherella: queste che abitano nelle’ contrade intorno a piazza di Spagna sono sempre coi pittori e cogli scultori : l’avrà forse avuto da chi ti ritrasse, il quale starà forse a pigione nella medesima casa, di Nina.
Costei giunta a casa, e venuta la sera, salse con Gasparetto alle stanze di Edmondo, il quale come la vide — Ebbene, le disse, l’hai tu trovata? — L’ ho trovata sicuro, rispose; e cominciò a narrargli tutto il caso dell’amica, delle compagne, della chiamata di Nunziatina, della sua collera nel vedersi ritratta, e finalmente della pace, e della promessa di merendare domenica nell’orto. Di che se Edmondo fu il più lieto uomo che immaginare si possa, non è a dire; e la Nina s’ebbe la sua mancia fiorita.
Giunta la domenica, e convenuto colla Nina ogni cosa, Edmondo si sentiva battere il cuore come una palombella: tanto questo uman cuore così superbo ed altiero, che sovente disdegna d’inchinarsi all’ossequio di Dio, per giusta pena Dio il fa umiliare e tremare dinanzi a una creatura dispregievole e vile. Edmondo, che per quella plebea avea perduto la sua pace, il suo decoro, la sua nobiltà e l’onor suo, vituperandosi in mille guise, ora godeva in sé stesso di essere giunto in fine al compimento de’ suoi desjderii. Egli adulava sè stesso d’altezza d’animo, perciocphè gli parea di non avere in essa mai avuto sinistri intendimenti, e d’esser mondo appieno di lei; ma non volea considerare, che l’uomo declina dalla sua altezza locando il cuore in luogo basso, e molto più adoperando mezzi indegni a cagione di pervenire anche a fini onorati.
In Edmondo era egli amore o capriccio? Era l’uno e l’altro; ma sì l’uno come l’altro meritava biasimo dai savi e discreti uomini; e il peggio si è, che molti in età più matura ridono di coteste pazzie giovanili, e se ne fan belli, e le narrano per iattanza siccome imprese di spiriti bizzarri, facendo rallegrar la brigata di ciò che dovrebbono arrossire e confondersi fieramente. Ma la fatuità del mondo di ciò si pasce e contenta; e se noi ce ne facciamo scherno siamo avuti in conto di zotici e mal conoscenti delle ilarità e prodezze mondane.
Come la Nina fu pervenuta alla casa di Ceccherella ivi trovò con essa la Brigida e la Sabina; e atteso un poco, ed ecco la Nunziatina che tornava dalla parrocchia: le altre si misero anch’esse il fazzolettone in capo, e uscirono alla volta dell’orto. Lungo la via, ch’era breve, Nina disse loro che suo zio avea creduto d’aggiugnere alla pizza una mezza libbra di fette di prosciutto per avviar meglio il bere: di che le giovani furon liete: e poi soggiunse quasi alla sbadata — Lo zio trovossi impacciato , perocchè la pizza è grande e quasi la non capiva nel fazzoletto, laonde non vi potè porre insieme le bottiglie: allora se ne mise una per tasca del vestito, e pregò un signore, ch’era con lui, di porre le altre due nelle sue tasche, e lo fece volontieri; ma dicendo, che siccome egli non vi conosce, posato che avrà l’alicante, andrassene a passeggiare altrove
— In questo favellare furono all’orto, ove in fondo a un vialetto trovarono una tavoletta coperta di candida tovagliuola e sopravi la merenda. Le fanciulle, che non sospettavano del tranello, parte in sull’erba, e parte sopra due trespolini sedettero, e attendeano che lo zio della Nina affettasse la pizza.
Poco lontano dalla tavoletta era un gran cespo di mortella, dietro al quale Edmondo s’era posto in agguato, ed aperto alquanto i ramuscelli sbirciava la Nunziatina che, secondo aveano ordinato insieme, la Nina dovea far sedere sul trespolino al dirimpetto. Le giovani, com’è usanza delle popolane di Roma, s’eran tolto di capo lo sciallo, e lasciatolo cadere sulle spalle, onde che il contorno del capo vedeasi netto, col profilo di tutto il sembiante. Edmondo com mendava in sè stesso Carluccio d’averla ritratta con ottima somiglianza, ma trovava, contro il solito ad avvenire, che l’originale superava di gran lunga la copia, alla quale non potè dar tutto lo splendore che movea da quel viso animato di giocondità e di modestia.
Dopo alquanto, e mentre Gasparetto porgeva alle giovani sopra una bella foglia di cavolo le fetterelle di prosciutto, la Nina con una gioia che mai la maggiore cominciò a gridare — Che buon prosciutto! gli è proprio dei monti d’Alatri e di Ferentino. Ma, e quel Signore ch’era con voi, zio mio, non ne vuol gustare un pochino? Ov’è egli?
— Sarà in giro per l’orto, rispose Gasparetto non curante, io non ho mancato d’invitarlo.
— Oh non sia mai, ripigliò la Nina; è così buono e alla mano! Venite Nunziatina, andiamo a cercarlo: e il rizzarsi, prendere la Nunziatina sotto il braccio e avviarsi fu tutto un punto. Ma la biscia tenne una via torta per dar tempo ad Edmondo di far la girata e venirle a rincontro. Allorchè lo vide spuntare da un viottolo, disse alla Nunziatina — Eccolo laggiù. Se sapeste quanto egli è ricco, benigno e generoso, non avreste la minima soggezione di lui. Tutto il suo gusto è di far del bene alla povera gente — Quando furono alquanto più presso, la Nina cominciò a gridare — Animo, signor Edmondo, venga a favorire queste buone ragazze: sentirà che prosciutto! che pizza !
Edmondo venne loro incontro con aria lieta, coprendo il tumulto del cuore, e dicendo — Grazie, buona mia. Io ci verrei pur volontieri, ma io non so se le vostre amiche avranno piacere.
— Piacer grande, signore, rispose la Nunziatina : noi non siamo degne di tanto onore; ma se voi non ischifate le poverette l’avremo a somma grazia. —
Edmondo ammirò il garbo e la discrezione di quella risposta; e voltosi a lei, le disse — Come vi domandate?
— Nunziata serva vostra; soggiunse; e perchè da piccola mi diceano per vezzo la Nunziatina, seguitano le amiche di dirmelo ancora.
— E vostro padre come si chiama?
— Mastro Simone ai vostri comandi, ed è carpentiere ed uomo dabbene: poveretto sì, ma buon cristiano; tenero della sua famiglia, che ci ha allevati tutti nel santo timor di Dio.
Edmondo procedea lentamente per intrattenersi più a lungo con lei, facendole di molte inchieste, alle quali Nunziatina rispondea sempre con una modesta franchezza: intantochè quando la richiese perchè indugiava di accasarsi, perchè, rispose, non ho ancora a ordine l’acconcio — Così ragionando furono al desco della pizza, e le fanciulle si rizzarono in piedi per riverenza a sua signoria. – Ma Edmondo, che sentiasi il cuore affollato come un mantice, guardossi intorno e smarrì, parendogli che tre di loro non fossergli facce nuove; onde posto a bocca un tantino di marzapane, non gli volea scendere per la canna, tanto eraglisi inaridito il palato e secca la lingua. Sporse la mano per bere, e la Nina voltasi a Nunziata disse — Deh lesta , Nunziatina, mesci al signor Edmondo — Com’ebbe finito di bere, venuto in un subito avviso, fe’ cenno a Gasparetto, e salutate le giovani, uscì dall’orto.
Ma egli non avea forse fatto trenta passi pel sentiero dell’uscita, che la Ceccherella scoppiò in una sghignazzata strepitosa. Tutte le compagne le dier su la voce, dicendo — Zitta; che hai tu, pazzerella? È egli questo il modo di farsi scorgere da quel buon signore che ci ha degnate di tanto? E la Ceccherella pur ridere, gridando — Oh Brigida, oh Sabina, non rassomiglia egli tutto al Ranocchiaro ch’ebbe le torsolate dai nostri monelli? — Alle due giovani scappò un risolino, e coprendosi co’ fazzoletti la faccia, dissero mugolando — Che Ranocchiaro? va va, scioccolona; mangia e taci.
BEPPONE
Nè voce, nè penna d’uomo potrebbe adequatamente dipingere, o anco adombrare, la confusione che provò Edmondo nell’avvedersi di quelle tre fanciulle, che avevano comperato da lui quella vil merce in sul trivio della Lungaretta. Come le riconobbe, e vide che la Ceccherella aveagli ficcato gli occhi in viso, un freddo gli corse così repentino per l’ossa, e il cuore gli si raggricciò dentro per sì fatta maniera, ch’egli si credette cascare lì lì spento dalla vergogna. La pelle gli s’era brividita addosso, le ginocchia infrollite, i capelli rizzati, e tutte le membra erano in un tremoretto sordo, intantochè non sentendosi più il capo, fe cenno per lo meglio al suo Gasparetto d’ uscire di là. Ma quando egli udì quella sghignazzata della Ceccherella smarrì affatto la vista e procedeva innanzi come pel buio; buon che uscito dell’orto, e veduto che Gasparetto volgeva dalla parte di ponte Sisto, gli disse: ho qualche negozio da ponte rotto; ci rivedremo stassera.
Allorchè fu solo, andava come uno intronato, e non sapeva raccogliere i suoi pensieri, pure affrettando il passo, quasi per fuggire que’ contorni che furono i testimoni delle sue confusioni. Nello scendere dalla piazzetta di s. Benedetto, come fu giunto al crocicchio della Lungaretta e dellaLungarina, tirò via difilato per riuscire al ponte a quattro capi, nè osò volgere gli occhi a sinistra parendogli udire la baia di quelle femmine, e lo smacco delle torsolate de’ monelli , e gli urli del popolaccio. Ogni cosa ch’era colà intorno gli ricordava la sua viltà, ognuno che passava per via credeva che Io guardasse, e guardando il riconoscesse pel ranocchiaro, e il gridasse giudeo; e così pensando, andava ratto come chi ha il nemico a’ panni.
Egli non avveniva in Edmondo tutto quel turbamento , se non per gli stimoli della mala coscienza e pel rossore che sentia l’anima nobile dell’essersi vituperata; poichè i passaggeri andavano pe’ fatti loro, e niuno gli ponea mente. Le tre giovani trasteverine aveano ravvisato in lui molta somiglianza col ranocchiaro; ma niuna di loro sospettava neanco per sogno ch’ ei fosse desso, e riputavanla una di quelle fortuite rassomiglianze che intervengono il più delle volte con uomini, eziandio nati in lontanissime terre l’uno dall’altro. Ma cosi è: per Edmondo tutti erano consci della sua viltà, tutti gli gettavano in viso la sua vergogna. Tuttavia l’uomo è una contraddizione misteriosa, che malagevolmente si può ricomporre siccome cagionata da due termini opposti.
Edmondo vituperava e detestava quel capriccio, che l’avea trascinato a quelle disorbitanze, e nel tempo medesimo commendava e amava la Nunziatina; ed ora che l’ebbe veduta, entrò in una nuova lotta col suo cuore
« Che sì e no net capo gli tenzona ».
l’un pensiero dicendogli, che quella giovane sì buona, sì vereconda, sì generosa e in un sì povera, meritava che le fosse affrettato il compimento de’ suoi desiderii coll’aiutarla di un po’ di doterella e d’un conveniente acconcio di nozze: l’altro pensiero diceagli, che tanta maestà e vaghezza non dovea esser profanata da sì bassa fortuna e da sì misero stato d’artigianella; e che s’ei la sposasse diverrebbe gran donna, e tutti gli porterebbero invidia di possedere sì ricca gemma. E qui entrava in mille labirinti circa i modi più opportuni di giugnere al suo intendimento, rinfocandosi in coteste immaginazioni sino agli inganni, e sino al delitto d’una rapina. Gli parea cosa da potergli riuscire, mettendo in opera tutte le astuzie della Nina, che sotto i più bei pretesti la si sarebbe condotta in casa, ed ivi, senza che l’aria potesse averne sentore, chiusala e abbavagliata in una carrozza, con lusinghe, con promesse, con lacrime l’avrebbe indotta a sposarlo. Che se la fosse proprio restia ad ogni lusinga, sperava a forza di moneta pervenir senza pericolo a trafugarla, e tragittarla oltre mare.
In su queste forsennate immaginazioni Edmondo era già pervenuto senza avvedersene verso l’arco di Giano, luogo solitario, basso, e senz’altro d’intorno che le ruine del monte Palatino da un lato e l’antica basilica di s. Giorgio in Velabro dall’altro. Egli continuando il suo cammino era già presso all’archetto che mette alla cloaca massima di re Tarquinio, dall’androncello della quale ode uscire un gemito fioco e lamentoso, quasi di persona che non ha più forza di gridare. Edmondo, che di nobil cuore fu sempre e compassionevole agli altrui mali, affretta il passo, e guardando entro l’androne vede tramazzata in terra una donna d’età ancor fresca, ma poveramente vestita, la quale vedutolo disse — Aiutatemi , signore — Edmondo si china, chiedendole che male avesse — Eh, signor mio, singhiozzando e ansando rispose: io sono una povera vedova ch’era venuta a cercare per le ripe un po’ di cicoria silvestra, e quando fui qui sopra mi vidi inseguita da tre soldati briachi, i quali volean darmi noia; ed io mi volsi a fuggire, ma giunta qui, uno di que’ birboni mi tirò per dispetto un gran sasso nelle reni e m’ha fatto cader bocconi: il dolore è sì forte che non mi lascia rizzare: aiutatemi per carità —
Allora Edmondo cominciò a farle animo, e dolcemente sollevatole la vita, si studiava di porla a sedere; ma mentre costei quasi per aiutarsi gli aveva afferrato la gamba con ambedue le mani, eccoti sopraggiungere due ominacci barbuti, i quali con voce imperiosa gli dissero — Dà qua la borsa — Edmondo non avea scampo: di dietro era il profondo della Cloaca Massima, dinanzi il passo era sbarrato da quei due ceffi truculenti, uno dei quali tenea sempre la mano sotto il giubbone quasi in atto di trarre il pugnale; da basso quella briffalda tenealo serrato alla gamba, di sorte che egli non potea nè difendersi nè fuggire. Egli avea in un borsello di pelle tra d’oro e d’argento un cinquanta scudi, e li consegnò al più vicino: quell’altro dal pugnale gridò — Dacci l’oriuolo — e il dirlo, e avventar l’altra mano alla catenuzza d’oro, e trarglielo del taschino, fu tutt’uno. La donna balzò in piede come un aspide, e coi due farabutti dileguossi in un attimo.
Edmondo ch’era uomo sperto de’ tranelli delle grandi città, tenne d’averla avuta ad assai buon mercato; perocchè in quella solitudine potea riceverne sopra la derrata, o qualche mazza in capo od anco una buona lama fra costa e costa. Quei ribaldi che aveanlo veduto dalla lunga venir solo, s’appiattarono dietro i piloni dell’arco di Giano, spedirono innanzi la strega per zimbello, ed ebbero bellamente acchiappato il tordo alla stiaccia. Il cavaliere usci di quel fondo, e tirato via per Campo vaccino, doleasi fieramente della perdita dell’oriuolo, non tanto perch’egli era un cilindro colle ruote impernate in molte gemme, ma perciò ch’era una dolce e cara ricordanza d’un suo fratello mortogli pochi anni addietro. Quel furto gli cagionava un dolore cocentissimo, e andava pensando il modo di poterlo ricuperare. E come un pensiero tira l’altro, gli tornò la mente sopra la prima altercazione, ch’ egli avea con sè stesso intorno alla Nanziatina.
Per sua buona ventura, e più perch’egli aveva l’animo veramente buono, gli cadde nel cuore un sentimento vivo dell’ angoscia in che avrebbe gittato l’amorosa famiglia di quella fanciulla, s’egli avesse dato ascolto alla rea suggestione di rapirla come che fosse. Diceva a sè medesimo: mi cuoce tanto la rapina del mio oriuolo, solamente perch’esso mi è la memoria del fratello defunto, e posso trovarne di somiglianti, pure son pronto a spendere ciò che si voglia per riaverlo: or che sarebbe pel padre, per la madre, pel fratello di quella giovane se la perdessero così crudelmente? Che angosce mortali per quei miseri cuori? E il suo fidanzato, il quale’ l’ama di sì ardente e di sì lungo amore, ed è già per coglierne il frutto, in quali disperazioni non sarebbe egli trascinato per un mio capriccio? E quella poveretta in quali agonie non piomberebbe? Io l’avrei divelta dai più cari e teneri oggetti della sua vita, e pretenderei ch’ella mi amasse? lo sarei agli occhi suoi un assassino; e cessata in me la fervenza dell’amore, avrei sempre dinanzi agli occhi la vittima de’ miei brutali furori, l’oggetto de’ miei rimorsi, la condanna del mio delitto.
Così ragionando fra sè medesimo fu alla casa di Alfredo, e trovatolo che appunto avea dato gli ordini ai cocchieri, parte d’ire alle case de’ suoi signori pel passeggio, parte d’esser pronti a condurne altri al teatro, salì con lui alle stanze. Alfredo veggendolo alquanto alterato in viso, gli disse — Oh, ch’è egli avvenuto a vostra Eccellenza, che la mi pare alquanto sbattuta? — Nulla, nulla, gli rispose: fammi recare un bicchierino del tuo ottimo rhum di Giattomaica — Il che avuto di presente, mentre lo centellava, gli narrò il seguitogli alla Cloaca Massima, soggiungendo — Assicurati, che’in quel brutto istante non ho avuto paura; ma fui a un gran rischio.
— Buono, riprese Alfredo, che non avete fatto nè braverie, nè minacce; perocchè sebbene cotesta canaglia non tende ad altro che a rubare se vien lor fatto, nulla però di meno , ove trovino resistenza possono dare in qualche eccesso. Avran fatto però con voi buona giornata.
— Fi, d’una cinquantina di scudi: avevo nel portadanaio nove gregorine d’oro, e qualche scudo con pochi paoli; ma ciò che mi travaglia indicibilmente si è il rapimento del mio orologio, che sai ch’era la cara e triste ricordanza dell’amato Gustavo, quando mi moriva fra le braccia all’Aia.
— Me ne duole all’anima ; e bisogna argomentarsi d’averlo per ogni guisa. La Polizia romana è, come nelle altre cose, così in questa de’ ladroncelli da borse, d’ un occhio di lince, e d’un’attività impareggiabile.
— Senti Alfredo, io sarei acconcio di dare una mancia di venticinque scudi; che, se lo vendono in ghetto o agli oriuolai, non ne caverebbero la metà.
— Uh, se voi siete sì largo e’ non fa mestieri di ricorrere alla Polizia: vostra Eccellenza avrallo in tasca doman da sera.
— E come ? Io non vi veggo il verso se non richiamandomene alla giustizia.
No no, signore; ma bisogna che voi abbiate il disagio di farlo da voi stesso, che solo potete darne i contrassegni. Domattina fate d’essere verso le ore undici qui presso in Campo vaccino, ove si fanno gli scavi delle anticaglie. Quella è l’ora del riposo e della seconda colezione; e tutti gli scavatori meriggiano sotto i muri degli orti Farnesiani, sotto l’arco di Tito, e per la salita del Palatino. Fra quella buona gente avvi una brigatella che sempre sta da sè, e niuno degli altri lavoratori s’impaccia con esso loro. Sapete perchè? Perchè son tristi, e stanno sotto la vigilanza del Fisco, il quale per averli sotto gli occhi, quant’è possibile, tielli a opera, ed è gioco forza che non manchino per non balzare in prigione. Ora sappiate che fra costoro è il capo , il mezzano, e il tesoriere di tutti i mariuoli, il quale si domanda in loro gergo Beppone: un omaccio che sembra un lionfante, e porta due basettoni color di cenere, che paion due scope da pattumaio: costui nol potete scambiare, tant’è appariscente, e suole sempre sedere su certe travi che stanno laggiù verso gli antichi Rostri. Se voi vi presentate a sua signoria, gli narrate la cosa, e gli esibite venticinque scudi, l’oriuolo è vostro —
Edmondo, che moriva di voglia di riavere la sua ripetizion d’oro, il domani un po’ prima delle undici ore già passeggiava lungo il Campo vaccino, e stava mirando quei scavatori ch’erano la pigrizia e lo sbadiglio in persona. Allo scocco dell’undici alla torre di Campidoglio ognuno pianta la carriuola a mezzo la via, si lascia andar di mano dentro il fosso il piccone, la vanga e la pala, e corre all’ombra, sudando più di quella corsa, che di tutta l’opera della mattina. Edmondo lasciò che ciascuno pigliasse luogo e s’ assettasse, indi volti gli occhi verso le travi, vide seder soletto messer lo duca, il quale scartocciato non so che e trattasi di tasca una fetta di pane s’acconciava d’asciolvere.
Al gentiluomo parve d’essere in un brutto impaccio con sua eccellenza: come affrontarlo? come introdursi a colloquio? Dirgli; siete voi il capo de’ ladri e de’ mariuoli? no davvero. Cominciar bel bello a chiedergli che sono quelle tre maestose colonne con quel mozzo d’architrave? Risponderebbe al solito: sono gli avanzi del tempio di Giove Tonante. E poi , che dirgli ? In su questo ragionare fra sé Edmondo era già bene avviato innanzi verso l’uomo: perché giuntogli a cospetto, e scappellatosi, e fatto un viso grazioso, gli disse — Di grazia siete voi mastro Giuseppe? — Per ubbidirvi, rispose Beppone, che volete? — Ecco , disse il forastiere, trovandomi ieri per caso verso l’arco di Giano, due uomini mi tolsero l’oriuolo, il quale m’è carissimo per essere la memoria d’un mio fratello defunto. Se lo vendono, non ne trarranno che pochi scudi; io invece ne darei venticinque per riaverlo, tanto m’è caro.
— Venticinque scudi di mancia? E voltosi a un gruppo che sedeva poco discosto, gridò — Eh, Nannetto, chi era di ronda ieri da san Giorgio, da Cerchi e da santa Prisca?
— V’era lo Schiaccia col Barbone, rispose Nannetto.
— No, che tu sii ammazzato! Lo Schiaccia era di guardia a sant’ Andrea della Valle, e il Barbone era di guardia a sant’ Apostoli.
— Ah si; ora mi sovviene: rondinavano da quelle parti il Salciccione col Piveita, e colla Gelsomina.
— Ho inteso, signore; tornate domattina a quest’ora, e spero che riavrete l’oriuolo: dati i contrassegni, già s’intende. Venticinque scudi, n’è vero?
— Venticinque — E dette queste cose, Edmondo s’accomiatò lasciando Beppone, il quale stavasi seduto con un sussiego che parea l’Arcalilo di Babilonia. Il dì vegnente gli fu dinanzi all’ora medesima, e Beppone sedendo pro tribunali, chiesegli i contrassegni — Catenella d’oro, disse il forestiere, lunga un palmo e mezzo colla gruccetta da fermarla nell’ucchiello, e la gruccetta era foggiata a pistola e serviva da chiavicina per caricar l’oriuolo. Dall’ultimo anello pendeva un suggelletto di corniola colle cifre E. R. e sopravi la corona comitale.
— È desso, rispose Beppone: eccovi l’oriuol vostro — E il cavaliere diegli cinque gregorine, e poscia uno scudino d’oro per beveraggio.
A Edmondo non parve vero d’averlo ricuperato, e ito a trovare Alfredo narrógli il seguito, facendo le meraviglie che in Roma si rubasse a man salva.
— Adagio, ripigliò Alfredo. A Roma si ruba come altrove, e forse meno che in altre città grandi d’Europa, ov’è sempre di molti sfaccendati e di molti viziosi, i quali amano viver di truffa, d’involo e d’inganni a spese altrui. Ma non dite, che qui si rubi a man salva. Nelle grandi comunanze avvi de’ mali inevitabili, come la noia delle mosche e le punture delle pulci; si possono più o meno diradare, ma togliere del tutto non mai. Costoro, vedete, sono tutti avanzi di galera; e ve n’ha che I’hanno già gustata le due e le tre volte: dopo li tre e li cinqu’anni tornano a casa ; niuno li vuol ricevere a opera, perché hanno la nota di ladri, e come campano que’ poveracci ? Il Buon Governo assegna loro di che lavorare agli scavi, e ne ritraggono di che sostentarsi sottilmente; ma costoro sogliono esser pieni di vizi, gozzoviglioni, femminieri, poltri, bordaglia incontentabile; laonde per cavarsi le loro vogliacce tornano di leggeri al mal vezzo di rubare. È raro però che offendano, sia di mazza sia di coltello; come al tresì è raro che assaliscano nel modo che fecero con voi: per lo più uccellano a trappolare i male accorti, gli sbadati, i buonaccioni: e cui tocca, tocca. Appunto per ciò in Roma, ov’ha tanti luoghi solitari e deserti, battono continuo in ronda drappelli di cavalleria, massime le feste, per l’Aventino, pel Celio, pel Circo Massimo, per le terme di Tito e di Caracalla, pei viottoloni dell’Esquilino, e della basilica Sessoriana; per porta Tiburtina e per porta Salara; e ove trovino crocchi di giocatori o di sviati, li sbarrattano e li riducono alle parti più centrali di Roma. La notte poi vannovi in pattuglia i doganieri pei contrabbandi: ad ogni modo egli è sempre poco prudente il passeggiare soletti per quelle anticaglie così fuor di mano.
Che dirvi de’ borsaiuoli e de’ mariuoletti che bazzicano per le calche e per le chiese di molta frequenza? Roma è soggetta a cotesta peste anch’essa come le altre città: con questa differenza però, che in Roma , ove cotesti sviatelli sien còlti, col castigo si cerca di migliorarli. Per lo passato erano chiusi in san Michele in certe cellette, ov’erano visitati da più sacerdoti e ammaestrati nella dottrina e nei doveri del cristiano: sotto Papa Leone XII erano chiusi alle terme di Diocleziano in mano anch’essi d’ecclesiastici che col far loro apprendere le arti e i mestieri, brigavansi di condurli a salute. Ora poi la paterna sollecitudine del Sommo Pontefice Pio IX gli ha consegnati in mano dei Fratelli della Misericordia, chiamati a bella posta dal Belgio, e diè loro la residenza di santa Balbina alle terme di Caracalla. Voi non direste quel santo luogo carceri di ladroncelli, ma collegio d’arti; con tal ordine, pulitezza e spirito di pietà è composto, nutrito e ordinato da quegli uomini di Dio, che si dedicarono in sacrificio di carità per condurre a bene quegli infelici.
— Ma prima che vengano a tanta depravazione, disse Edmondo, egli si converrebbe usare di molte industrie per migliorarli o almeno atterrirli. Credilo a me, Alfredo, un po’ di scudisciate (o di nerbate, se son grandi) sarebbe una gran panacea a questi morbi attaccaticci della plebe.
— Il brodo di nerbo si fa bere a cotesti ammalati nelle nostre contrade, che ammiransi per le più libere e civili del mondo ; ma a Roma guai se un famiglio di Giustizia desse un buffetto a un mariuol còlto nel tagliare la borsa o nell’involare un fazzoletto di tasca! Se ne farebbe un romore da certi giornali inglesi e italiani da intronare il cielo e la terra, gridando — Che ecco i preti rimettono la tortura; ci ribalzano nelle ferità atroci del medio evo, discarnano, disbranano, disossano i poveri fanciulli sul cavalletto.
— Diascol, credici ! Tu mi dai nelle iperboli.
— lo dico la verità schietta ; e se voi foste stato a Roma del 48 avreste veduto come si bestemmiava il cavalletto nei giornali dei redentori d’Italia. Eppure la vista di quel nerbetto che fischiava qualche volta in piazza Navona e in Campo di Fiore, faceva far senno a certi monelli, cui pruiiva le dita di rubacchiare, ma per riverenza a madonna Margherita, se n’asteneano, e in Roma non formicolavano i ladroncelli come oggidì. E poi dite voi nulla quel po’ di gogna ai truffatori, ai bari, ai ladri, ai falsari usciti di pupillo? Quel cartello che pendea loro dal collo facea pur buono! Ora date loro un mesetto di carcere, e n’escono più matricolati che mai, ed hanno apparato a rubare più cautamente ; laddove quel po’ d’asperges che davano i nostri vecchi gli era un nettare miracoloso.
Dopo questo po’ di cicalata Edmondo, lieto della sua ricuperazione, lasciò Alfredo; e volendo visitare un amico in un quartiere di casa Braschi , tenne pel palazzo Farnese verso piazza Navona. Fatte le prime accoglienze, udì sotto le finestre, che rispondeano sulla piazza, un gran romore; perchè fattosi coll’amico ai cristalli, vide un grande accorrer di popoli da ogni parte, e raunarsi e affollarsi verso il fontanone dell’Obelisco — Che sarà egli mai? disse all’amico; forse qualche baruffa e capiglia di facchini? Non vorrei che ci fosse sangue e morte.
— No no, rispose sorridendo il Romano, datti pace, Edmondo, che ora noi Romani non siamo più accoltellatori, come ci spacciate, per grazia vostra, voi altri forestieri. Il Romano è divenuto buono, me’ che ‘l pane. Tutta la gente, che tu vedi accorrere, viene per ispassarsi, perocchè laggiù fassi una festa, che si chiama Il Possesso di Piazza Navona.
Tu dèi sapere che tutti coloro, i quali bazzicano pel mercato di Piazza Navona, pèrdono il nome lor proprio, e ne assumono un altro dato loro dalla congregazione de’ sensali e de’ capocci di piazza; ma per venire a cotesta rigenerazione, e ricevere la cittadinanza della più bella e ricca piazza del mondo, ci vogliono gran fatti e imprese degne di Roma: e qui calza bene quell’epifonema virgiliano
Tanta molis erat romanam condere gentem.
Niuno può aspirare all’alto grado di Bagarino di piazza Navona, se prima non si è segnalato nell’arte dell’agguindolare il villano, che viene a città colle poche derrate del suo podere o dell’orto suo; laonde quando alcuno propone d’essere accolto in piazza per Bagarino, è già laureato in utroque e può aprir scuola d’arzigogoli e di finezze. In Roma per significare che uno è astuto, si dice — Egli è dottore di piazza Navona. E quando una femmina è parlantina, cicala, e vuole esser l’ultima sempre a cinguettare, le si dice — Va, che teco la perderebbe una treccia di piazza Navona.
E non credere che si muti il nome soltanto agli uomini, perocchè fassi eziandio alle donne, avvegnachè senza solennità. Impertanto quella rivendugliola che prima dicessi la Dorotea, ora chiamasi la Rossa, e quell’altra ch’era la Giuditta or dicesi la Bruna; e cosi la Bianca, la Ciliegia, la Sermolina ecc., nè v’ è pericolo che ripiglino il nome loro; perchè ciascuno conosce la Sermolina che vende i limoni a man diritta, e la Ciliegia che vende le fave, i piselli, i carcioffetti e i pomi d’oro lungo la corsia, la Mora che vende le castagne dal lato di sant’Agnese, e la Fringuella che vende l’indivia di verso il teatro.
Gli uomini poi hanno l’innesto di nomi che s’assettano meravigliosamente al personale: a quel maghero, secco ed intirizzito appiccano il nome di Baccalà; a quel bastracone che va dondoloni e cascante, dicono l’Orso; quello scarmigliato con una casaccaccia bruna e bisunta indosso, chiamasi il Mago: colui dai denti in fuori il Cinghiale; quello che ha un capone tanto fatto, il Cocomero; e così v’ha di strani e nuovi soprannomi, che son dati a ciascuno come accademico di piazza Navona.
Mentre il Romano intratteneasi con Edmondo, e squadernavagli innanzi una sì nobile erudizione, la gente correva in folla e cresceva come i flutti del mare incalzati dal vento. Quand’ecco si vedono di mezzo alle turbe due facchini giganti alzare in predellucce un ometto sparuto e aggrinzato, col capo calvo come una zucca, e in farsetto di velluto e sollevatolo in alto, e portatolo attorno, tutti battean le mani, o agitavano i fazzoletti magnificando il candidato. Quando gli ebbero fatto fare il cerchio della fontana, i due giganti saltano sulla sponda di quella, e preso l’eroe l’uno alle spalle e l’altro ai piedi, gli dieron tre tuffi nel pilo, creandolo Cavaliere bagnato. Le grida , gli urli , il batter nei piatti delle bilancie, il sonar delle padelle dei ferravecchi, ferian le stelle.
Quando l’ebbero tuffato in molle, come un paniere d’insalata, uno di quei facchini levosselo in collo cavalcione, e presolo per le mani, e datogli due scosse per assettarselo bene in groppa, portavaselo in trionfo tra i fischi del popolaccio verso la scalinata di sant’Agnese, e giunto sul pianerottolo, ivi era atteso dal senato di piazza Navona, che subito gli fe’ cerchio intorno: allora uno de’ maggiorenti, ch’era l’oratore del sinedrio, complimentollo da parte di tutta la signoria di piazza, dicendo — Il nobilissimo ordine dei sensali, dei bagarini, dei portatori, dei fruttaiuoli, degli erbaiuoli, de’ cecivendoli, de’ pentolai, de’ farinaioli , de’ ferravecchi , e di tutti i rivenduglioli di civaie, oggi per magnanimità sua ti saluta suo concittadino, e t’innesta e stabilisce il prelibatissimo nome di Rapa: Dunque, voi tutti matricolati di Piazza non lo chiamerete più d’ora innanzi mastro Gregorio, ma sì il Rapa; nelle vendite il Rapa, nei cambi il Rapa, nelle compere il Rapa – Viva Rapa! gridaron tutti con un baccano che rintonava sino al vicolo del Fico.
Allora vennesi all’investitura del Bagarinato; e ad uno ad uno i capi sensali gli presentarono un mazzo di rape degli orti di san Cosimato, un cavolo cappuccio, un capo di cavol fiore, un cesto d’indivia, di lattuga, di scheruola, di bietola e di boragine; una coppella di noci, di marroni, di fave, di ceci e di lupini; un bel vassoio di pere, di mele, di prugne, di melangole, d’aranci, e di quante altre frutte la ricca Pomona romana sa ornare la piazza agonale; altri in fine gittarongli in faccia a gran manciate una grandine di frumento, di frumentone, di loglio, di lenticchie, di miglio, che gli riempirono la goletta della camicia, il seno e le tasche.
Fatto questo, due araldi con voce stentorea gridarono — Ora il Rapa piglia il possesso di piazza Navona: fate largo— e il dir questo, e alzare il Rapa di peso, e sederlo sull’orlo del primo scaglione, e pigliarlo pei piedi, e tirarlo, e farglì dare la culattata di scaglione in scaglione sino al l’ultimo, fu tutto un fiato. La piazza a quella vista uscì in un tripudio romorosissimo , che non si sarebbero uditi i tuoni. Il Rapa rizzatosi, e presi per mano i caporioni di piazza, ringraziolli ridendo: e poscia guardò pel lungo e pel largo la piazza Navona, come il novello suo regno, e invitolli a bere all’oste del Pellegrino.
Edmondo non potè contenere le risa molte volte a vedere la giovialità della plebe romana, che si diletta di coteste sue usanze, le quali , chi ben cercasse , troverebbe avere la radice ne’ tempi della Roma antica. E di questo ragionando coll’amico suo, quegli disse aperto: ch’egli riputava molte consuetudini proceder dirittamente dalle costumanze latine, altrettanto come le ottobrate, il carnovale, il comparatico di s. Giovanni , le fave dei morti, certi rimasugli di superstizioni, e le gallorie che si celebrano in Roma pel maritaggio dei vedovi e dei vecchi.
— Oh che c’è egli di singolare intorno a questo argomento, disse Edmondo? penso che avranno delle consuetudini bizzarre.
— E bizzarre tanto, rispose, che tu non vorresti la notte delle nozze trovarti a dormire nella contrada ove dimoran gli sposi. Nè credere che i vecchi possano fare il maritaggio di secreto; perocchè se anco ottenessero dal parroco di ricevere la benedizione nuziale a gran notte e a chiesa serrata; egli v’è sempre chi ne dà qualche sentore al vicinato, e la cosa è spacciata. Tutti i capi ameni delle botteghe e delle case ivi intorno si danno la parola, e fatto groppo in qualche crocicchio, ivi recano loro arnesi, e muovono a stormo verso la casa de’ congiugati, con un fracasso che par vadano all’assalto di Sebastopoli. Chi suona campanacci; chi picchia padelle, calderuoli e timballi; chi trascina catene; chi dà fiato alle bucine di mare, chi agli sveglioni e chi ai corni da caccia; altri batte ne’ tamburelli e nei cembali; altri rotolano per la selciata vecchi barili e bottaccini sfondati de’ salumai: chi grida, chi fischia colle dita in bocca, e giunti sotto la finestra degli sposi fanno un chiasso e un nabisso infernale. Pensa come quei poveri vecchi si rannicchiano e si turan gli orecchi! Non v’è né pace nè tregua: tutte le genti accorrono, tutta la vicinanza si fa alle finestre, e calano le lucerne dai davanzali, gridando — Viva gli sposi! Buon pro agli sposi! Quando poi quei chiassoni n’ebbero una buona satolla, il Presidente del Rione manda loro due uomini d’arme, i quali entrano nella folla, e dicono sorridendo — Oh basta, giovanotti: andate a casa , e buona notte — Il Romano in questo’ è docilissimo, e ciascuno
« Di ritroso fanciul seguendo il metro »
partonsi di male gambe, volgendosi spesso a guardare l’inespugnabile fortezza, e colla buona intenzione di ritornarvi domandassera.
— Questa tregenda, riprese Edmondo, fassi quasi per tutte le contrade d’Europa, cotalchè scorgesi chiaro, che cotesta usanza proviene da un sentimento universale delle prime genti del mondo.
Ma ora, disse il Romano, che i popoli ricevono il forbimento d’una civiltà artifiziata non s’abbandonano più a certi naturali passatempi, i quali richiedono stagioni più riposate e tranquille, che non le nostre. E Roma stessa, non puoi credere, come a mano a mano va perdendo le sue consuetudini popolari; di modo che fra qualche lustro i vecchi cittadini non conosceranno più la Roma d’un mezzo secolo addietro.
LA DOTE
Ogni stromento è buono a chi lo sa adoperare; e l’uomo che sta sull’avviso del cuore suo coglie argomento di bene quando meno l’attende. A Edmondo la perdita del suo oriuolo, il cociore vivissimo che sentì nel perderlo, e la gioia che provò nel ricuperarlo, gli valse un buon pensiero; e l’averlo accolto, e poscia eseguito, gli fruttò tanta consolazione quanta non ne avea provato in vita sua. La Nunziatina eragli sempre dinanzi agli occhi; e gli parea che quella giovane nella tenuità sua fosse appieno felice, ove potesse affrettare il suo matrimonio con Cencio: essa da sè, per quanto s’affaticasse a lavorare di forza, non sarebbe venuta a capo di giungere a termine de’ suoi desìderii se non forse appena in un paio d’anni; quando in quella vece egli ricco e prodigo del suo in mille modi anco sciocchi, anco vili, anco bestiali, potrebbe in un tratto cagionarle il più gran contento che possa mai godere una giovane buona, povera e innamorata.
Questi pensieri gli s’avvolgevano in mente quella notte prima di pigliar sonno e la mattina appresso dopo svegliato: ma come effettuare le sue generose intenzioni senza porre a pericolo di qualche diceria l’onoratezza della giovane, o suscitare qualche favilla di gelosia e di sdegno in Cencio suo fidanzato? Allora sovvennegli in buon punto di don Alessandro, uomo grave, savio ed esperto, dicendo fra sè: per cavarmi un matto capriccio ho messo in uzzolo quel mascalzone di Gasparetto e quella cialtroncella di Nina, gli è ben giusto che volendo fare un’opera nobile e dilicata mi rivolga ai prudenti. Così detto, si vestì, e uscito di casa, volse verso s. Pietro per attendere che don Alessandro, terminato il coro, venisse alla sacristia.
Mentre passato Ponte sant’Angiolo s’avvia per Borgo alla volta del Vaticano, ecco vede isboccare dal vicoletto della Traspontina una gran brigata di popoli, i quali uscendo da tutte le botteghe rideano e i fanciulli ficcandosi fra gamba e gamba , e urtando di spalle e di gomiti , traforavansi per giunger primi a dare la baia, e a picchiar le tabelle per accrescere il baccano. Edmondo rallenta l’ andare, e vedendo ridere la gente credette che i monelli, come suol avvenire, avessero còlto qualche topo, e traesserlo per la via legato alla coda. Ma vede in quella vece uscire del vicolo in sulla via di Borgo un giovanottone col viso alquanto nericcio, e una barbetta arruffata, il quale era a bracciere d’un altro , che conducealo ad onore con una gravità maiuscola e riverente. Dietro a costui era uno sciancato con un mento a scodella e un po’ di gobba per giunta, il quale a guisa di baldacchino reale tenea sopra il capo di sua eccellenza un fusto d’ombrello, cui cadeano per li giunchi due brandelli d’un telo, che rimaneasi solo ancora più lacero d’una bandiera campale. Precedeva la brigatella un fattorino con un campanaccio da pecoraio, e dietro una torba di ragazzettacci che fischiavano e romoreggiavano di voci e di mani.
Edmondo non sapea se la fosse una mascherata o una delle solite baldorie della plebe romana; perchè veduto sullo sportello d’una bottega un uomo alto e atticciato e di bell’aria, il richiese del fatto. Questi era il poeta di Borgo, il quale fattosi alquanto innanzi, gli disse — Signor mio, voi dovete sapere che il popolo romano, come la sera ha beuto un sorsellino di più, la mattina non troverebbe mai la via d’alzarsi di letto, poichè lo scirocco fa buon dormire, e in val di Tevere lo scirocco è un vento che purtroppo spira di spesso. Or quivi è una usanza, che specialmente i calzolari, i falegnami ed i fabbri, s’egli v’è qualche lavoro che importi , sono invitati dai mastri di bottega a venire la mattina di buon’ora per terminarlo presto, e non disgustarne i commettenti. Tutti son puntuali; ma se tal fiata avvenisse, che qualcuno si dimenticasse in letto, gli altri garzoni vanno in frotta a svegliarlo, l’aiutano a vestire, e poscia il menano a bottega colla solennità che voi vedete. Nè crediate che il vi conducano per le scorciatoie: no, anzi lo traggono a zonzo per le più popolose contrade, acciocchè i fattorini e i lavoranti piglino la lezione, e im parino che
« La gola, il sonno e le oziose piume »
non son cose da Romani; poichè facere et pati fortia romanum est, e lo dice Tito Livio, sapete? La castigatoia poi non termina col farlo girar per le vie a ricever la baia; ma prima di ridursi a bottega, il poltroncello dee pagar l’acquavite o il caffè a tutti quei commilitoni che andarono a destarlo.
— Tuttavia egli non pare , disse Edmondo , che quel giovinotto si rechi ad onta la baiata, che gli danno i popoli per la via , anzi ride con essi , e pavoneggiasi di quella berta.
— Il Romano, rispose il poeta, è superiore alle opinioni volgari, e procede sicuro e sereno anche allora che altri lo corregge de’ suoi difetti; cotalchè quando io lo veggo ridere in questi casi, non posso contenermi ch’io non gli canti col nostro Metastasio
Tu m’insegni con quanta costanza
Si contrasti alla sorte inumana;
E che sono ad un’alma romana
Nomi ignoti timore e viltà.
Il Romano, signor mio, è come l’acqua la quale plus pressa plus surgit
Nobil onda Tal quest’atma
Chiara figlia d’alto monte Più ch’è oppressa dalla sorte
Più ch’è stretta e prigioniera Spiegherà più in alto il volo,
Più gioconda E la palma
Scherza in fonte, D’esser forte
Più leggera Dal suo duolo
All’aura va. Acquisterà.
Addio, signore: e così detto il poeta ritirossi dietro lo sportello, e piantò Edmondo ivi ritto come un piuolo. Già il campanaccio era avviato per Borgo vecchio, e la gente era ita pe’ fatti suoi, laonde veduta la via sgombera Edmondo continuò suo cammino; e pervenne alla sacristia di s. Pietro in aspetto di don Alessandro, il quale finito il coro entrò a spogliare la cappa e il battolo del zibetto — Oh, disse, che buon vento, il mio caro Edmondo?
— Son venuto, rispose, per godere alquanto della vostra dolce compagnia, e in uno per ragionare alquanto con voi e averne un consiglio amichevole e savio — Cosi dicendo, uscirono, e giunti verso l’obelisco cominciò a entrare nell’argomento, dicendo — Don Alessandro, voi siete uomo di tempo, e molto sperto e assegnato in tutte le cose vostre, e però pieno di quella discrezione che onora la vostra età e il vostro grado. Io v’affido il pensiero d’un’opera buona, ch’io giovane, mondano, forestiere e protestante non potrei fare da me per molti rispetti. Voi eravate con noi tempo fa quando nello studio di Carluccio parlammo delle ottobrate del popolo di Roma, e se ben vi ricorda Carluccio parlò d’una giovane Trasteverina, ch’egli avea trovato in un orto, la quale per liberare del carcere suo fratello, che in un subito sdegno avea ferito il fidanzato di lei, essa fu tanto amorosa, che privossi di quel sollazzo, e spese il danaro per ricomporre la pace.
— Lo ricordo benissimo, riprese don Alessandro, e la buona fanciulla fece un altro atto nobilissimo di virtù cattolica, recandosi scalza alla Madonna di sant’ Agostino, e ringraziandola, e votandosi a lei di certe astinenze; il che mostra quanta pietà si accolga in quel cuore.
— Tuttochè protestante, parve anche a me cosa tenerissima di religione e mi crebbe in doppio l’ammirazione verso quella colomba; chè tale io la chiamo per l’animo ardente, semplice e mansueto. Queste cose appunto, caro don Alessandro, mi mossero al più vivo desiderio d’affrettare la sua felicità. Mi fu significato il nome di lei ch’è detta la Nunziatina; e di più mi si aggiunse, ch’ella è poveretta e vive delle mani sue, e non può effettuare il matrimonio con un giovane suo pari, perchè la non può venire a capo di fornirsi il corredo necessario. Voi che conoscete le costumanze romane, che ci vuol egli?
— L’usanza di Roma porta, che lo sposo rechi le dona alla fidanzata, facendole la roba da nozze più orrevole che può, la quale per ordinario è di seta: è altresì dello sposo il comperarle i vezzi da collo, da petto e da mano, onde le collane d’oro, le borchie e le anella , ond’è sì guernita la sposa sono suo dono. La sposa poi dee recare il letto maritale, la lettiera cioè con due materassi, se la può; le lenzuola, i guanciali, i panni lani, il coltrone e la copertina. Ella dee essere ben fornita di biancheria da dosso, e tocca a lei in qualche caso la masserizia della cucina come padelle, paiuoli e la brocca di rame. Tutte cosette da poco; ma che alla povera gente costano sudori, e talvolta vi trafelano senza poterne venire a fine; mercecchè una malattia di pochi giorni gli asciuga spesso di quella poca moneta che avevano raggruzzolato a stento, e il matrimonio si prolunga alle calende greche, con quella agonia delle misere fanciulle che potete immaginare. Ed io penso di frequente — Vedi! quel signore getta in un pranzo (che niuno gliene avrà né grado né grazia) tanto valsente da render beate tre o quattro famiglie , che gemono senza speranza di vedere compiuti i giusti ed innocenti lor desiderii.
— Egli è appunto perciò ch’io vorrei trovar modo di cavare la Nunziatina d’angoscia e ricorro al vostro consiglio. Per me un migliaio di scudi non è gran cosa, e invece di gittarli e scialacquarli in corbellerie da nulla, vorrei assegnarli a fare cotesta opera buona.
— Io ve ne commendo e ve ne conforto, il mio caro Edmondo, e il modo è facile dal mio lato, ma vorrei che fosse altrettanto dal vostro.
— Vi dissi, che un migliaio di scudi non mi disagia; purchè la giovane nè debba arrossirne, nè averne gelosie dalla parte dello sposo; il che avverrebbe ov’io stesso mi offerissi a sovvenirla direttamente.
— Da poi che voi stesso vedete ch’ egli è a procedere in questo fatto con isquisita delicatezza, si conviene che voi siate uomo, e che adoperiamo in guisa, che nè la giovane, nè lo sposo venissero mai nella sospezione, che voi foste il loro benefattore. Nelle città cattoliche, e in Roma più che nelle altre, cotesti improvvisi e secreti soccorsi sono più frequenti che altri possa immaginare; e vi sia noto, che per le mani de’ sacerdoti passano ne’ poveri di gran somme, senza che la mano sinistra sappia ciò che ha fatto la destra, avendo per testimonio solo Iddio, che n’entra pa gatore. Noi primieramente facciamo restituzioni, anco di grosse somme, dateci dai penitenti, che concessi e pentiti delle antiche truffe e ruberie, usano dell’occultissimo mezzo de’ Confessori per ispegnere le ingiuste partite, e ragguagliarle col libro secreto della coscienza. Noi oltre a questo siamo il canale della divina Provvidenza pel sollevamento delle umane miserie, nè voi potreste tenere le lagrime a vedere le commozioni di quella vedova, che s’è venduto ogni cosa per dare il pane a’ figliuoli; e mentre si guarda attorno e non vede più quadri alle pareti, più materassi sul letto , più biancheria nei cassettoni, più rami in cucina, scorge entrare in quelle vuote camere un Sacerdote, che le mette in mano un rotoletto d’oro senz’altro dirle, che un pregate pel vostro benefattore. Quella pia verginella, che brama da tanto tempo di consecrarsi a Dio in un monistero, ed essere ammessa all’altissimo onore delle Spose di Cristo, mentre geme come la tortora cercando il diletto dell’anima sua, vede entrare un Sacerdote che le dice — Figlia, asciuga il lungo pianto; lo Sposo delle vergini t’apre il giardino dei gigli, ed ecco la dote ch’egli ti manda.
Edmondo, sapete voi per queste mani quante volte le anime pie fecero passare i loro soccorsi, quante lacrime astersero, quanti voti appagarono, quante inopie sollevarono, quante speranze fecero rifiorire? La carità cattolica è inesauribile, perchè attinge alla fonte della carità eterna di Cristo.
— In ciò, caro don Alessandro, noi protestanti, se vogliamo esser giusti e sinceri, non possiamo dissimulare quanto i cattolici ne vincono alla prova. Ma voi altri preti, che tanto magnificate il celibato cattolico, non vi interporrete per asciugare anco le lagrime delle innamorate fanciulle, le quali bramano d’ire a marito, e per la povertà non possono pervenire all’adempimento de’ lor desiderii.
— Chi ve l’ha detto? Tutt’ altro, amico. Anzi sono più frequenti coteste sovvenzioni, che quelle per monache, sì perchè il caso de’ matrimoni è più frequente, e sì perchè la verginella che aspira al chiostro, se attende anco un paio d’anni non importa; non così della fanciulla povera e innamorata, la quale non di rado si trova in non lieve pericolo dell’innocenza: in ciò i buoni parrochi sono solleciti più che mai.
— Qui non siamo nel caso, tuttavia vorrei far lieta cotesta buona creatura.
— Ell’è buona davvero, e tanto quanto forse non è mai giunto a cognizion vostra: imperocchè oltre all’esser pia, vereconda, contegnosa e savia, ell’ha un cuore pari al vostro, che sente la compassione dei mali altrui più che i suoi proprii; e si studia e travaglia di mitigarli e addolcirli quant’ ella può; privando sè medesima di qualche innocente sollievo per ispendere i pochi suoi denaruzzi per fare una robicciuola a qualche fanciullelta pezzente che non ha più madre, o per nutrirla affamata, o per ristorarla inferma, e tutto ciò fa con una grazia e disinvoltura maravigliosa.
Edmondo ascoltava senza fiatare, e don Alessandro s’avvide che trasse il fazzoletto di tasca, e si asciugò gli occhi: onde continuandosi senza far mostra di nulla, soggiunse — La povera Nunziatina, pochi giorni dopo la pace fatta fra il suo fratello e il suo fidanzato, fu còlta improvviso da una infiammazione di gola così violenta che la condusse agli estremi; ed essendo portata allo spedale, ivi colla dolcezza de’ suoi modi, colla sua pazienza, mansuetudine e pietà edificò grandemente le inferme, e si fece amare dalle Suore ch’hanno in cura quello spedale.
Un padre Crocifero, dì quelli che assistono le inferme a bene morire, uomo di molte lettere, mi narrò di cotesta cara figliuola cose tenerissime della sua carità, quand’ella era convalescente; e come assistette con un amore e con una delicatezza inestimabile una protestante convertita, ch’era cieca, e la imboccava, e la teneva pulita come una rosa. Ma ciò ch’è più mirabile si fu l’industria, la pazienza, la costanza con cui indusse una peccatrice a morire con sentimenti di fede e di pietà singolare.
— Deh, disse Edmondo, perchè non è nata costei più altamente, ch’io veggo ch’ ella avrebbe fatto cosé maggiori?
— Ciò non vi turbi. Ciascuno è grato a Dio quand’egli opera secondo le forze sue; e più vale agli occhi suoi l’obolo del povero che molti doni del ricco; e la parola dell’anima semplice ha talora più virtù che i lunghi ragionamenti dei dotti: sicchè badatevi, Edmondo, che se voi parlaste con lei la vi potrebbe anche far cattolico senza che voi quasi ve ne avvedeste.
— S’egli è poi per cotesto, le virtù di lei, narratemi da voi eziandio cosi di volo, hanno avuto sul mio cuore un tale incanto, ch’io non vi potrei dire a parole: per guisa che ove mi domandaste se in questo momento io son protestante, vi risponderei di riciso — No; son cattolico — tanto è l’impero ch’esercita la magnanimità di costei sovra tutte le potenze dell’anima mia.
— Caro Edmondo, questo sentimento, il quale in sostanza non è se non il naturale attraimento della virtù, può essere eziandio in voi un raggio della grazia celeste, che balena nella vostra mente, e che voi dovete accogliere con grato animo, e procurare che non si spenga. Dio v’ha dato un cuor buono, fate ch’egli sia docile alla sua voce —
Edmondo, a queste gravi parole di don Alessandro , levossi con un movimento repentino il cappello, cacciossi le dita nel ciuffo, gli diede una gran sprimacciata, l’attortigliò rapidissimo, come l’uomo che vuol chiamare un pensiero per fuggirne un altro, e voltosi di tratto — Ebbene, disse, quale avviso sarebbe dunque il vostro circa il modo di consolare quest’ammirabile creatura? E sì dicendo rimise il cappello, e giù per le tempie filavagli un sudore sì copioso, che pareva che il capo fosse nello strettoio. Don Alessandro s’avvide della tempesta che tumultuava in quel petto, e facendo le viste di pensare al quesito — Io, disse, condurrei la cosa con molta delicatezza. Conosco il padre, ch’è un buon popolano, e gli direi: Mastro Simone, la saviezza e modestia della figliuola vostra è conta per la Lungaretta, e ciascuno ne dice bene, di che io mi congratulo con voi e con vostra moglie, che l’avete allevata nel santo timor di Dio: ma nella lunga malattia e convalescenza, che la tenne allo spedale delle donne di san Giovanni, fece palese la sua virtù alle altre inferme, alle suore, e a quelle gentildonne romane, che mosse da nobilissima carità cristiana, si recano a visitare e consolare le inferme. Una d’esse commendò la Nunziatina in una brigata di signori, aggiugnendo, ch’ella avea un buon partito alle mani d’un giovane dabbene e laborioso; ma che per esser poveretta non potea conchiudere il matrimonio da ivi ad oltre un anno. Fra quelli che l’udiano magnificare il contegno, la modestia e la pietà della vostra figliuola sedea un ricco signore, fervente cattolico, il quale . .,
— Ma io non sono cattolico, interruppe Edmondo.
— Ehimei! Statevi zitto: chi ve l’ha detto che non siete cattolico? — Adunque fervente cattolico, il quale senza far motto a persona, saputo prima ove abitavate, venne a me di segreto; e mi disse — Eccovi, don Alessandro, dugento scudi, che darete a mastro Simone, acciocchè provegga il letto e l’acconcio a quella buona figliuola: ditele che preghi pel suo benefattore.
Oh questo si, disse Edmondo, che ne ho gran bisogno; ma voi, caro amico, sbagliate la somma. Io v’ho detto, che vorrei assegnarle un migliaio di scudi almeno.
— Voi non v’intendete di povera gente. Un migliaio di scudi piovuti in grembo cosi d’improvviso farebbero impazzire mastro Simone, la Nunziatina e lo sposo. Bisogna cogli infermi di stomaco andare adagino; poichè se li caricate di soverchio cibo a un tratto, in luogo di rafforzarsi e guarire, fanno una indigestione. Il mio pensiero sarebbe, dando li dugento scudi, di dire a mastro Simone; animate gli sposi ad esser buoni cristiani, e frequentare la chiesa; la Nunziatina che non sia vana e superbiosa; Cencio che non sia bettoliere e sfaccendato; e allora chi sa che il loro benefattore non volgesse l’animo ad aiutarli di vantaggio? —
Intanto io deporrei gli ottocento o mille scudi alla Cassa di risparmio, che tiene aperta pei minuali il principe Borghese; e n’avremo l’entrata d’una quarantina di scudi almeno; Cencio, ch’è garzone del suocero, avrà ancora un tre anni di garzonatico, nei quali moltiplicando i frutti, col capitale, conterebbe a suo tempo, de’ soli frutti, un capitaluzzo da metter su bottega in suo capo e fare maestranza: saldi sempre i mille scudi fruttiferi.
— La cosa m’entra, disse Edmondo, e veggo che voi siete uomo sperto in sì fatte beneficenze, le quali se tutti facessero a questo modo, veggo anch’io, che i poveri n’approderebbero incomparabilmente meglio, che darle a mano con pericolo che sfumino in dileguo fra pochi giorni. Dunque don Alessandro mio, vi farò carta di mille dugento scudi sul mio banchiere: a rivederci stassera da Carluccio — Così dicendo torse cammino verso la piazza di Venezia, e don Alessandro tenne verso il Pincio per visitare l’amico dipintore.
Carluccio era solo; e siccome egli era giovane lieto e compagnevole sì, ma di coscienza, così don Alessandro avealo in istima di savio e discreto, e più volte apriagli l’animo suo: laonde, acciocchè l’aiutasse all’uopo, riputò di narrargli in breve il caso d’Edmondo rispetto aIla Nunziatina, e come la virtù di lei lo comprese sì fattamente, ch’era uscito, in un impeto di cuore, a dir netto — Io son cattolico —
— Hem! riprese Carlo, io ci avrei i miei riveriti dubbii. Volete voi che da un amor pazzo, che il gittò in tanto farnetico da vergognarsene chi pur non avesse che un granellino di sale in zucca, volete, dico, che n’esca il trionfo più segnalato della divina Grazia, qual è il lume della Fede?
— Amico, soggiunse don Alessandro, Iddio nei profondi e misteriosi consigli della sua infinita sapienza sa trarre il bene dal male per sì fatta guisa, ch’eziandio, non solo le follie della immaginazione giovanile, ma persino i delitti più niquitosi dell’umana malizia possono divenire efficace stromento delle divine misericordie. Basta leggere gli atti dei Martiri per toccarlo con mano; ma senza rimescolare le antiche memorie, io n’avrei alle mani casi tali da farti stordire. Senti questo, il quale se non fosse intervenuto a me, penerei a crederlo io stesso ove altri il mi raccontasse.
L’anno 1834, mentr’io aveva la rettoria d’una chiesa, vivea esule in Roma una piissima e nobilissima signora polacca la quale solea frequentar la mia chiesa e confessarsi in essa. Una mattina ragionando meco mi disse, che soggiornando essa nella Villa Mattei sul monte Celio, usava spesso nella chiesa de’ santi Giovanni e Paolo, la quale è tenuta dai Padri Passionisti pulita e lucida come uno specchio. A quei giorni si parava a festa per l’esposizione delle quarant’ore, ed essa gentildonna a una tal ora vedeva entrare in chiesa una bellissima giovinetta bionda come l’oro, la quale seduta sopra una sedia vicino alla porta, stavasi immobile a riguardare i paratori senza batter palpebra. Avea tutta l’aria d’una forestiera.
— Pochi giorni sono, mi disse quella dama, nell’uscire di chiesa, nella quale siccome luogo solitario e remoto non era persona, vedendo io quella giovinetta così intenta, le dissi in francese — Damigella, siete voi cattolica? — No, rispose, ma amo di molto i cattolici — Ebbene, diss’io, pregate — Non so pregare, — soggiunse; ed io le replicai — Dite spesso: Dio mio, abbiate pietà di me — E mi promise di farlo. Don Alessandro, io la raccomando alle vostre orazioni —
Due giorni poi essendo io in casa mi venne annunziato uno, che volea parlarmi d’un suo negozio. Entra; e veggo un uomo sui trentacinqu’anni, complesso della persona, brunotto, con due gran basette alle gote, con una sottoveste bianca alla Robespierre, e un cravattone al collo col nodo alla Bolivar: pregolo di sedere, e lo domando in che potessi servirlo — Ecco, disse, mio reverendo, io son forestiere, e vengo a voi che avete fama di sacerdote zelante del bene delle anime, acciocchè vi degniate di darmi consiglio in cosa dilicata e che importa nulla meno che la salute eterna d’un’ anima — Io guardo ammirato cotesto ascetico di nuovo conio, e me gli offero pienamente.
— Io avrei, disse, alle mani una giovane protestante, che trovai nella chiesa de’ santi Giovanni e Paolo; un’angioletta proprio di paradiso, pura come una colomba. Costei non è in Roma co’ suoi genitori, ma viaggia con una nobile famiglia sua pari, ov’ha un’amica più che sorella; ma essa come il marito suo, sono due protestanti accanitissimi contro la Chiesa Romana. Or questa candida colombella dissemi piangendo, ch’essa brama ardentemente di rendersi cattolica, e non sa a quale partito appigliarsi: ditemi voi, reverendo, come potrebbe venire a capo de’ santi suoi desiderii —
lo risposi a quell’incognito, ch’egli era negozio da non correre all’avventata, ma da maneggiarsi con somma discrezione; mi desse tempo a pensarci; intanto bisognerebbe veder modo di farla entrare in conoscenza di qualche pia e prudente gentildonna e cattolica della sua nazione, che molte ve n’ha in Roma. Tra qualche giorno si compiacesse di ritornare da me; e così rimanemmo.
Quando costui si fu partito, dissi fra me — Sta a vedere, che costei è la giovane, di cui favellommi la gentildonna polacca!
Il dì vegnente verso le undici del mattino sento un busso forte all’uscio della mia camera, e veggo entrare il mio apostolo con un paio d’occhi accesi e con tutto il sembiante alterato. Lo invito a sedere: ed ei mi dice — Reverendo, favorite giù in chiesa, che quella damigella vi attende — Come m’attende? Chi l’ha condotta? — Io, reverendo — Voi? E come l’aveste? — I suoi entrarono in sospetto del suo santo disegno, e vogliono ricondurla alle sue contrade, e però io l’ho guidata qui a salvamento —
Allora mi cadde il velo dagli occhi, e fattomi di fuoco, gridai — Ah rapitore di vergini! ah seduttore dell’innocenza! così eh? sotto colore di zelo avete ingannato e rubato quella povera giovane abusando la sua pietà, strappandola agli altari, e ciò in una Roma? In questo momento forse ne gira in cerca la pubblica forza, e all’uscire di qui vi metterà le mani addosso, e sarete punito di ratto in galera. Ben vi sta.
A questa mia uscita improvvisa e concitata l’uomo smarrì, e fatto bianco come un panno lavato, supplicommi di scendere in chiesa. Io per pietà di quella poverina calai, e la trovai seduta presso la sacristia che tremava come una foglia: cercai di calmarla, e le chiesi se conosceva la gentildonna polacca. Mi rispose che sì. Allora rivoltomi a colui, gli dissi — Signore, poichè avete commesso sì gran fallo, io non ci veggo altro rimedio che di ricoverarla in qualche casa notabile di gran rispetto, ove sia una signora di segnalata probità e prudenza: non ne avete qualcuna alle mani? Mi rispose, ch’egli era intimo amico d’un ricco banchiere, persona nobilissima per la sua virtù e saviezza: e nominollo. Allora soggiunsi — Qui non v’è tempo da perdere: venga subito egli e la moglie —
Detto, fatto. In poco più di mezz’ora la giovane era accompagnata dalla sua protettrice in quella degna famiglia: il marito salì a me col forestiere , e c’intrattenemmo del caso. Io dissi ch’egli innanzi tutto dovea presentarsi al Console generale della nazione della giovane, e fare di sè malleveria per lei; così statuire le leggi di quel regno; al che mi rispose: ch’egli era presto d’entrare mallevadore per la donzella. Allora soggiunsi — Signor mio, voi fate un atto nobilissimo di carità ricoverando quella giovane, guarentendo per lei, e facilitandole il passo d’entrare nel grembo di santa Chiesa, in che solo è salute: di questo Dio rimeriteravvi da pari suo; ma io che mi vi professo gratissimo, ho a richiedervi d’un’altra grazia, che fia il compimento della vostra generosa azione — Dite, mi rispose rotondamente, e sarà fatto.
— Signore, ripigliai, dovete promettermi che, sin che la giovane è sotto il vostro tetto ospitale, non permetterete mai a costui di metter piede in casa vostra — Quel magnanimo mi serrò la mano, gridando — Ve ne dò la mia fede — Pensa, Carluccio, come rimase quel traditore! Non zittì, non m’alzò più gli occhi in viso; e partì coll’amico come un cane frustato: io visitai i due coniugi, raccomandai loro la donzella, cercai d’un sacerdote che l’ammaestrasse nella dottrina cattolica, e la giovane s’apparecchiò all’abiura con un fervore, che movea a tenerezza tutti della famiglia. Intanto io ne tenni ragionamento colla gentildonna polacca, la quale andò a visitarla, e le si offerse per madre, sostenendola poscia gagliardamente nella lunga e aspra battaglia, che l’invitta giovane sostenne co’ suoi parenti.
Il fraudolento, che sotto specie di pietà l’avea rapita, non potea darsi pace d’aver perduto sì bella preda: domandò, supplicò, scongiurò di poterla vedere almeno una volta; ma l’amico sempre saldo a negarlo. Finalmente per disperato un giorno andò al banco, e disfidollo a duello. Il banchiere avea militato sotto Napoleone I alle guerre di Russia; perchè sentendosi disfidare, balzò in piedi gridando — Ah vigliacco ladrone di fanciulle, fuori di qui, e non ti rivoltare, sai! ch’io ti darò della punta de’ miei stivali nel luogo più degno di te —
Quando la giovane fu bene ammaestrata, abiurò gli errori della sua setta, e fu ricevuta in luogo di figliuola dalla gentildonna polacca, che l’ebbe sempre carissima. Io poi seppi che il ribaldo, che aveala rapita, avea moglie in patria, e s’era innamorato di quell’angioletta, incontrandola per via; la venne appostando nelle sue gite al monte Celio; e vedutala cosi semplice e pia vi fece su disegno, infingendosi un Ilarione; sinchè per averla a sua posta, la tolse con inganno alla famiglia, cui era affidata da’ suoi genitori. Ma quando appunto egli credea d’averla nell’ugne, Dio nella sua infinita misericordia volse le insidie e il tradimento di costui a trionfo della sua grazia. Ora che meraviglia, Carluccio , che Dio si servisse di quello stolido amorazzo d’Edmondo a rappianargli il sentiero di giugnere nel seno amoroso delle sue misericordie?
DELLE FESTE ROMANE
Ogni casa vuol pure avere la sua entrata e la sua riuscita, e non è savio il volerla fare altrimenti che non porta la sua natura. Avvi delle case, nelle quali per ordinario s’entra per la porta a terreno; ed avvene dell’altre ch’hanno la porta al secondo e sino al terzo piano. Oh come può egli essere? Fabbrica la casa lungo la china del monte, e se tu ci voglia entrare dalla via che costeggia il dosso, e tu v’entrerai pel secondo o pel terzo piano. T’appaga?
Viaggiando anni sono nel cuore della Francia giunsi lungo la Loira, che scorre limpida e veloce per le belle e feconde valli del Puy, antica e nobile città delle Gallie, posta come un anfiteatro a piè dei monti vulcanici del Velay. La sua Cattedrale fu edificata sino dai tempi de’ Merovingi sopra un alto ronchione di cinghio, e di lassù sovrasta la città e la guarda maestosa e severa colle brune muraglie di trachite, col grande atrio soffolto da massicce colonne di basalto, e coi cornicioni rugginosi, sopra i quali torreggiano le statue gigantesche dei primi Re Franchi scolpite grossamente in quel sasso ferrigno.
Per salire al fianco d’essa cattedrale, sono intagliati in quella repentissima rupe tanti scaglioni, che dalla piazza giungono sino alle fondamenta del tempio, dando di loro bellissima vista; poichè quella scala è più alta di quella che in Roma da basso il clivo Capitolino monta insino alla basilica d’Araceli. Giunti in capo di quelli altissimi gradi, il cinghio era incavato a punta di scarpelli, e si salìa per certi chioccioloni, che metteano sotto il lastrico della chiesa, e sbucavano nel bel mezzo di quella: cotalchè in luogo d’entrarvi per la porta di fianco, come per tutto altrove, nella cattedrale del Puy s’entrava per lo mezzo del pavimento, uscendo da un pozzo con inestimabile meraviglia di chi vi salia la prima volta, e si vedea sopraccapo le volte del tempio.
Eccovi adunque ogni edifizio colla porta d’entrata e d’uscita rispondente alla sua postura: e mostratovi che ve n’ha colla porta a terreno, colla porta a mezz’aria, e sin colla porta di sotto in su, potrei additarvene di quelle che vi si cala pel tetto, come in Lapponia pel gran freddo e in Cafreria pel gran caldo, ov’ hanno le case sotterra, e vi s’entra per le cateratte di sopra.
Or essendo le cose così, oh perchè voler egli che tutti gli uomini procedano a un verso? Si dà biasimo da molti forestieri ai Romani perchè son Romani, e vivono romanescamente; han eglino a vivere alla Francese, alla Fiorentina, o alla Veneziana? E vivono alla Romana; che ci s’ha egli a fare? Ciascuno ha la porta di casa sua, secondo la natura del terreno, dell’aria e dell’acqua. Nell’Ospizio del Gran san Bernardo di verno si entra e si esce per le finestre, tant’ evvi alta la neve: in Egitto invece ne’ tra boccamenti del Nilo si entra e si esce dalle case in barchetta.
Siamo entrati in queste considerazioni a cagione che non pochi viaggiatori danno mala voce al popolo romano d’alcune sue costumanze singolari: chi lo chiama ancora pagano per certe sue cotali feste, che hanno forse radice ne’ tempi latini; chi per converso lo rampogna di superstizioso, perchè talvolta bestemmia e commette gravi delitti; e poi va in processione, si scrive nelle pie confraternite, si prostra dinanzi a un’immagine miracolosa della Madonna; s’è infermo vuol avere a canto al letto il Bambino d’Araceli, la berretta di s. Filippo, la fascia di s. Camillo, la manna di s. Nicola e cent’altre divozioni, come se uno, perchè commette fallo, non dovesse pentirsene mai, nè ricorrere per l’intercessione de’ Santi alla misericordia di Dio, ma viver da animale per omnia secula: onde che a detta loro, chi casca non si dovrebbe aiutare per rizzarsi di nuovo, sotto pena d’esser giudicato bugiardo e peggio. Per la stessa forma costoro gridano ch’ei non è vero quanto si dice della fede del popolo romano: perchè mescola spesso la divozione coll’allegria, e si trastulla e passeggia volentieri. Oh tutto il male stesse pur qui! Lasciatelo sollazzare a suo modo, che ve ne va egli? Ogni uccello ha il suo volo, ed ogni pesce il suo guizzo, conforme s’attiene alla sua natura. Il popolo romano è fatto così: di verno gode il sole, e l’ombra di estate: ha egli torto? ch’è quanto a dire, s’egli è tempo di pregare prega di cuore, s’egli è tempo di letizia vuol stare allegro, e se ne rifa.
In tutte le altre città d’Italia il carnovale s’allunga dall’Epifania sino alle Ceneri; in Roma invece il carnovale è di soli otto giorni; ma il popolo vi gavazza tanto, che mai baldoria più chiassona di quella. Ivi calza proprio quel gran detto antico dell’impazzire a ragione, ch’è impossibile per tutto altrove, eccetto che a Roma. Ed è sì vero, che tutti i forestieri, i quali convengono in Roma a decine di migliaia e vi pigliano parte attivissima, non rinvengono dal loro stupore a vedere un popolo, in tanta ebrezza di gioia, così moderato e ossequente alla legge; poichè nel più forte del tripudio, udito il segno di por termine alle gioie, cessa di presente, e vassene cheto pe’ fatti suoi.
Il carnovale romano s’accentra sulla via del Corso, ov’è la carriera de’ barberi, e il giro delle carrozze. Nella piazza del Popolo, a piè dell’obelisco rizzasi uno steccato a semicerchio, ov’è la mossa de’ corsieri: ai due lati s’alzano due magnifici padiglioni, in cui seggono parte dei Conservatori di Roma per presiedere alla sferrata de’ barberi, e per su tutta quella lunghissima e dirittissima via son palchi e steccati sino alla ripresa, ov’è un altro padiglione de’ giudici della meta. La mossa de’ barberi si fa dopo la calata del sole.
Intanto al bombo della campana di Campidoglio s’apre la venuta delle carrozze, e in poco d’ora il Corso n’è pieno a doppia fila, e vi si fa un baccano inestimabile. Le dette carrozze son tutte aperte, e i gran signori usano i carri da caccia colle sponde a piuoli: tutta la cassa v’è foderata di mussola bianca; le donne sono in abiti bianchi a sacco e gli uomini in candidi camiciotti, e in cappellozzi flosci color di cenere: nel mezzo del cocchio son due panieri; l’uno pieno di confettini a gragnuola di gesso, l’altro a mazzetti di fiori. Le finestre, le logge, i balconi e i palchi son tutti messi a drappelloni e a ricascate di damaschi, di zendadi e di mussoline, vermiglie e cilestre; e i davanzali sono pieni di spettatori, i quali hanno anch’essi di gran ceste piene di confetti che gettano nelle carrozze. Quegli delle carrozze scaglian confetti e mazzolini di fiori alle finestre; e tutto questo grandinare e ricevere e gittar di fiori e di confetti forma tutto il bello, il vario, e l’animato di quella festa.
Nè i Romani son essi soli a cotesto tripudio; ma le mi gliaia di forestieri calati a Roma dalle regioni tramontane se ne sollazzano maravigliosamente, e non sanno saziarsi di matteggiare; perocchè usati come sono alle loro contrade ove i popoli sono di natura più riposata e tranquilla, per non dir fredda, si abbandonano alla sbrigliata a quella gaiezza, ch’è propria de’ sangui meridionali; confessando, che la libertà si proclama nei loro paesi a suon di tromba, ma non si pratica e non si gode appieno che a Roma, ch’essi credeano serva e schiava da catena. Egli è una gioia a vedere que’ nobili e ricchi giovinotti stranieri scalmarsi a gittare manciate e mestolate di confetti sulla folla del popolo, e far lune e soli e stelle sulle schiene, perocchè i confetti rompendosi e sfarinandosi fan sulle giubbe spruzzi, e cialdoni bianchissimi. Essi sono nelle carrozze in bluse, e tengono al volto la visiera di reticina fitta; ma tuttavia è tanta la grandine che scroscia dalle finestre,, che hanno tutti l’aria di mugnai usciti allora dalla tramogia e dal frullone.
Le popolane di Roma che vanno in capegli, e le più gli hanno nerissimi, paion tutte coperte della polvere di ciprio; e quelle che sono in polacchine di stame bruno o tanè pare che abbiano stacciato la farina fiore, tanto son elle chiazzate di polvere di gesso. Chi si scrolla di qua , chi si strofina di là, chi si toglie di tasca una spazzoletta per riforbirsi, e mentre si sbratta, ed ecco un cucchiaione di confetti che lo spolverezza di nuovo. Cotesta gragnuola cascando entro le golette increspate delle gentildone, le inzuccherano come le fragole, e la sera nello spogliarsi que’ granellini corrono lor per la vita: gli uomini poi se ne trovan le tasche piene. I nembi de’ fiori spicciolati che si versano dalle finestre, e cascano sulla gente, fanno delle trecce, de’ cappelli e delle spalle un giardino: le ciocche e i mazzolani volano dalle carrozze alle finestre, e spesso non v’aggiungono a parecchi palmi, di che ricadon sulla calca, e ognuno alza le braccia per acchiapparli, e rimandarli nelle carrozze.
Aggiugnete in mezzo a cotesto frastuono le maschere a piedi, ove i pagliacci e i pulcinelli hanno legato in capo a certe mazzuole vesciche gonfie, e le zombano pel capo e per le spalle del popolo con un rimbombo indiavolato: gli arlecchini colle spatole fesse picchiano gli astanti, e romoreggiano e croccano; altre maschere soffian nelle buccine di mare, e cornando assordano; chi batte sistri; chi cembali; e il rumor delle ruote, l’annitrir de’ cavalli, il trambusto degli stromenti fende il cielo. Ed ecco si sparano le bombardelle. Le carrozze a quel segnale imboccano i vicoli da lato, e sfogano nelle vie parallele al Corso, sgomberando per la corsa de’ barberi: al secondo sparo quelle migliaia di carrozze si son dileguate, e un drappello di cavalleggeri spazza di gran carriera tutto il Corso.
Allora i popoli si ritirano stipati lungo le case e attendono il passaggio rapidissimo de’ corsieri. Sulla piazza del Popolo è tirata la fune alle mosse; dietro a quella i barberi addestrati dai barbereschi zampeggiano, s’inalberano, rignano, fremono divorando cogli occhi l’agone: essi non hanno che una testieretta in capo, sopra cui ondeggia nn piumino, e ai fianchi e alle groppe hanno appiccato con pece delle pallottole a punte d’ago. AI segno dato, è tolta la fune; i barberi sferrano, e via. L’impeto del primo slancio, le grida del popolo, il pungolo degli spilli, l’emulazione che li arrovella, impennano sì fattamente il corso de’ barberi che l’occhio li può appena seguire. Gli Agonoteti o il Magistrato della meta gli attende dal padiglione; i barbereschi gli aspettano a piè fermo alla tenda della ripresa; i due o tre barberi che anelano alla vittoria si dinanzano di poco, e si soffiano addosso, e danno e ricevono stimolo a vicenda: al primo che giugne il barberesco si scaglia alla testa; e tanto è l’impeto della foga che il barbero lo si leva per aria. I plausi al vincitore echeggiano intorno; e il padrone del barbero si presenta tra i festeggiamenti degli amici al magistrato, e riceve solennemente il pallio di velluto o di tocca d’oro.
Allora il barberesco addestra il corsiere e un altro gli tien sollevato il pallio sopra un’asta, e a suon di stromenti lo mena lungo il Corso e per le più popolate contrade a ricevere dagli spettatori gli onori del trionfo. Il sentimento dell’animale è meraviglioso, sì procede superbo: e tiene il capo alto; e guarda con occhio giulivo; e inarca il collo; e guizza gli orecchi, ed agita la criniera, e porta la persona ristretta con un andar gagliardo e sonante.
Ciò tuttavia che rende più singolare il sollazzo carnovalesco dei Romani si è l’ultima sera di carnovale, quando si fa la festa de’ moccoli. Dopo il pallio rientrano le carrozze nel Corso, ed essendo già in sull’ annottare ciascuno accende un moccolo quasi per fare i funerali a berlingaccio. È una scena piacevolissima a vedere tutti i palchi, e i due giri di carrozze che pigliano da un lato e dall’altro tutta quella lunghissima via, ove ciascuno che v’è suso ha un lumicino di cera acceso in mano. Quelli che sono a piedi tentano per ogni modo di spegnerlo; e chi è in carrozza cerca per ogni modo di tenerlo acceso. Indi un nuvolo di giovani che danno l’assalto alle carrozze e ai palchi co’ fazzoletti, co’ soffioni, colle tese de’ cappelli per ismorzare i lumi; e chi li tiene, alzarsi in punta di piedi acciocchè non v’aggiungano; e appena spento un lume, tutti gridano — Eh… eh… senza moccolo! E l’altro lo riaccende, e ripete — Ecco il moccolo!
Voi vedete gli eleganti carri da caccia pieni di giovani principi romani e forestieri, e le superbe carrozze piene di gentildonne folleggiare col popolo alla mescolata. Quella sera tutti gli ordini cittadini scompaiono, tutti sono fratelli, tutti si confondono gli uni cogli altri: è un datur omnibus: ciascun bada a spegnere, e a tenere acceso. In quel chiasso, in quell’aggiramento, in quel vortice di pedoni, di cavalli, di ruote, di timoni, stupore che non avvenga mai un sinistro accidente: e’ pare che i cavalli quella sera abbiano più senno degli uomini. Basterebbe che un cavallo ritrosisse, impennasse, si gittasse alla banda per ischiacciare la calca. Nulla. Il Popolo salta sulle salitoie, sui mozzi e sui raggi delle ruote, passa frammezzo le gambe de’ cavalli, e in quell’agitare continuo di fazzoletti non bastano i paraocchi delle testiere, poichè spesso sbattono i fazzoletti loro dinanzi, li urtano, li attraversano; e i cavalli non imbizzarriscono. Chi è in carrozza si spenzola per ispegnere i lumi di quelli che sono ne’ palchi: que’ dei palchi si rizzano e si disten dono per ispegnerli a chi è in carrozza. E mentre uno lo spegne all’altro, ed ecco dietro la montatoia un traforello salta sul soffietto e lo spegne allo spegnitore.
Chi dalle finestre mira quello spettacolo è una cosa stupenda: tutta la via del Corso arde; e vista nel suo pieno sembra un fiume di lucciole, che appaiono scompaiono, e scintillano e rabbuiano con uno avvicendarsi incessante. Ma lo spettacoto più ammirando si è allo scocco dell’ora di notte, che tutti a un tempo spengono i lumi e vannosi chetamente ai fatti loro. Ove mai trovare un popolo sì docile e discreto, che in mezzo al più tempestoso baccanale si raccheta ed abbonaccia a un tratto? Il Romano in ciò non ha pari, e mostra l’indole sua aggiustata e obbediente alle leggi. I forestieri di tutte le nazioni, che s’attendono squadre di cavalli che vengano alla carica per disperdere il popolo, rimangono stupefatti al vedere, che al tocco dell’ora di notte tutti ripiegano i fazzoletti, chiudono i ventagli, spengono i moccoli, e zitti e chiotti si mettono per le vie traverse e sgomberano il Corso, che in poco d’ora non vede più una carrozza.
Si dica il medesimo per Pasqua e per s. Pietro all’illuminazione della facciata e della cupola del Vaticano: lo stesso pe’ fuochi d’artifizio della Girandola; che si faceano nel maschio di Castel sant’Angelo, ed ora sul Monte Pincio: appena cessato lo splendore de’lumi, o i razzi, e lo scoppiettare de’ girelloni e delle fontane ardenti, ognuno ritorna in pace ai suoi focolari: lo stesso dicasi delle Tombole in Piazza Navona o in Villa Borghese; lo stesso degli altri spettacoli, di cui è sì ghiotto il popolo Romano: e perocchè tanto ordine e tanta pace incresce fieramente ai settarii, alcuna volta si presero il maligno piacere di gittare in mezzo a quelle calche curiose lo sbigottimento e la confusione.
Evvi in Roma un altro singolare costume, che attrae il popolo in folla a vedere, e questo si è nella state, ed ha, a creder nostro, le sue origini sino dai tempi de’ Cesari. Roma è la più ricca città d’acque correnti che siavi in Europa; perocchè gli imperatori con isfolgorata magnificenza le derivarono ben da lungi le quaranta e le cinquanta miglia, conducendole per valli e per monti con gallerie sotterranee e con archi altissimi a immensi tratti, sino a introdurle nel cuore di Roma, dove si spandeano per le marmoree fontane, pe’ ninfei e per le terme de’pubblici bagni. Queste acque venieno da quattordici vene, ed eran celebri gli acquedotti dell’acqua Claudia, della Giulia, della Marzia, della Tepula, della Vergine, della Traiana, e dell’Alessandrina.
La quantità delle acque era tanta, che, raccolta poscia nelle docce sotterranee, avviavasi ne’ giardini a ridurla in fiumicelli, in cascate, in pelaghetti ed Euripi ; o innalzavasi negli agoni e negli anfiteatri a formare le natatorie e le naumachie o battaglie navali per curioso trattenimento del popolo. Egli è certo che nei grandi calori della state coteste acque rinfrescavano la città mirabilmente, e la plebe se ne giovava per sè e pei cavalli, che menava a bagnarsi la mattina e la sera per refrigerar loro il sangue nelle vene. Egli pare che cotesta usanza duri ancora in parte nella Roma moderna, e sia una memoria delle antiche feste Fontali.
Di tante acque perdotte in Roma dalla repubblica e dagli imperatori non ci rimangono che l’acqua Vergine, l’Alessandrina e la Traiana; perocchè l’ostrogoto Vitige assediando Roma, e volendola privare delle mulina interne aggirate dai risciacqui delle fontane, l’anno 537 ne tagliò tutti gli acquedotti, i quali furono poi in parte ristaurati da Belisario e da Narsete; ma nelle nuove invasioni essendo caduti, e Roma rimasta quasi spopolata, il Pontefice Adriano I l’anno 780, ne ravviò parecchi a benefizio della città. Finalmente nel secolo XVI, risorte le arti e rifiorita Roma per munificenza de’ Sommi Pontefici, furono raccolte e ravviate quelle sorgenti che poterono rinvenire. Paolo IV riappiccò gli acquedotti dell’acqua Vergine d’Agrippa: Sisto V, quelli dell’Alessandrina guidata dall’imperatore Alessandro Severo; e Paolo V quella dell’imperatore Traiano. Questi tre Pontefici edificarono le tre portentose fontane di Trevi, delle terme Diocleziane, e del Monte Gianicolo, le quali si partiscono per canali e fistole a rallegrare tutte le piazze e le case di Roma con un’abbondanza strabocchevole.
Innocenzo X della casa Panfili derivò un doccione dell’acqua Vergine nel mezzo di Piazza Navona, ch’era in antico il Circo Agonale d’Alessandro Severo. Ivi Innocenzo edificò la sontuosa basilica di sant’Agnese, e al dirimpetto di quella fece rizzare dal Bernino l’obelisco di Caracalla, che sovrasta una delle più belle fontane del mondo; tanta è la maestà e leggiadria con che fu condotta da quel celebre architetto, e arricchita delle statue gigantesche figurate pei quattro maggiori fiumi del mondo: il Danubio per l’Europa, il Gange per l’Asia, il Nilo per l’Africa, e il Rio delle Amazzoni per l’America. Il bacino della fontana è circolare e forma un pelaghetto limpidissimo delle acque che mostrano uscire dai quattro fiumi summentovati.
Ora nel mese d’Agosto, quando i calori del sollione sono più cocenti in Roma, il sabbato sera si chiude colle cateratte il chiavicone di piazza Navona, e si turan le fistole del pilo della fontana; di che il pilo s’empie e trabocca le acque giù pe’ gradi, e discorrono per la piazza, la quale essendo in tutta la sua elittica dolcemente inchina verso il mezzo, forma come una lunghissima cuna. La piazza è già sgombera di tutti i banchi, le ceste, i bigonci e le scaffe de’ rivenduglioli; onde in poco d’ora le acque inondano per tutto e si spandono in lucidissimo lago, entro il quale come tre isolette sorgono la gran fontana d’Innocenzo X e le altre due di Gregorio XIII, che sono ai due estremi della piazza, eleganti anch’esse di finissimi marmi, di statue, di colonne e di mostri marini. Si specchiano nella limpidezza delle acque la basilica di sant’Agnese coll’ardita sua cupola, il collegio e il palazzo Panfili con tutte le case che dal lato di sant’Agnese, di s. Giacomo, e del palazzo Braschi costeggiano tutto intorno la bella piazza.
Ed ecco a mano a mano sboccare dalle vie traverse vetturali, carrettieri, e mozzi a bisdosso de’ loro cavalli e ronzoni conducendoli al bagno delle fresche acque, ove li abbeverano e passeggiano a lungo: in quel tempo arrivano eziandio a suon di tromba gli squadroni della cavalleria, dell’artiglieria e del carriaggio, e adacquano i loro cavalli passeggiando entro il lago a tondo: frattanto i monelli di piazza Navona, della Rotonda, di sant’Eustachio e di tutte le contrade colà intorno corrono al lago, e scalzi, e coi calzoncelli riboccati insino all’inforcatura entrano nelle acque e vi ragguazzano coi pie’ e colle mani; e chinatisi e fatto giomella delle mani, annaffiano e sprazzano i circostanti che dall’orliccio asciutto stanno mirando e ridendo, e minacciando quegli insolenti, e gittando loro torsi e bucce di cocomero, e fradici pomi d’oro. I cavalli a quella frescura refrigerati zampeggiano, e i pulledri saltacchiano allegri, e i muli si raccosciano, mentre i putti ammettono loro i cani, e gridano e urlano e fischiano loro intorno.
La domenica vegnente poi la festa, il gaudio e la parata è molto maggiore; perocchè vengono a bagnarsi e rinfrescarsi le carrozze de’ patrizii e de’ cittadini romani. Tutto il popolo v’accorre da ogni parte, e si stipa lungo le sponde, le botteghe e i rialti: le finestre, i balconi, i pergoli e le logge son piene di signori e donne che godono lo spettacolo dall’alto, e agitando i fazzoletti bianchi alle carrozze degli amici e dei parenti accrescon la festa. Son due popoli uno di mare ed uno di terra, che gli uni danno mostra di sè nell’acqua e gli altri all’asciutto. I cocchieri entrano adagio a cagione che i cavalli non abbian ribrezzo dell’acqua, e quegli che adombrano e sbuffano sentono sopraccapo il fischio e lo scoppio delle scuriate, e il serrare de’ morsi e il picchiare delle fruste in sulle groppe. I rotini dinanzi sono tutti sott’acqua, e le rote di dietro s’affondano sin sopra il mozzo; lo scalpitar de’ cavalli, e l’aggirar delle ruote alza le acque, e bollono e spumeggiano che sembra un mare in burrasca.
Dopo la calata del sole i cocchi nettunii escono dell’onde coi Tritoni, colle Naiadi e colle Anfitriti, che menavano a spasso per gli spumosi flutti, e salgono in sulle delicate e morbide selci delle vie di Quirino che squarciano i piedi a chi le cammina; ma non così fanno i Quiriti, i quali trovano un altro sollazzo non meno gustoso senza dipartirsi dalla piazza Navona. Dovete sapere, che nell’estremo fondo della piazza verso l’Apollinare la sponda va dolcemente rialzando sicchè non vi giugne l’acqua del lago, e in quel tratto asciutto son poste ad anfiteatro di molte scancie o prodicelle a piramide, sopra le quali sono in bell’ordine posti e accomodati mezzi cocomeri fiammeggianti, intramezzati da fette d’ogni grandezza, allogatevi bellamente di costa e di taglio, onde si paia che tutta la piazza sia una fiamma di fuoco torreggiarne. Attorno a cotesti scaffali son messe tavole e sedie, le quali attendono i buongustai. Non dubitate che ve n’abbia carestia: no davvero. I Romani son ghiotti all’eccesso de’cocomeri; e se la state non se ne fanno di molte satolle non ne son paghi. Basti dire che l’anno del colera morbus essendo stati vietati i cocomeri, la plebe romana ne mormorava come d’una sevizie e tirannia de’ medici: e perchè in Roma non si permetteano d’entrare, le feste uomini e donne ne usciano per gli orti in cerca e se ne rimpinzavano; dal che avveniva, che il lunedì cadeano malati tre cotanti. Narrasi che fra questi fu un carrettiere massiccio e forte come un atleta, il quale uscito di Porta Portese ai cocomeri, ne comperò un paio, e affettandoli facea questo dialoghetto fra sè e sè — Sor colera, me lascereste magnà sta fetta de cocomero? — Via via, lasciatemela magnà, sor dispettoso — E mangiato quella, e presone un’altra, ripigliava — Sor colera, viva la faccia vostra! E sapete che son buoni? Oh lasciatemene magnà un’altra fetta. E quest’altra al vostro bel grugno, e quest’altra ai baffi de’ medici, che v’han dato il passaporto per Roma, grazia loro! E così celiando se n’empì il buzzo come un otre. La notte stessa fu portato al Lazzaretto coi dolori, e la mattina era già ito al sotterratoio.
Adunque dopo il giro delle carrozze in piazza Navona, il popolo siede alle tavole de’ cocomeri e ne trionfa un sobbisso, gittando in terra le bucce, che sono raccattate dai monellacci, e le si attaccano a’ denti, divorandole sino al verde, e lavandosi il mostaccio insino agli orecchi. Ma perchè il cocomero, sebbene sia tutto acqua, fa sete, e vuol esser cotto nello stomaco, così alcuni ad ogni fetta ingollanvi un bicchierino di rhum; e poscia chiamato l’oste, che ha le cantine lì da lato, annaffiano il cocomero con di buon fiaschi di vino d’Orvieto e di Marino.
Similmente per s. Bartolomeo la divozione conduce il popolo romano all’isola Tiberina, ove si venera il suo santo deposito e si ricevono le indulgenze: onde fatte sue orazioni in chiesa, esce, e trova la tentazione del pomo d’Adamo. Con ciò sia che tutta la piazza e le vecchie spallette dei due ponti sono adobbate di cocomeri affettati, i quali brillano d’un rosso che vince il vermiglio de’ damaschi e la porpora tinta in grana. Gli scaffali delle fette costeggiano il convento de’ Frati Minori, e lungo le prode sono le mucchia de’ cocomeri interi, che sembrano i monticelli di bombe sullo spianato d’una piazza forte. Chi li picchia per udire se son pieni; chi li fa tagliare per vedere se sono infocati; chi ne gusta un trincetto per sentire se son saporosi, e poi seggono alle tavole; e di’, bocca mia, che delizia! Anche costì, già s’intende, girano i fiaschi, e dee esser del buono, altrimenti rischiasi una indigestione. Pochi anni addietro e’ v’era un altro sollazzo, che ora a giusta ragione è vietato: perocchè lungo le sponde dei due ponti stavano di molti putti ignudi con un batoletto a cinta; e la gente per trastullo sciocchissimo gittava loro nel Tevere un cocomerone: i putti salivano sulle spallette, e d’un salto a capo all’ingiù sì buttavano nella corrente, e a nuoto lo inseguiano, gareggiando a chi l’acchiappava. Indi i casi mortali di coloro che portati dalla furia delle acque sotto i mulini affogavano fra le ruote: altri saltando da quell’altezza dell’arco faceano il tonfo sì profondo, che essendo in Agosto le acque basse, davano del capo nell’arena e rimaneano intronati e soffocavano.
Nella state i Romani hanno ne’ dì delle feste altri diletti, imperocchè escono a brigate dalle porte, riunendosi insieme molti del parentado o del vicinato, e vanno alle osterie dei dintorni a cenare la lattuga e il prosciutto, mangiando all’aperto sotto le pergole dei giardinetti e degli orti. Alcuni de’più ghiotti entrando nell’orto fanno mercato coll’ortolano d’un’aiuola intera di lattuga, e, convenuti del prezzo, danno in que’ bei cesti, e pigliatone il cuore, ch’è bianco come la cera, se li vanno pappolando col pan fresco per guisa , che in cinque o sei fanno campo raso in poco d’ora come se vi fosse entrata una torma di papere: indi rientrano all’oste, e condiscono quell’insalata con parecchi fiaschi di vino al suono della ribecca, la quale spande colla sua armonia molte allegrezze ai popoli, e condisce la letizia di quei diporti. Altri essendo appena calato il sole, dopo il cenare, entrano ne’ praticelli e giocano alle bocce o ai birilli, mentre le fanciulle ballonzolano fra loro, sinchè all’imbrunire riduconsi lietamente alla città.
In Settembre le grandi raunate del popolo sono la sera in sulla piazza Navona alla magnata de’ fichi. In terra di Roma ve n’ha gran copia, i quali vengonle ogni giorno portati dai colli laziali e dai sabini in canestri colmi, in bell’ordine posti in mostranza su per li deschi. Avvene d’ogni ragione e d’ogni colore, verdi, verdini, verdoni, rosselli, giacintini e morati; e vi trovi i fichi zuccaiuoli, i garaoncini, i calavresi, i brogiotti, i castagnuoli, i pisinelli, i grasselli, i zuccherini, e i lardaiuoli. I Romani seggono a un gran canestro a quattro e a sei, e dicono al villano — Quanto li dai? — Tanto — Convengono del prezzo; e poi dàlli, e mandan giù. Prima scelgono i più maturi , quelli della lacrima e dalla pelle vizza e scalfita, che paion graffiati dalle gatte, e molti mangianseli interi senza nè partirli nè mondarli ; poscia vengono ai tortoni e a quelli che fan bocca da ridere, ed hanno il lattuccio attorno al picciuolo. Tanta è la smania d’insaccar fichi nella ventraia, che vuotano il canestro in men ch’io nol dico.
Eccoci costì sempre al mangiare, esclamano i forestieri: panem et circenses, questa è la divisa di Roma; e voi lo ci date per un popolo nobile e d’alti spiriti e generosi. I Romani son diluvioni e tutto termina in gozzoviglie — Adagio coi Romani: noi parliamo qui del popolo e non dei gentili, i quali hanno, come tutti gli altri cittadini d’Italia, i loro speciali sollazzi secondo lor gentilezza ; ma ove parlasi di plebe, sia ella tedesca, sia ella francese, sia ella di che nazione si voglia, la non ha miglior piacere che quello di bere e di mangiare, perocch’ella non gusta i diletti raffinati: e in ciò, come ben disse don Alessandro, tutto il mondo è romano.
Il popolo di Roma poi, che ha dell’eroico e tiene ancora dell’indole antica, ama sopra ogni altra gente italiana gli spettacoli, nei quali trionfa la virtù e la forza: onde ha caro di vedere ne’ suoi teatri i Paladini che combattono in difesa del debole e dell’oppresso: le battaglie commesse per liberare un popolo ingiustamente assediato: la Lucrezia, che violata s’uccide: la Virginia, che per serbarla inviolata dal Decemviro, è scannata dal padre in mezzo al Foro. Così cotesto popolo assiste volentieri ai giochi di forza, ai salti sui cavalli, alle prodezze de’ ballatori di corda, e insino che furono permessi nel mausoleo d’Augusto certi giochi atletici, uno dei più cari per lui, era la cavalcata del giovenco furioso. Era in ciò famoso, Luigetto la Merla, vocato il zoppo, il quale vive ancora. Costui, dopo che i fieri molossi avean lungamente accaneggiato il toro, il facea prendere per le corna col laccio scorsoio, e tirarlo sbuffante e resistente a un mozzicone di colonna: ivi col capo basso e confitto a un anello di ferro il tenea, sinchè gli avesse gittato in sulle reni una bardella da cavalcare, e affibbiatala con due cignoni rinterzati , egli vi saltava a cavallo. Il toro al sentirsi la sella e l’uomo addosso sbuffava, spumeggiava, mugghiava, e quando era più invelenito scioglievasi il canapo che il tenea basso; ma nell’atto che il toro si rizza, i torieri gli dan foco sotto la pancia a due razzi, i quali scoppiando e sprizzando come due fontane ardenti, attizzan la fiera e la convolgon nel fumo. Il giovenco a quel tuono, a quel cociore, a quel fumo spicca un salto smisurato, ed entra in una furia inenarrabile. Gli slanci, le contorsioni, gli sbuffamenti, le smanie che mena gittano lo spavento nei cuori più fermi e più gagliardi : ma Luigetto, serrate le ginocchia agli arcioni e curvo sulla persona, acconsentendo ai groppi e agli sgroppamenti indiavolati di quel furioso, sta saldo in sella come s’ei fosse una cosa stessa col toro. Finalmente dopo aver corso l’agone due’ o tre volte fra i plausi, le ammirazioni e i tripudii del popolo, i torieri gettano il cappio alle corna di quel furibondo, e lo stringonoalla colonna, onde il cavalcatore, puntato le pugna sull’arcione, salta leggerissimo in terra.
IL VECCHIO E IL NUOVO
Roma non ha forse de’ suoi antichi palazzi chi serbi le primiere sue forme come il lato del monistero di Torre di Specchi, in che abitato avea santa Francesca Romana, fondatrice delle dame Oblate di Maria. Quel quartiere fu sempre mantenuto inviolato dalla divozione delle gentildonne sue figliuole con tanta cura, che vi si veggono ancora le interne scale, salite e scese le tante volte dalla Santa: evvi ancora la sua cella collo stesso palco e collo stesso pavimento, e un’altra camera grande tutta dipinta secondo la scuola di Giotto, dei fatti principali della sua vita. Le quali dipinture ci conservano le fogge del vestire del secolo XIV e dei primi anni del XV; e ci offrono ancora la vista delle contrade di Roma, e delle case turrite per sostenere gli assalti delle fazioni nelle guerre civili, che per tutto il medio evo travagliarono la città, signoreggiata, o meglio, spesso tiranneggiata dai Colonna, dagli Orsini, dai Frangipani, dai Cenci, dai Savelli e dagli altri potenti Baroni, i quali si asserragliavano ne’ loro palagi, e il popolo diviso si combatteano per le vie e per le piazze abbarrate, coll’accanimento dell’ira e del furore di parte.
È ancora nel monistero di Tor di Specchi un’alta loggia, donde si scorge la rupe Tarpea e tutto il fianco dell’antica rocca Capitolina; e le pareti della detta loggia sono dipinte all’usanza del secolo XIV, e vi si veggono gli archi acuti e le volte co’ pilastri a faccette, e in esse infitte mensole e nicchie con entrovi statue di guerrieri colle cotte di maglia, e cogli elmi a buffa. Nella fronte è figurata la pietosa istoria quando santa Francesca, per salvare il marito, consegna di sua mano per ostaggio al più sfidato nimico di sua famiglia il figliuol primogenito con una fermezza di cuore e serenità di sembianti che metton lo sgomento nell’animo di quel feroce.
Ciò che fa al caso nostro in coteste anticaglie si è il vedere che a lato di quelle rozze scene di ponti caduti, di casamenti scalcati, d’abituri di tavernai e di pescatori, di ceffi di sgherri e di militi inferrucciati; s’apre da un fianco una camerella rotonda co’ suoi finestrini a cristalli di vaghi colori e ornati di seriche tende. Le volte sono a spicchi dorati, il pavimento è ricco di marmi, le pareti sono bellamente dipinte, e in mezzo di cotesto leggiadro stanzino vedi la Santa in abito di gentildonna romana in ginocchio, dinanzi a un Crocifisso, sollevata e rapita in estasi, e ritto vicino a lei l’angelo, suo visibil compagno, colle ali spante in atto d’offerire a Dio la calda preghiera di Francesca. Niuno di certo fra la rusticità di quel contorno s’ attendeva tanta eleganza e nobiltà improvvisa.
Similmente l’antico quartiere della Santa, il quale riceve sì poca luce dalle strette e aguzze finestre gotiche, spira tutta la semplicità e la rozzezza di que’ bassi tempi: le mura storiate da capo a fondo cogli anneriti colori rendono allo sguardo una mestizia reverenda; quelle vecchie panche tarlate, quei cassettoni di noce bruna, quelle impalcature di travi affumicate, vi balzano di tratto cinque secoli addietro, e vi par di vivere per incanto ne’ fieri tempi di Cola di Rienzo, o poco dopo il gran scisma d’Occidente, quando alla morte d’un Papa il popolo mettea alla ruba le stanze pontificali, nè pago a tanto, assaltava i palazzi de’ Cardinali per rapinarli; e i Cardinali eran costretti d’afforzarsi ne’ palazzi e difendersi da’ piombatoi delle bertesche, e dalle feritoie colle balestre e coi lancioni.
Ora allato a cotesto scuro edifizio voi vedete sorgere come per incanto una magnificenza di portici, di archi, di logge, di corridoi, e di camere lucidissime e nettissime (avvegnachè povere e schiette), le quali riescono sopra vasti cortili rallegrati di fontane e d’agrumi: le cappelle sono ricche, eleganti e d’una forbitezza e squisitezza che inspira divozione ed amore. Ma nulla è da comparare all’altar maggiore della chiesa interna, ornato da pochi anni per opera d’una signora Oblata con uno splendore che forse in tutta Roma non ha chi l’agguagli. Imperocchè l’ambito dell’abside, l’altare stesso, e i suoi gradi è tutto di piastre dorate a vari scompartimenti di bassirilievi, di fregi finissimi e vaghi d’intaglio e di pietre preziose.
Tutto poi cotesto aureo podio è aggirato d’una cornice, sulla quale son posti grandi e nobili candelabri d’oro alternati con vasi di bellissime ciocche di fiori: e i candelabri son formati di varii gruppi d’angioli, e ì vasi adorni di figure e di fogliami a sbalzo e a incavo con ismalti e castoni di gemme, che brillano mirabilmente alla vista.
Lo splendore di quell’oro, il luccicore di quelle gioie, l’artifizio di quegli intagli, l’opaco di quei campi, il brunito di quelle cornici, la maestà di quell’altare, la magnificenza di quei candelabri vi ricordano l’Arca del Testamento e l’altar dei timiami, e vi sollevano e in un sprofondan l’anima dinanzi al trono di Dio.
I due contrapposti così ricisi in Tor di Specchi delle rozze e aspre memorie del medio evo, colle dolci eleganze della gentilezza moderna m’introducono a considerare i costumi dell’antico popolo romano coi Romani d’oggidì, e discorrere le cagioni che tanto mutamento effettuarono. Chi legge le cronache di Roma dal nono secolo al decimoquinto, in mezzo a tratti di nobiltà, di magnitudine, di elevatezza e sublimità stupenda sopra ogni dire, vede contrapponimenti terribili di ruvidezza silvestra, d’audacia isfrenata, di libertà licenziosa, di ferità sitibonda di sangue; per tale che vi paia della romana semenza non essere, fra l’invasione di tanti barbari e fra tante ruine, allignata nei sette colli se non la schiatta feroce de’ pugilatori, degli atleti e de’ gladiatori. Con ciò sia che dove gli altri Comuni italiani sursero per libertà a gentilezza, il Comune di Roma volse la libertà a vieppiù imbarberire e inferocire dispettando ogni legge; appunto perchè mancava chi le reggesse il freno della lunga assenza de’ Pontefici dimoranti in Avignone, e poscia pel grande scisma d’Occidente, che sconvolse la’ Chiesa di Dio, e turbò sovr’ogni altro il popol di Roma.
Se non che dopo il Concilio di Costanza, ricomposte le cose divine e umane, avendo recato Martino V la sedia stabile in Roma, e succedentisi i Pontefici sul monte Vaticano, a poco a poco cotesta plebe si ammansò e colse i frutti della pace, spogliando la dura scorza d’asprone, ond’era da tanto tempo ricoperta. Non è tuttavia che gli orgogliosi e potenti suoi baroni non le destassero a quando a quando l’inveterata fierezza e impetuosità naturale ; ma prima combattuti da Alessandro VI, e poscia conquisi da Sisto V sbaldanzirono, e fatti più miti, anco la plebe romana mitigò l’aspro animo senza viltà, conservando intemerata la nobiltà e generosità dell’indole antica.
Coi Pontefici presero stanza in Roma le arti belle, e Giulio II specialmente le accolse e onorò nel Bramante, in Michelangelo e in Raffaello, lasciando poscia sì bella eredità a Leon X, che l’accrebbe mirabilmente e la condusse a sì alto segno, che il secolo delle lettere e delle arti, nomossi per lui l’aureo secolo di Leone. Il popolo romano, circondato da tanta magnificenza, da tanto splendore e da tanta cortesia e gentilezza, che a guisa di fiumi reali scorrean limpidi e maestosi dalla rocca vaticana a irrorar delle dolci acque Roma e il mondo, non potè non riforbirsi, e rammollir l’animo rigido e duro.
Noi non possiamo immaginare a’ dì nostri l’opulenza e la magnificenza di Roma a que’ giorni; la solennità delle feste; la maestà della corte Pontificale; il fasto e la pompa sfolgorata delle ambascerie de’ monarchi ; il decoro onorando dei principi della Chiesa. Allora ogni Cardinale ovvero era figliuolo di Re e gran Dinasti della cristianità, ovvero la Chiesa e le corone gareggiavano ad esaltarli, secondo la somma dignità del sacro Senato Apostolico; laonde ogni palazzo di Cardinale era una reggia, e avea guardie di lancieri a piè e a cavallo, e famiglia numerosa tutta vestita a un’assisa, e tanti cavalli quanti non ne han ora le reggie stalle del Papa con tutti i Cardinali che sono in Roma. Si legge, che il solo cardinale Ippolito d’Este, quando andò Legato in Francia avea seco più di quattrocento cavalli; e si narra come un miracolo di povertà e umiltà, che il ven. Cardinal Bellarmino non avesse nella sua casa che trenta famigliari. Ad ogni Oratore di Principi, che così allora diceansi per lo più gli Ambasciatori, i Cardinali della Corona, e molti altri signori e principi romani mandavano loro incontro a uno e due miglia da Roma i loro cavalli riccamente bardamentati, coi gentiluomini di camera, con una gran brigata di staffieri e palafrenieri vestiti a una taglia e colle divise del casato; il che faceva un corteo mirabilmente splendido e fastoso. Gli Oratori dei Principi tenean corte anch’essi, milizie, insegne, e aveano giurisdizione ne’ loro palagi e procinti nè più né meno come i monarchi nella loro reggia.
Ora pensate come il popolo romano alla vista di tanto grandezze, sontuosità ed eleganze dovea rigentilir l’animo, affinare i pensieri, illeggiadrire i suoi modi, render più dolci e soavi i suoi costumi. I poeti non rifinivano di esaltare le cortesie di Leone X; i pittori le dipingeano in mille guise, le stanze e le logge Vaticane le sfoggiavano sotto il pennello del Sanzio e de’ suoi scolari: s’aprian gallerie, s’edificavan palazzi, si ornavan templi, s’addirizzavano strade, si decoravan giardini e ville di statue e di fontane: Roma ogni di meglio divenia commendabile e bella. Nulla però di meno con tutto che la maniera e il tratto del popolo si ripulisse considerabilmente, non picciol resto di fierezza rimaneasi ancora in que’ sangui caldi e in que’ spiriti risentiti: e chi legge la vita di Benvenuto Cellini, e le cronache romane del secolo XVI, vi scorge ancora una grand’ orma dell’asperità e del rigore latino.
Nel secolo XVII colla gentilezza delle sue pompe; col lusso dei principi romani; colla dimora di Cristina Reina di Svezia in Roma; cogli sfarzi degli ambasciatori; colla molteplicità delle feste popolari; col lustro de’ nuovi edifizii sacri e profani; coll’abbondanza e la ricchezza che felicitavano la città eterna, la plebe romana spogliava ogni dì meglio gran parte dell’antico scoglio; ma tuttavia l’animo serbava fiero e caldo, che spesso non sapea rattenersi nelle sue foghe: laonde non di rado avveniano buglie sanguinose co’ masnadieri spagnuoli, francesi, portoghesi e tedeschi delle famiglie degli ambasciatori, ogni qual volta volessero, sotto l’ombra de’ loro padroni, commettere qualche soverchieria ne’ popolani.
La mollezza del secolo XVIII rarificò in Roma ma non ispense l’impeto subitano della romana fierezza. I Patrizii aveano ancora i lor bravi in palazzo, i quali quand’erano la festa un po’ caldi dal vino s’accapigliavano di frequente con altri bravi, o co’ popolani, che non voleano ceder d’un punto alle loro braverie. I Romani rispettavano cordialmente i loro Patrizii, e riveriano le loro assise; ma se un famiglio, perchè avea indosso la divisa d’un signore avesse voluto usare qualche mal tratto, era pagato di botto della sua insolenza, e il popolano trovava subito asilo entro la soglia d’un altro grande, che la corte Savella non s’ardia di violare.
Il popolo romano è adiroso e superbo, ma non è traditore; e in que’ tempi delle vendette e dell’assassinio un Romano non si saria mai compero a tanta viltà: chi avesse voluto far bastonare, ferire od uccidere il suo nemico, dovea ricorrere a qualche scellerato forestiere, che non averia mai trovato un popolano di Roma che declinasse a tanta codardia. Il Romano avrà morto il nimico anche a tradimento per ira, non mai a prezzo; o prima gli avrà detto: Guardati da me perch’io t’ammazzerò ad ogni conto. E ciò che il Romano per indole generosa faceva in antico, fallo altresì in presente.
Del 1849 un feroce repubblicano voleva scannare un frate sulla piazzetta del convento: accorse un gagliardo popolano con una mannaia e glielo strappò vivo dall’ ugne; ma in quell’arruffamento il popolano, posto il piè in fallo cadde, e toccò una ferita in petto: accorse popoli, e gli fu tratto di mano. Nel ritrarsi disse al sicario — Badati, perchè sai chi sono — Un anno dopo mentre a gran notte il popolano passava sotto la porta Settimiana s’accozza a caso col sicario: l’afferra in petto, e gli dice — Ah scannafrati, tu sei morto — e caccia il coltello di tasca. Colui si getta in ginocchio, e grida — Aspetta, che sono in peccato mortale. Abbi pietà de’ miei cinque figliuoli — Ed io n’ho otto, rispose il popolano, e tu m’uccidevi. Va, e ti confessa — E piantollo così in ginocchio. Di questi tratti generosi in Roma ne puoi contare parecchi, dacchè provengono dall’indole nobile della gente romana.
In sullo scorcio del 1700, mentre i colti cittadini coll’acutezza dell’ingegno e coll’arguzia de’ parlari dilettavansi grandemente in motti e frizzi e scede che appiccavano alla statua di Pasquino, onde fur dette Pasquinate, il popolo romano, che nuotava nel burro, facea vita e tempone, campando di buon mercato e sollazzandosi il più che potea. E avea ben di che. Imperocchè in Roma, prima della calata de’ Francesi in Italia, non si pagavano imposte prediali, né casatichi, nè testatichi; le gabelle eran poche e lievi; i Patrizii romani spendeano le loro ricchezze in opere d’arti, ed eran continuo in commetter faccenda agli artigiani ne’ ristauri e negli abbellimenti de’ loro palazzi, di lor ville e de’ lor giardini. Ogni gran casa aveva i suoi muratori, i suoi legnaiuoli, i suoi fabbri, i suoi maestri di cocchi, e d’ogni altra ragion mestieri, i quali di generazione in generazione erano al soldo del Barone, e non venia lor meno il lavoro; e quando invecchiavano avean pensioni; e quando erano infermi era loro pagato il letto nelle corsie de’ Fateben Fratelli; e quando allogavan le figliuole a marito avean le doti; e le vedove i sussidii; e gli orfani la tutela: sicché fatti adulti, e appreso il mestiere, entravano ne’ ruoli degli operai di famiglia.
Ciò che incontrava al popolo presso i Patrizii, intervenia presso le case religiose, le quali metteano in opera un gran numero di popolani pei bisogni delle chiese e de’ monisteri: cotalchè al popol di Roma non mancava mai pane. Aggiugni il buon vivere delle derrate ch’eran di picciol costo; l’abbondanza d’ogni cosa; la pace tranquilla e grassa all’ombra del Vaticano. Noi abbiamo quei tempi come cosa incredibile; come un aureo sogno; come cicalate di vecchi lodatori e magnificatoci degli anni andati: e la dee esser così oggimai per tutti quelli che nacquero in questo secolo tumultuoso e disgregato. Chi nacque dall’ottocento all’ottocenquattordici a’ suoi vagiti faceva eco il rimbombo de’ cannoni; e primi oggetti che gli si profferirono agli occhi furono sangue, stragi, arsioni e saccheggi di città, e turbamenti inestimabili.
I nati più tardi furono avvolti incessantemente nelle cospirazioni., negli ammutinamenti, nelle ribellioni, senza mai posa nè tregua; dacchè l’Italia fu ed è tuttavia campo aperto a tutte le sedizioni, a tutti i moti, a tutte le ire di chi le trama continuo addosso le rivolture che la soqquadrino da capo a fondo. In questa misera terra che — Apennin parte e il mar circonda e l’alpe —, egli non v’è angolo, per oscuro e rimoto e alpestro che sia, il quale non abbia veduto covarsi in seno, e poi scoppiare improvviso il fuoco di qualche congiura. Or com’è possibile agli uomini odierni il poter concepire una idea chiara e adeguata del tranquillo di pace, che godea l’Italia in que’di beati dell’ascensione al trono pontificale di Pio VI? A noi sembran favole di poeti.
Il popolo romano adunque da Benedetto XIV a Pio VI era di molto rincivilito; ma tuttavia non potea deporre in tutto la nativa fierezza: sanselo i repubblicani del 1797, e dapprima assaggiolla Ugo Basville. I suoi giochi saporiti eran giochi di sangue; e dilettavasi smisuratamente delle cacce de’ tori e de’ bufali, dello sparo degli archibugi, dello scoppio delle polveri, e delle tragedie.
Il sollazzo che allora più andasse all’animo de’ Romani si era la sassaiola, che quasi a ogni dì di festa avea luogo in Campo vaccino o a Cerchi, o sulla spianata del Celio alla Navicella. I monelli più sviati de’ Rioni de’ Monti e di’ Trastevere eran destrissimi nel fare a’ sassi, ed avean colpi sì ricisi e sicuri, che, fosse di fionda, o fosse di soprammano, dov’essi scagliavano un sasso incartavan nel segno: onde che ciascuno potea scrivere sopra il suo ciotto, come quel greco arciere sopra il suo dardo — All’occhio destro di Filippo — sicuro d’accecare il Macedone di quell’occhio. Si legge che le madri nell’isole Baleari, per addestrare i figliuoli a fiondeggiare, appendeano la merenda a un alto ramo d’albero, e sinchè non la colpiano del sasso, non poteano calarla e merendare. I monelli romani invece della merenda aveano a bersaglio o la faccia di donna Lucrezia, o di Marforio, o di qualche altra statua antica, e ciottolavanle da vicino e da lontano. Talora pigliavano a segno un cespo d’erba che penzolava dagli archi dell’acquedotto di Nerone e dell’acquedotto di Claudio, e picchia e dalli sinchè non aveanlo divelto co’ sassi: anche si provavano colla fionda d’imberciare i finestrini altissimi che son là nell’ultimo girone dell’ala del Colosseo, e imboccavanli e trapassavanli di netto, tant’era accertato il colpo: ond’egli è a pensare se costoro battagliando alle sassate colpiano diritto l’avversario.
Ora siccome e il mal vezzo dei figliuoli d’Adamo d’astiarsi fra le castella e i villaggi vicini l’un all’altro, cosi è altresì — Di quei che un muro ed una fossa serra —, massime nelle città ov’è piano e monte, o divisione di fiume e di torrente. Roma ha il Rione de’ Monti e il Rione di Trastevere: di che Trasteverini e Montigiani erano spesso in zuffa e veniano alle selciate quasi ogni festa a cento e dugento per parte. Divideansi in molte schiere, spediano innanzi i veliti e gli esploratori, aveano il grosso della battaglia, e l’antiguardo e il retroguardo: gli uni talora campeggiavano sull’Aventino e gli altri sul Palazio, e faceano a chi si diloggiava dal campo. Coloro che accampavano sul Palatino difficilmente poteano essere manomessi per l’arduità de’ luoghi: imperocchè si convenia arrampicarsi su pei muri che circondano gli arconi e le ruine del palazzo de’ Cesari e vincere dapprima gli accessi del Circo Massimo. I difensori, che aveano preso luogo sugli spianati delle alte sustruzioni che s’inarcano alle falde, impediano su da alto colle fionde gli approcci del nemico. Per non esser presi alle spalle s’asserragliavano da s. Bonaventura, e dalla parte del Monte Celio: metteano le scolte laggiù da s. Giorgio in Velabro; s’inerpicavano sulle vette del tempio di Apollo e della Biblioteca palatina per iscorgere di lontano gli assalitori. Altri cacciavansi in imboscata nei grottoni del secondo loggiato, altri nelle camerelle dei Gladiatori.
Se i Trasteverini occupavano il Palatino, i frombolieri de’ Monti scagliavan le pietre da s. Gregorio, dal Clivo di Scauro, dall’Arco di Costantino, o dai rialti delle adiacenze dell’Aventino, onde la battaglia poi faceasi serrata nel Circo Massimo, e talvolta ricacciavano i Montigiani sino alle Terme di Caracalla; ove, attestatisi e rafforzate le schiere s’avventavano sui Trasteverini, incalzandoli ne’ trinceramenti del Circo. Intanto i popolani adulti dell’una e dell’altra fazione animavano, accaloravano, rinvigorivano i loro garzoni, e spesso la zuffa cominciata co’ sassi de’ monelli terminava co’ ferimenti dei grandi. Adunque non v’era festa che non facesse piangere qualche madre, cui portavano a casa il figliuolo col capo rotto o coll’occhio divelto, e qualche moglie che vedeasi condurre il marito sforacchiato. Questa pessima costumanza fu tolta dal Cardinal Consalvi, il quale ogni festa mandava squadroni di cavalli a sbaragliare quelle raunate. E così fu cessata alla plebe romana un’occasione d’infierire e accostumare l’adolescenza ad essere battagliera e pronta di mano.
Niuno tuttavia rammorbidì e mansuefece l’animo de’ Romani siccome quel sapientissimo Papa Leone XII, il quale se avesse regnato qualche anno di più, conducea di certo a felice termine i nobili e sublimi divisamenti , che tutta la mente gli occupavano a’ vantaggi di Roma. Con ciò sia ch’egli per torre al popolo esca e sprone di fierezza vietò, come si è mentovato più innanzi, tutti i giochi di sangue, e quelle costumanze che poteano pericolare la gente. Dapprima si macellavano le bestie alle beccherie sparte nelle vie popolate della città, e non di rado avveniva, che fuggita una bufola o un torello feriti, imperversavano corneggiando e gittando a terra e spaurendo quelli che s’abbattano in quel contorno: dacchè in campagna di Roma il bestiame non è domestico, come altrove, ma foresto e indomito, a cagione ch’ei vive alla selva e alla fratta, come le salvaticbe fiere; e quando è condotto a città pel macello viene accompagnato da mandriani a cavallo, che a Roma si dicon Butteri, i quali hanno mazze e pungoli in mano; e se un pedone s’incontra a venire, il mandriano trascorre innanzi, e lo fa accostare al suo arcione sinchè la torma sia oltrepassata.
Avvi eziandio lungo le strade, onde passan le bestie, ricettacoli e rifugii di palancati, entro i quali ricoverano i viandanti. Quando i branchi entravano in Roma erano dinanzati da un bufalaro che sonava un campanaccio per avvisare a’ popoli che si ritirassero: e però Papa Leone per impedire e provvedere a tanti incomodi fece costrurre i macelli fuori di porta Flaminia; nè niuno potè più macellar bestia in Roma.
Tolti i ludi atroci e i macelli, vietò altresì la frequenza degli spari d’archibugio, che faceansi per le vie e per le piazze romane all’occasione delle nozze de’ popolani e delle feste più solenni della Chiesa, in cui erano frequentissime le disgrazie e le paure. In fra le altre costumanze pericolose era quella degli spari del Sabbato santo allo scioglimento delle campane; perocchè mentre le donne al primo tocco del campanone di s. Pietro davano per la prima volta i piedi ai loro bambini in fasce, i quali così sciolti guizzavano le gambucce per aria, i loro uomini sparavano gagliardemente dalle finestre carabine, schioppi, trombonacci, pistole e terzette con un rimbombo che assordava le campane. I fanciulli poi correano di casa in casa per tutto ilvicinato a domandare le pentole rotte, intronate e sfesse, ch’essi poi allogavano in lunga schiera ne’ trivi: poneanvi sotto un mucchiello di polvere da cannone, e fatta la seminella, e poste le micce, al primo suono delle campane appiccavanvi il fuoco, e godeano veder saltare per aria le pentole, a guisa di granate e di bombe, e scagliare i cocci da lunge: il che sovente era cagione d’accecare e svisare più d’uno, che colà intorno, o dalle finestre mirava lo spettacolo di quella gazzarra.
Ma non bastò a Leone XII levare di mezzo gli impedimenti a mitigare e addolcire l’ingegno del popolo romano; ch’egli pensò alla radice, riordinando con sapientissime istituzioni le parrocchie di Roma, il quale riordinamento ben presto diede e dà tuttavia maravigliosi frutti di pietà e civiltà nella plebe romana. I parrochi accrebbero la loro autorità sul popolo, e gli s’accostarono così intimamente, che divennero, oltre che i maestri, eziandio i padri e tutori del gregge loro commesso, e segnatamente dei fanciulli e delle giovinette, ch’essi hanno continuo in mano pe’ catechismi, per le istruzioni della prima Comunione e della Cresima , per le doti delle zitelle; pei matrimoni, e per gli aiuti che porgon loro ad esser partecipi della pubblica beneficenza della Chiesa Romana.
A questi attivi e vigorosi argomenti di civiltà cristiana aggiunsero la viva scintilla, cui gran fiamma seconda, delle scuole notturne, alle quali i fattorini d’ogni arte e mestiere s’accolgono ogni sera, e vi ricevono Le sante istruzioni della dottrina cattolica, l’esercizio dell’orazione, la scuola di leggere, scrivere e conteggiare, i primi avviamenti del disegno per gli intagliatori, doratori, scarpellini e gessai. Tutte coteste mandre di garzoncelli, che chiusa bottega, ivano discoleggiando per le vie di Roma, lerci, scapigliati, ignoranti e tangheri, omai da più di trent’anni sono dai zelanti sacerdoti delle parrocchie allevati a mitezza, a gentilezza e pietà con sollecitudine e affezione più che paterna.
Le feste, che scorreano sviati e tracotanti pe’ trivi, alle porte della città, ne’ luoghi più remoti a viziarsi nel gioco, nelle dissolutezze, e nell’ usare colle brigate de’ beoni, de’ ladroncelli, de’ bestemmiatori e rissanti; oggi in quella vece sono guidati in bella schiera dai maestri delle scuole notturne a innocenti sollazzi, addestrandosi alla corsa, al salto, a giochi di maestria e di forza, crescendo leggiadri, snelli, destri e ad ogni bella e pudica usanza ben costumati.
La sera si riducono di nuovo alla scuola, assistono a un breve sermone, fanno la disputa del Catechismo, odono la lettura di qualche viterella di Santo, e tornati a casa nelle lunghe nottolate d’inverno ripetono ai padri, alle madri, alle sorelle quant’ hanno udito e appreso. Egli non è a dire come i ruvidi padri, che molti son carrettieri, conciatori, tintori, fabbri e manovali de’ più grossi mestieri, rimangono strabiliati a udire i loro figliuoletti d’undici e dodici anni ragionare di cose che non aveano mai udito mentovare, e vederli col libro in mano, e sentir leggere i Comandamenti della legge di Dio, i Misteri di nostra santa Fede, i Sacramenti della Chiesa e le vite de’ Santi.
I parrochi inoltre promossero le scuole pie per le fanciulle, e molti Ordini religiosi di donne furono a questo intendimento chiamati da Papa Leone, poscia da Gregorio XVI e più che mai a’ nostri giorni dal Santo Padre Pio IX. La pia e dolce educazione delle fanciulle concorse mirabilmente ad ammolcire e ingentilire nel seno delle famiglie il cuore e i modi della plebe romana; di guisa che, dopo trent’ anni di studio e d’opera incessante, le due surte generazioni spogliarono in gran parte la rigidezza delle consuetudini antiche.
Avvi di quelli che assegnano sì gran mutamento alla civiltà universale che si va traforando ne’ popoli più ritrosi a scapito della purità della fede e dell’integrità de’ costumi: noi non vorremmo in tutto negarlo, massime negli ordini più colti de’ cittadini; ma rispetto al popolo la mitezza è germinata dall’industria e dalla cultura de’ Parrochi e del Clero Romano, ed è frutto prezioso del ministero sacerdotale animato e promosso dalle istituzioni di Leone XII. Noi che prima dell’Anno Santo assistevamo in Ottobre allo spedale della Consolazione, ove si portano a medicare i feriti, siamo testimoni oculari del costante raddolcimento dell’antica fierezza romana, ch’era così pronta all’ira e così subita alla vendetta. Fra la domenica e il lunedì capitavano i sei, i sette e gli otto feriti nelle risse al Testaccio, e un giorno fùronne portati sino a ventuno: ora in tutta la stagione delle ottobrate non giungono a quelli d’una festa sola di trent’ anni fa. Alle buglie degli avvinazzati s’aggiungeano i ferimenti de’ rivali in amore, le gare del trapassarsi in carrozza, le tenzoni de’ giochi, le gelosie de’ mariti, le scommesse alle giostre de’ tori e alle corse de’ barberi.
Il venire alle coltella era sì usato in Roma, che quasi ogni giorno intervenia qualche ferimento, ond’è ancor celebre, e corre per le bocche del popolo la novella d’ una vecchia matrona romana, la quale qualche anno fa alzandosi di buon mattino, all’ora che gli staffieri s’adunavano sotto il portico interno del palazzo, faceasi alla finestra in cuffia di notte, dicendo — Eh giovinotti quanti n’ han por tato stanotte alla Consolazione? E rispondendo i fanti — Nessuno, Eccellenza — la dama rientrava il capo borbottando e dicendo — Eh li Romani non adoperano più virilmente! Eh li Romani si son fatti femminelle da conocchia! Eh li Romani non son più quelli de’ miei tempi! — Se cotesta matrona avesse sovrastato a vivere ancora qualche anno, vedrebbe che davvero il popolo romano non è più quello di trent’anni addietro, ma serbando intero il suo animo pio, nobile e generoso, l’ha vestito e ornato della mitezza e gentilezza de’ più colti popoli d’Italia.
LE NOTTI ESTIVE DI ROMA
Oh oh di’ un po’ costì, ch’hai tu fatto del nostro Edmondo? ov’è egli ito a rimbucarsi? ove s’è egli dileguato? Parti egli di poterti far gioco de’ tuoi lettori sì francamente? Ci intitoli un libro del suo nome, e poi che è che non è? lo getti nel dimenticatoio, e ci pianti lì in secco a tuo bello e grande agio come non fosse il tuo dovere d’attenerci le promesse. E bada, sai ? che tu ci facesti un giochetto sino dai primi capitoli, mettendo sempre in campo don Alessandro, che parla e parla senza fare mai nè punto né virgola, lasciando soltanto al povero Edmondo le orecchie da udire e la pazienza da masticare. Nè basta, se tu nol ci creavi in tutto, per tua gentilezza, anche matto; non diremo soltanto da catene, ma da gogna; chè il fatto suo è una compassione a vederlo far cose tali e dare in istravaganze sì sperticate, e in ghiribizzi cosi fuori del naturale, che tu ci hai preso a uccellare per isciocchi.
Ma riduciamla a’ fatti. In somma Edmondo s’è egli poi fatto cattolico? E quel tuo sempiterno don Alessandro è egli venuto oggimai a capo di bene ammaestrarlo e rannerbarlo nella Fede verace, che sola ha virtù di condurre l’anime a salute? Su, bravo, escine una volta: to’, eccoti la ciambella.
Lettori miei gentilissimi, cotesta vostra ciambella non è condita col mele, ma coll’assenzio, e sa più d’ostico ed agro che non credete: imperocchè gli è vero che ho lasciato in camera Edmondo per alcun tempo; ma se ponete ben mente io v’intrattenni poi sempre De’ costumi del popolo romano, ch’è il mio tema principale, e quell’Edmondo v’è apposto per dare un nome proprio alla trattazione più che altro. Tuttavia egli v’ebbe tanto che dire e tanto che fare, che voi vi richiamate di me per avervelo fatto dir cose da tralunato, e operare stranezze iperbolicissime; quasi che eziandio chi si reputa savio non cada talvolta in iperboli più sformate, avvegnachè meno solenni, di quelle di Edmondo!
Egli è anche vero, nè io il vi vo’ negare, che don Alessandro tien quasi sempre il pulpito; ma noi gli pur dobbiamo di molti chiarimenti intorno a certe costumanze romane che ci erano oscure: laonde abbiatelo pel vostro Cicerone, o per la vostra Guida di Roma, nè, come cortese ch’egli è sempre co’ forestieri, vi domanderà la mancia. Voi però m’incalzate, e mi rovesciate in capo quell’insomma Edmondo s’è poi egli fatto cattolico? ch’io, per paura di qualche nuova stretta, vi rispondo riciso: Sì, si gli è cattolico; e buono: e dice davvero; e se v’abbatteste in lui nol conoscereste più, tanto è ammodato, né ha più quel viso d’astrologo e quegli occhi spaventati in fronte che sentiano un po’ dello strano.
Ma ecco là quel giovinotto che m’accenna; e quell’avvocato che viene alla volta mia; e quella giovinetta che stuzzica col gomito suo fratello; e quel buon pievano, che mi guarda da un pezzo, e col viso alto, e col mento in fuori, e colle labbra già in atto di domandare.
Non accade tanta izza: ho capito: tutti vorreste interrogarmi intorno ai particolari di cotesta bella conversione d’Edmondo, n’è vero? dò io nel segno? v’ho io còlto per aria? Veniamo a patti. Io v’appagherò; ma vorrei anco un piacere da voi, e confido nella gentilezza vostra. Vorrei prima di tornare a Edmondo avere un po’ di conversazione con don Alessandro; il quale m’invitò a bere un caffè con esso lui, nè vorrei essergli poi si scortese da non vi andare. Mentre si ciantella e si va sorseggiando, io tra un ciantellino e l’altro, tra una soffiatina e un’altra ho in animo d’interrogarlo di qualche altra costumanza romana, per indi potervela poi recitare. Già, m’attendo da lui le sfilita lamentazioni di Geremia: che ora il popolo romano si va snaturando: che da vent’ anni in qua oh quanto mutatus ab illo; e poi que’ sospironi Oh tempora! oh mores! poichè s’egli non v’annesta un po’ di latino, gli pare che il periodo non corra. Dice che parecchie di quelle usanze, ch’ io sto narrando, appena che ora appaiano (e anco di rado) in Trastevere, a’ Monti, in Borgo s. Pietro, dove po chi anni ha le eran comuni e universali.
— Tanto meglio, gli dico io, tanto meglio, don Alessandro, perocchè facendone un po’ di nota, indi a cinquant’anni si dirà — Oh vedi qual erasi Roma! — Chi godrà che quegli usi sieno smessi, e chi ne farà sorger altri più acconci alla stagione che corre — Ma cotesto, come vedete, è un punto da toccarsi dilicatamente, e come suol dirsi colle mollette, perchè don Alessandro vi si cruccia, vi s’arrovella ed esce de’ gangheri, apponendo le cagioni di cotesti mutamenti a una civiltà licenziosa, la quale diveglie e sbarbica il vecchio , perchè intende a rifare un nuovo che più non odori di cristiano: essendo suo dogma, che un popolo, cui siano tolte le sue tradizioni, non è più quello, ma un altro popolo artifiziale che si può foggiare a talento dagli astuti e togliergli colle vecchie istituzioni la vecchia fede. Eh si sa: questi vecchi veggono pericolar sempre la fede: e se volete non hanno il torto. Perocchè trenta, quarant’ anni addietro la fede scemava negli ordini maggiori, e specialmente nelle genti di studio, appunto per le letture de’ libri irreligiosi; dove a’ dì nostri la rea semente s’è gittata nel campo popolare, e v’attecchisce e barba e cresce e si dilata a gran passi, e massime nelle plebi cittadine.
Or dunque a don Alessandro. Ieri fui a visitarlo, e vi prometto che mi diede un caffè alla veneziana, che me ne sento ancora il sapore in bocca. Prima, ciò s’ intende, ho dovuto sorbirmi un ciotolone d’oimè, di poveretti noi, di Dio ci aiuti, di ah che mondaccio, e altrettali borbottamenti e fiotti uscitigli de’ polmoni, che in latino e che in volgare; ma intanto io n’ho buscato di molte buone novelle da impinguare i miei quaderni. In fra le altre mi disse, che ai sollazzi della state, in che si trastullavano i Romani, egli è da aggiungervi la Gatta Cieca di piazza del popolo, e la Luna d’agosto nel Colosseo coi Fochetti del teatro Correa.
All’entrare in Roma per la porta Flaminia s’apre allo sguardo maravigliato del forestiere una piazza degna in vero dell’antica metropoli del più vasto Impero del mondo, del centro della Religione e del magistero delle arti belle. Con ciò sia che s’aggira quel vasto campo in due grandi emicicli; che hanno per centro lo stupendo obelisco d’Eliopoli, condotto nel circo Massimo da Cesare Augusto, e ritto sopra un alto piedistallo, ai piè del quale quattro lioni egiziani, coricati maestosamente sopra quattro basi a scaglioni, gittano dalla bocca a larghissimi sprazzi quattro fontane che s’accolgono in altrettanti pili a maniera di pelaghetti. A mano manca le sorge il monte Pincio colle sue dolci erte spalleggiate d’alberi annosi, coronate di statue antiche, di trofei, di colonne rostrate, e terminate in quella portentosa ringhiera, sotto la quale si stende maestevole e sovrana l’augusta Roma col Tevere che l’attraversa e colle sue cupole che si spiccano verso il cielo.
La piazza sbocca in tre lunghissime e dirittissime strade, attestate da due magnifici templi e adorne di sontuosi palazzi; la mediana delle quali conduce l’occhio dirittamente a battere nella rocca del Campidoglio, che sovrasta alla basilica d’Araceli, e mira sublime da quell’altezza le memorande ruine dell’antica Roma, e le grandezze della novella. Il semicerchio di rimpetto al Pincio è coronato di pini, di passi e d’abeti , che coi densi rami si consertano e ombreggiano la statua di Nettuno che fra due tritoni signoreggia la marmorea fontana dell’ acqua Vergine, la quale per la sua tazza a conchiglia, riversa dai labbri accanalati le sue dolci e pure acque a gronde lucenti, e mira di fronte l’altra fontana, su cui posa armata d’elmo e di lancia la statua di Roma fra il Tevere e l’Aniene.
Ora in cotesta nobilissima delle piazze i Romani passeggian frequenti per condursi al Pincio, a villa Borghese, al palazzo di Papa Giulio, e a ponte Molle; ivi hanno capo le corse de’ barberi il carnovale, e le grandi adunanze del popolo a goder gli spettacoli della Girandola, che da qualche anno invece di farsi alla mole Adriana, si rappresenta sullo spianato del Pincio. Ma le notti delle domeniche estive, quelli che furono a diletto sul Pincio, scendono in piazza; e a quel grato asolare d’un’auretta che vi spira giù dai monti Parioli, s’ intrattengono a crocchio, vi mangiano il cocomero e l’insalata, o si riconducono a bere o a cenare lì presso nel giardinetto vicino a s. Giacomo, il quale è tutto illuminato pe’ viottoli, pe’ boschetti, e per li spiazzi, di palloncini a vaghi colori pendenti dagli arboscelli a guisa d’aranci dorati, di melagrani vermigli, di cedri verdognoli, e d’ortensie cilestrine, col più vago vedere che occhio possa gustare.
Quello è proprio il giardino delle Fate, e par sorto per incantesimo: imperocchè ivi tutto è fantastico e bizzarro con un misto d’ombra e di luce, con fughe di viali selvosi, con recessi di cappannucce pastorali e pescherecce, con piazzette ad anfiteatro intorno a cui, d’albero in albero, s’ intrecciano e ricascano festoni e nappe, e serti scintillanti e variopinti di palloncini a mille tinte: sott’essi son poste le tavolette coperte di tovaglioli bianchissime, e rinverdite di foglie, sulle quali brillano i bicchieri e le bottiglie di cristallo, e vi seggono attorno le liete brigate a cenare la lattughetta colla vitella mongana.
Mentre adunque i buongustai si raccolgono a’ piè del Pincio, e nel giardinetto di s. Giacomo a mangiare, bere e godersi l’armonia de’ ribecchini e de’ flauti, nella piazza del Popolo, quando risplende la luna, i popolani s’intrattengono a un loro gioco che li trastulla mirabilmente in sin presso la mezza notte. Il gioco si è quello che i Toscani dicono fare a Mosca cieca e i Romani a Gatta cieca, e sta nel bendare gli occhi a uno ed avviarlo a un luogo assegnato: se vi perviene, vince la posta; se no, egli ne ha il danno e le beffe. Per ordinario si suol porre il premio sotto una pignatta, si benda il giocatore, gli si pone una mazza in mano, gli si fanno dare alcuni giri, e s’avvia; e se s’abbatte a picchiare e rompere il pignatto, vince fra le acclamazioni della brigata. Ma siccome chi non vede lume, raro è mai che dia nel brocco, e spesso avviene che cammini a rovescio; così gli astanti ne traggono cagione delle più grasse risa. Spettacolo che danno sovente al mondo gli uomini, che pur si reputan veggenti, e menan colpi e tentennate da ciechi, avvisando di coglier nel segno, e colpeggiano il vento, o danno di cozzo col capo in una cantonata, onde ne van poi col naso rotto, con qualche dente meno in bocca, o colla fronte a bozze.
In sulla piazza del Popolo in luogo di porre il premio sotto la pila, si depone in mano d’alcuni presidenti scelti dalla brigata, i quali in fine lo danno al vincitore; e se niuno azzecca a vincere, quei denari si beono alla prima osteria. Il gioco è cotesto. Sotto l’obelisco si bendano gli occhi ad alcuni giovinotti, i quali così al buio deono, partendo dall’obelisco, imboccare la via del Corso. Chi l’imbocca la vince. Pensate! In quel campo spazioso non han dato dieci passi, che già chi torce a levante, chi a ponente e chi a tramontana, avvisandosi però ciascuno di proceder diritto al Corso.
Già la luna, o colma o quasi nel suo pieno, s’alza maestosa sopra il monte di Quirino, e manda torrenti di luce sui sette colli, sul campo Marzio e sui prati di Nerone: l’ombra dell’obelisco gitta una lunga macchia sulla piazza, la quale si perde entro la selva del Nettuno, e tutto il gran giro resta luminoso d’una luce d’argento. I monelli, per meglio vedere la Gatta cieca, saltano sugli scaglioni delle quattro fontane, e molti si mettono a tre e quattro insieme a cavallo de’ lioni, mentre i più arditi s’inerpicano sul gran piedestallo, e seggono sulle cornici. La piazza da basso formicola d’ogni gente, che s’accalca fra le due tazze delle fontane verso la via di Ripetta e dei due Macelli, per veder bendare i giocatori, e assistere alla mossa.
Ivi sono raccolti i più arditi garzoni de’ Monti, e di Trastevere, dell’Oca e di Borgo, e fanno a gara, e si vantano d’imboccare di certo la via del Corso. Assai di loro hanno in sulla piazza, fra i cerchi delle donne la fidanzata, e nell’atto che si bendano dai Presidenti, a ciascuna batte il cuore fra la speranza della vittoria del suo amante, e il timor delle pubbliche risa se sgarra — Liberata, gridano le comari da un lato, abbi per sicuro che Renzo tuo vince la prova — e da un altro crocchio le fanciulle del vicinato fanno animo alla Nazzarena pronosticandole la vittoria del suo Marcellino. I giovinotti frattanto gridan fra loro — Ne vada un buon fiasco d’Orvieto che vince Nanni di Borgo Pio — None, none, io ti do pegno l’un contro dieci che vincerà Coriolano di piazza Barberina — Bè, fuori, ecco, cinque paoli a un grosso: vi garba? Iodico, che l’imbrocca là quel giovanottone dal berretto rosso; anche anno andò sino alle colonne de’ Miracoli: e fu a un dito d’infilare il Corso, ma quest’anno v’entrerà di colta.
Infrattanto i giocatori sono bendati, e si dà loro i tre giri; il Presidente accenna colla mano, e fermi: al primo comando di partire, ognuno manda innanzi le braccia, e s’avvia. Oh ch’è egli a vedere sei e otto ciechi movere di conserva, e tendere a un luogo determinato ch’essi non veggono! A pochi passi sono già disgregati, e ognuno va diritto per immaginazione, formandosi in capo l’idea del termine e dello spazio, al quale sovente è molto da lungi. I più scaltri non potendo giovarsi dell’occhio, giovansi dell’orecchio, ascoltando le voci, e giudicando essere degli astanti che lor fanno ala verso il Corso. Tutt’altro: son genti che chiotti chiotti seguono il cieco per vedere ove para.
L’uno va e va, e senza avvedersene volge di verso il Pincio, e quando s’avvisa d’esser proprio al Corso, batte il muso nel cancellone della salita. Si strappa subito la benda, e tralunato e attonito si guarda attorno per riconoscere il luogo, e non si rinviene, siccome colui che reputavasi tutto altrove. Quell’altro a sei passi aveva già fatto una mezza girata, e continuandosi, l’amante sua, cui passava vicino, gli dice all’orecchio — a sinistra — il cieco, incaponito d’essere a filo verso il Corso, procede franco, e s’avvia diritto verso la fontana del Nettuno; e che è che non è? entra col capo sotto le gronde, e n’ha un risciacquo che gli scorre giù pel collo e pel petto. Le grida, gli urli, i fischi sono un visibiglio. Il cattivello si sbenda, si scrolla, si trova sotto la conchiglia versante, e mormora fra sè: Accidenti alla fontana!
Un terzo si spinge innanzi a tentoni: i monelli lo inseguono: uno gli tira il gherone del farsetto; un altro in punta di piedi gli va dietro, e con una pagliuzza gli fa il solletico nell’orecchio, ed ei spranga pugni al vento, perocchè i traforelli gli guizzan sotto, e dangli un pizzicotto nella polpa della gamba, o gli vanno innanzi a ritroso a braccia aperte come per accoglierselo in grembo. Che volete? Un altro, che nei tre giri trovossi appunto essere colle spalle al Corso e col viso verso l’obelisco, va di portante a investire negli scaglioni della base, e casca sotto uno de’ quattro leoni, mentre uno de’ monellacci che vi siede a cavallo mette la mano al pispino che schizza l’acqua, gliela volge addosso, e lo spruzza dì buona ragione, al suono della baia, che gli danno tutti gli altri.
Ma siccome ogni legge ha chi trovi l’arte di frodarla, così tre giovani ordinaron fra loro di vincere il gioco, e di partirsi il guadagno: laonde uno dei tre si offerse alla bendatura; un altro si mise tra la piazza e il Corso; il terzo collocossi all’entrata della via. Dato il segno della mossa, quello di mezzo uscì in un fischio quasi per chiamare qualcuno: quello ch’era sull’imboccatura del Corso rispose con un altro fischio; di maniera che il cieco che stava in orecchi serviasi de’ fischi come della bussola da navigare; e se deviava alquanto, ed ecco un altro fischio che rimettealo in cammino. Come fu pervenuto fra il pronao del tempio di s. Maria di Monte Santo e il pronao di s. Maria de’Miracoli; che sono come due magnifici atrii della via del Corso, i due fischiatori si dileguaron fra i popoli, e quello della Gatta cieca rasentando le colonne de’ Miracoli, imboccò fra i plausi universali la strada, e ottenne dai giudici il premio. Appresso il gioco la gente fa di molti crocchi, e narrando le molteplici avventure de’ ciechi, e ridendo delle più strane, a mano a mano si scioglie e riducesi ognuno in pace a dormire.
Prima che ci dilunghiamo da cotesti contorni della piazza del popolo dobbiamo di notte entrare nel teatro Corea, il quale s’ aggira nel gran cerchio interno del Mausoleo d’ Augusto. Ivi dentro nelle dolci e limpide notti della state i Romani s’accolgono allo spettacolo, ch’essi chiamano dei Fochetti, e son giochi notturni di luminarie a disegno operate colla polvere d’artiglieria acconcia con polveri di zolfo a varii colori. Sin tanto che cominci la rappresentazione, le brigate de’ Romani passeggiano lungo la bella riva arborata, che dal palazzo delle Arti si stende sin presso alla piazza dell’Oca di fianco alla porta Flaminia: altri seggono sugli scaglioni e sulla cordonata del porto di Ripetta a godere la frescura che scende per val di Tevere coll’auretta notturna: non pochi traghettano il fiume sulla barca, e spargonsi pei prati di Nerone, e raccolgonsi nelle osterie camperecce a cenare l’indivia coll’arrosto; sinchè scoccata l’ora dei fuochi, ciascuno si riduce al teatro Corea. Ivi, quasi a preludio, si mandano razzi altissimi, i quali scoppiando ricascano in una pioggia di stelle o di globetti scintillanti di vaghi colori: costà schizzan fontane vermiglie, colà s’accerchiano rapidissimi girelloni a sprazzi rossi, verdi e gialli: li bombano con iscoppi fragorosi i petardi, o saltano le cavallette ardenti.
Intanto la gran macchina è presta: si rappresenta l’incendio di Troia, che i Romani non si saziano mai di ricordare, siccome surti dal seme troiano scampato a quelle fiamme. Nella parte del girone, che nel Mausoleo d’ Augusto accoglie il proscenio, si lievano con bell’ordine d’ architettura la rocca d’llione,il tempio di Minerva e il palazzo di Priamo, i quali sono incastellati per guisa, che per tutto ove s’abbracciano e s’incatenano le travi a disegno di porte, di finestre, di cornici e di colonne, vi corron per tutto i cannoncelli delle polveri artificiate, cui dato fuoco in un attimo, figurano una città luminosa, che scintilla in tutte le sue forme, e in tutte le sue decorazioni con maravigliose apparenze. Indi si veggono dai larghi fianchi e dalle profonde caverne del gran cavallo, tirato a foga di popolo presso l’atrio di Pallade, sbucare i greci guerrieri, e colle faci in mano correr le vie solitarie di Troia sepolta nel sonno, e appiccare il fuoco alle case, alle curie, ai templi e agli abituri. Dapprima si veggono qui e colà rosseggiar le fiamme entro i vani delle finestre, indi investir vorticose i tetti, e sovrastarli fra i densi nuvoli di fumo, e il guizzare de’ lampi, e il bombar del vento che disfoga dagli aperti varchi.
Il popolo romano a quell’orrendo spettacolo sta intento e muto, sinchè allo scrosciar de’ tetti, al ruinar de’ palchi, al crepitar delle fiamme vede l’interno della Rocca ardere come la bocca d’un vulcano, i lunghi portici dirompere sotto le colonne arrovesciate, il gran tempio di Minerva fendersi in due e vomitar fuoco dalle tribune, dai nicchioni e dalle celle più interne. Ma quando mira l’arsione della reggia di Priamo, e tra le onde di fuoco scorge i talami delle reali spose ruinar fragorosi gli uni sugli altri; e le ampie sale, e le lunghe fughe delle camere dorate, e i più intimi recessi esser divorati dal fuoco, e l’urto, e il conflitto delle muraglie che si sgretolano e fiaccano e s’ ammucchiano e s’accatastano in roventi macerie, il popolo alza un grido gemebondo, e parte dall’anfiteatro coll’animo stretto e affollato, che prima d’uscire si volge a rivedere le ultime faville della combusta Troia.
Altre volte rappresentano l’incendio di Sagunto e la disperata difesa di quei cittadini: altre le fiamme, onde Nerone distrusse e consumò la città di Roma; e veggonsi andare a fuoco i palagi, i fori, i teatri e i templi del Monte Celio, dell’Aventino, delle Esquilie, del Viminale e del colle di Quirino, mentre quel mostro dal sommo di una torre trimpella la cetra al suono dei gemiti e delle strida del popolo esterrefatto e fuggente. Altre affigurano l’arsione del Campidoglio nella dura lotta fra Vespasiano e Vitellio, nella quale arsione si scorge tutto intero dapprima il tempio di Giove Capitolino col suo pronao quadripartito, e col maestoso portico di marmo pentelico, che tutto il correva d’intorno: indi il Tabulario che sorgeva nella valletta, e per ultimo la Rocca Tarpea. I Romani godono inestimabilmente di quegli antichi edifizii che formavano la gloria loro, ed esultano a rivederli rizzati di nuovo giusta le descrizioni di Dionigi d’Alicarnasso: il prestigio poi dei fuochi d’artifizio, che ne disegnano i luminosi contorni, è tale, che il popolo al primo vederli accendere esce in un tripudio di voci, di mani e di piedi che fa echeggiare tutto il teatro Corea. Ma le glorie di quaggiù sono come i fuochi fatui, che appaiono e dispaiono in un baleno. Dopo il vago fulgore del tempio di Giove Capitolino e della Rocca Tarpea che brillano a sì variopinti chiarori, eccoti i Vitelliani scagliare i tizzoni accesi nei tetti e nelle finestre, e il fuoco appigliarsi, e correre rapidissimo, e avvolgersi di densissimo fumo, fra i globi del quale odonsi gli scoppii, i tuoni i rimbombi degli archi e de’ cornicioni cadenti, e lo scuotersi delle colonne, e in quelle scommozioni scavezzarsi, calcinare e crollar frante sotto i marmorei architravi che dirupano e scoscendono rovinosamente.
In queste rappresentazioni di fuochi i Romani sono meravigliosi e non hanno chi li possa agguagliare: tanto sanno figurar naturali le finte apparenze di quegli incendimenti, e san così a tempo e misura dar loro la fiamma, e con essa gli effetti dello struggere prima appoco appoco; indi l’investir concitato, e l’apprendersi largamente, e ardere e carbonare le travi, i palchi e i solai, e le partite, che diroccando ogni cosa, sembra di trovarsi testè al tutto presenti a un vero incendio di templi e d’ intere città. Ora poi che, per s. Pietro e per Pasqua, fanno i fuochi d’artifizio sullo spianato, e sul clivo del Monte Pincio, in quell’amplissimo spazio, foggiano, rizzano, illuminano edifizii grandissimi, che attraggono a vederli e stupirli tutta Roma colle molte migliaia di forestieri convenuti da tutti i regni d’ Europa all’augusto spettacolo delle sacre funzioni pontificali.
Il popolo romano ha nella state un altro intertenimento singolare a Roma, e forse unico al mondo , Egli non occorre per lo più che nelle serate d’ agosto a luna colma, la quale per la serenità e purezza dell’aria suol apparire più grande ed esser più limpida nel cielo cristallino che signoreggia i sette colli. Quand’essa è più alta e rutilante, i Romani si conducono a brigate nell’anfiteatro Flavio, detto il Colosseo, ed ivi girando l’occhio ne’ varii punti di quel gran cerchio godono i meravigliosi effetti delle ombre e delle luci che formano da sè un nobile e sublime ricreamento a vedere.
L’anfiteatro anticamente correva intorno in una grande elittica, che formava da basso l’arena aggirata dal podio, sul quale s’accerchiavano i gradi crescenti a mano a mano che montavano in alto, intantochè l’ultimo scaglione era quasi doppiamente più vasto del primo. Cotesti scaglioni non erano tramezzati che dai vomitorii, i quali eran bocche onde uscivano i cittadini sui gradi a veder gli spettacoli de’ gladiatori o delle bestie feroci. Allorchè adunque l’anfiteatro era intero, la luna entrandovi co’ suoi raggi non facea vedere all’occhio se non una gran coppa mezzo illuminata e mezzo buia, senz’ altra interruzione che l’ombra dei vomitorii: ma nello stato ruinoso in ch’è al presente la scena ha tante varietà e differenze, quanti sono gli sfasciumi di quell’immenso edifizio. Da un lato vedi tutti gli scaglioni caduti, e con essi gli archi e le volte che li reggeano; e in mezzo a quelle ruine costolature di muraglie ritte in piè, o quasi divelte e cadenti con mezze arcate reggentisi in aria. Indi ruine e scamiciature di pietre, e tronchi di muro scassinati e curvi in atto di dar la volta e precipitare; e cornici e modanature e petroni scommessi, e sovra certi mozziconi di pilastri, campati e puntellati in alto solitari e barcollanti: qui e là sprofondi e voragini, e fianchi dissoluti e scoscesi, e monti di ruinaglie muscose e rugginenti.
Dalla banda di levante l’anfiteatro è men disossato e fiaccato che altrove; e avvegnachè non vi si vegga ordine di gradi e di sboccatoi, tuttavia si veggono ancora le volte reali che ne sosteneano i gironi; e si scorgono dietro a quelle i vecchi ambulacri e le scale che metteano ai vomitorii, e i massicci pilieri inarcati a grossi macigni, sui quali folceansi gli immani fianchi esteriori dell’anfiteatro: giù a basso apronsi ancora nel podio le cave de’ lioni, delle tigri e de’ leopardi, donde sbucavano sitibondi di sangue e di strage nell’arena a lottare coi gladiatori, o a dilaniare le membra innocenti de’ martiri di Gesù Cristo. Ora queste immense ruine che di giorno ti presentano le membra dislogate di quell’enorme gigante, e ne ammiri la forza e la grandezza, e ne piangi lo sfacimento e ne riverisci la polvere ed i frantumi; queste ruine di notte al raggio della luna ti porgono una scena che ti sublima l’anima sovra sè stessa. I Romani scelgono il punto, in cui la luna s’ alza fra Monte Porzio e Frascati, e fiede diritto il mezzo cerchio ch’è dal lato dell’arco trionfale di Costantino; nè indi si partono che non la veggano battere in pieno sul fianco di verso il Laterano. Immagini il lettore contrasti di luce e d’ombre che deono operarsi là dentro! I rigiri e i torcimenti di que’ risalti e di quelli sfondi fanno sì che i raggi investano con isprazzi di lume vivo, risentito e crudo tutti i massi sporgenti, e smaltino d’una luce d’argento gli altissimi rocchi di muro, gli archi, le bugne, le cornici e i modiglioni, che rilevano intorno alle curve parte isolati, parte in ischiera e parte in masse irregolari e buttate alla ventura.
Indi coteste luci ardite e taglienti morir di tratto in una notte profonda che s’incaverna in quei grottoni, in que’ covi e in quegli anfratti caliginosi e cupi, ove l’occhio s’ innabissa pauroso. Qui vedi una punta lucente , e dietro a quella cercare il raggio ove posarsi, nè trovando alcuno sporto, s’affonda a mano a mano fra le membrature meno divelte, e le tocca e le lambisce con chiarori sfumati che si perdono nell’ombra e muoiono nella notte. Colà ti guizza una leccatura di lume fuggente , costà si spicca a un tratto un bagliore che ti dipinge il contorno d’un arco, il risalto d’un architrave, l’incastellamento d’una galleria. Quelle dense e grandi ombre che contrastano colle tinte argentine, e si mescolano e si confondono nelle ritirate e ne’ rilievi, e rientrano e risalgono, e s’affrontano e frangono insieme fra i fusti, i rottami e le altissime ossature di quel portentoso edificio, formano prospetti e fughe e scorci e distese d’una maraviglia stupenda.
I Romani in cotesti loro diporti sono d’un gusto delicato e squisito; e siccome immaginosi, creansi in quelle incerte apparenze nuovi edifizi di palagi, di templi, di propilei d’ archi trionfali e di quanto sa vagheggiare un occhio e un ingegno avvezzi al bello ed al grande. Nè Roma è scarsa di questi spettacoli: chè altri vanno a godere gli effetti della luna nelle superbe ruine del Palatino dalla parte che guarda il Circo Massimo, ed è ornata di tanti archi gli uni sovra gli altri, di tanti avanzi di ambulacri, di logge, di essedre, di nicchioni e di sale: altri si conduce fra le maestose reliquie delle terme di Caracalla, o delle terme di Tito, o degli acquedotti del Celio verso l’arco di Dolabella: scene svariatissime e piene dei più singolari prestigi d’ombre e di luci, di sfumature, di sbattimenti, d’abissi e di chiarezze improvvise e portentose a vedere.
Ma i giochi delle luci e delle ombre in quelle maestose e solitarie reliquie dell’antica grandezza romana sono addoppiati dalla fantasia e dalle illusioni de’ raggi della luna. Nel Colosseo segnatamente quei fusti di muro ritti in piè hanno talora l’apparenza di giganti schierati con usberghi e scudi ed elmi rilucenti; e l’ellera, che gli incappella, penzigliando e agitandosi alla brezza notturna , forma le sembianze dei cimieri.
Ch’alto sull’elmo orribilmente ondeggiano.
Là un pilone caduto sembra un gladiatore ferito che appoggiato sul dosso della mano manda l’ultimo respiro; quivi un cornicione mezzo sepolto fra le macerie apparisce una lionessa in atto di scagliarsi sopra una tigre: quel masso fra la luce e l’ombra accenna un elefante, e intornovi molti molossi che gli s’avventano agli orecchi, e ch’egli colla proboscide flagella e avventa per l’aria: un altro si crea sul pulvinare o loggia imperiale la presenza d’un Cesare incoronato d’alloro, che sta immobilmente riguardando le lotte del cesto e del pugilato: questi fra l’ombria d’un androne crede vedere l’Imperator Commodo assalito dai congiurati. Ognuno si fìnge in quella gran cerchia di diroccamenti confusi fra le ombre e fra le luci quelle im magini che più gli attalenta di dipingersi nella mente. I forestieri poi che si dilettano di quelle scene notturne animano il Colosseo, le Terme e i ruderi del Palatino coi fantasmi degli antichi eroi dell’Ossian, e delle saghe islandiche, vagolanti fra gli sfondi di quelle sontuose ruine, ed escono da quei prospetti coll’animo estatico e sopraffatto.
L’ABIURA
Don Alessandro non era uomo da lasciarsi fuggire le occasioni, che se gli paravano innanzi per far il bene: imperocchè veduto che Edmondo era stato colpito da un lampo della grazia, conobbe ch’egli non si dovea perder punto di tempo, e lasciargli divertire la mente da quel buon pensiero. Don Alessandro avea stretta conoscenza con una gentildonna naturale del paese d’Edmondo, la quale alcuni anni addietro era venuta dal protestantesimo alla Chiesa cattolica, donna di gran mente, spiritosa, amante in sommo delle arti belle, addottrinata nelle controversie de’ protestanti, e con questo nobile, doviziosa e di grate e gentili maniere. Pensò il buon prete ch’essa fosse tutto al caso per Edmondo, uomo di quell’ottime parti che vedemmo, ma d’ingegno alquanto diverso e risentito. Perchè ito a visitarla, e parlatole dell’uomo e delle sue condizioni, l’ebbe presta ad ogni suo desiderio.
Don Alessandro il dì appresso uscito del coro andò difilato all’amico e lo trovò appunto in assetto d’uscire — Oh che buon vento? esclamò Edmondo; siate il ben venuto le mille volte; non m’ avete mai onorato così mattutino, e vi son tenutissimo di sì bella visita, che mi presagisce una giornata avventurosa.
— Do’; siete anche voi di que’ superstiziosi che si recano ogni cosa ad augurio, e badano se uscendo dell’uscio posero innanzi il piè ritto od il manco; se s’intoppano in un cane o in un gatto; se veggono prima una donna o un prete, e vi almanaccano sopra e vi fan glosse e commenti con pronostici da giocatori del lotto?
— Da banda le ugge e le iettature de’ Napolitani : egli s’ ha a far colezione insieme: Doralice, la casiera, ha sempre a quest’ora l’acqua bollente, ed io darò mano a una scatola di thè; ma proprio della Cina, che mi fu donato da un Ammiraglio inglese venutoci da Hon-kong, e non ebbe la prima bollitura — Così detto, sonò il campanello, venne la Doralice, portò coll’acqua bollente il burro, le fettuccine di pane abbrostite, due belle spume da intingere e un va setto di latte.
Mentre distendeano il burro sul pane e cospergeanlo di sale Don Alessandro disse: Amico, verso il mezzogiorno vo glio condurvi ad ammirare un Leonardo da Vinci che non vedeste mai il più stupendo.
— Un Leonardo! eh Don Alessandro, de’ Leonardi ne va pochi pel mondo; e a udire cotesti quadrai, ognuno ve ne mostra da dieci in su.
— Costì non v’è dubbio; dacchè tutta l’Accademia di s. Luca l’ebbe per tale; e quanti lo veggono e conoscono la maniera gagliarda e dilicata del Vinci, vi dice — Questo è un Leonardo — e non isgarra! Una signora paesana vo stra, passando per un vicoletto, vide tra ferravecchi e di molta ciarpa una tela in una corniciaccia disgessata e rognosa, e la dipintura appena vi si vedea, tant’era polverosa e affumicata. Parea una Sacra Famiglia; e la gentildonna ch’è d’occhio finissimo e d’ottimo gusto, vi scòrse un non so che, che indussela a comperarlo: e l’ebbe dal rigattiere per un’inezia.
Chiamò uno de’ più valenti ristauratori di quadri, il quale con sue acque cominciato a lavarlo, come vide uscirne la testa della Madonna s’intese correre un sudoretto per la vita e un tremoretto per l’ossa così improvviso, che gli so spese l’alito in seno. Credea di travedere, e s’allontanava, e s’accostava, e volgeala a una luce e poi a un’altra, e non sapea rivenire al sentimento. Allora dà della spugna sulla testa del Bambino, e giù e giù — O Leonardo, o Tiziano, esclama, di qui non s’esce — Onde come il maestro l’ebbe fornito di lavare e di dargli i veli delle sue gomme, chiamò i primi dipintori della scuola romana, i quali entrando, diceano: Oh il bel Leonardo! La gentildonna allora cercò per bel modo di trovare onde il rigattiere avuto l’avesse; e seppe che l’erede d’un’antica famiglia spenta da qualche anno, volendo riabbellire il palazzo cadutogli in retaggio, vendette per isgombero un ammasso di vecchiumi accatastati ne’ soppalchi del tetto, e fra questi era il detto quadro, che ora in una ricca e bella cornice adorna la ca mera di rispetto della Dama. Voi siete sì buongustaio che dovete aver caro di vederlo.
— Se l’ho caro? pensate voi: egli mi tarda di bearmene gli occhi.
Così ragionato alquanto, e beuto il thè, si misero in via, e furono alla gentildonna, la quale accolteli benignamente e gli ebbe introdotti nella stanza del quadro, ch’era in effetto bellissimo e degno di quel sommo maestro della scuola Lombarda. Ivi seduti vennero in molti ragionamenti intorno a coteste belle venture de’ quadri vecchi, e in particolare de’ due ritratti di Raffaello trovati in Firenze sur un granaio pochi anni sono, e del famoso ritratto di Papa Giulio, della galleria Durazzo, che lavandolo, trovossi appunto essere o di mano di Raffaello, o di Sebastiano dal Piombo. Ma Don Alessandro, cui premeva il cuore la conversione d’ Edmondo, volto dolcemente il discorso, domandò la gentildonna qual cagione mossa l’avesse a rendersi cattolica ; ed ella, che null’altro attendeva di meglio, cominciò a magnificare le divine misericordie, e a descrivere a sì vivi colori e con sì commoventi parole il contento dell’anima sua, ch’Edmondo la guardava senza batter palpebra.
E notate, soggiunse, volta a don Alessandro, ch’io ebbi il primo impulso da ciò che più spaventa e rimove noi protestanti dal ritornare in seno della Chiesa romana, ch’è appunto la Confessione. Io aveva di molte amiche cattoliche in Roma; e non poche, avvegnachè belle, nobili e ricche, eran piene di travagli lunghi e cocenti, come suol avvenire a chi vive in cotesto mondaccio tristo. Vedevo che alcune dai conforti delle amiche non ricevean refrigerio; poichè il cuore ha sovente delle pene secrete, che altri non conosce che chi le prova; e molte non si possono comunicare neanco cogli intrinsechi, o comunicate, non si intendono, o intese, non si ha per esse che uno sterile: vi compatisco. Ora io vedea non di rado, che il giorno, in cui s’erano confessate, sentiansi più liete; vedeasi loro in viso una serenità tutta nuova, una pace, un riposo invidiabile. Dunque, conchiusi, la Confessione de’ cattolici, ben lungi da esser quell’ergastolo che noi riputiamo, dee pur contenere un balsamo ignoto che sana e molce le ferite del cuore.
Indi meglio considerando la cosa in sè medesima, dissi fra me: La Concessione dei peccati secreti non potea esser indotta negli uomini che da un Dio. Qual umano sapiente l’avrebbe mai pensata, o pensandola, avrebbe potuto imporla? L’uomo che chiuso nel suo cuore è impenetrabile, non avrebbe mai potuto esser persuaso da un altr’uomo d’aprirgli il cuore suo per essere giudicato e assoluto da lui con poche parole, ch’ei recita, non come uomo, ma come Dio. Ciò non potea cadere in mente a niun uomo del mondo senza esser tenuto pazzo od empio da spegnersi col fuoco. Non per tanto l’accolsero tante nazioni, e fra esse, non il solo popoletto ignorante, ma uomini sapientissimi e potentissimi come imperatori e re, legislatori e guerrieri. I Papi stessi, che sono i Vicarii di Cristo e hanno l’autorità delle chiavi, s’inginocchiano umilmente al semplice prete e aprongli candidamente gli arcani più riposti dell’anima.
D’altra parte mi parea che soltanto una misericordia divina potea trovare un mezzo sì facile di cancellare i peccati che offendono la divina giustizia, volendo che la ferita della superbia si sanasse col farmaco dell’umiltà: se l’umile confessione dell’offesa suol placare anche fra gli uomini generosi l’animo irato dell’offeso, quanto più Iddio ch’è la generosità per essenza? Ma ciò che, oltre l’intelletto, mi vinse il cuore si fu il conoscere che la stessa Confessione è un vero bisogno di questo povero cuore. Egli ha questo dalla natura, che ogni pena gli è un peso; e più la pena è secreta e profonda, e più gli pesa addosso e lo torce e lo angoscia, finchè non trova il modo di esalare il suo affanno in un cuore amico. Io assomigliava il rimorso della coscienza al verme solitario, che ange e travaglia lo stomaco, sinchè lo stomaco non giugne a recerlo. Io vedeva, essendo fanciulla, che quando avea qualche affannuccio secreto, me lo andava covando un pezzo, e poi egli m’era pure gioco forza d’aprirlo alla cameriera, e apertolo, me ne sentiva alleggerita. Dio, fattore dell’animo umano, occorse a cotesto prepotente bisogno della nostra natura, e Cristo innalzandolo alla divina sorgente della sua Grazia, costituillo il più valido mezzo della nostra salute. Da queste considerazioni, aiutate dalla divina bontà, ho inferito, che la Confessione non dovea rimovermi dall’impulso che sentiva in me di farmi cattolica: per converso mi vi spingeva gagliardamente pensando ai poveri protestanti, i quali non hanno cotesto immenso soccorso del cuore oppresso dal cociore secreto della coscienza rimorsa dalla memoria dei falli commessi: e più d’ogn’ altro momento immaginavo quello della morte, quando l’uomo sente così al vivo il bisogno d’intendere da parte di Dio quella gran parola: Io ti perdono.
Edmondo a mano a mano che la gentildonna incalzava il ragionamento, mutava colore: quando s’affocava, quando impallidiva: quando si torcea sulla sedia, quando agitava un piede rapidissimamente. Alla fine disse: Ebbene, Baronessa, la prima confessione che faceste al prete cattolico v’avrà fatto sudare.
— Vi dirò, cavaliere: in principio gli è certo che la natura sentiva un certo ribrezzo; ma non sì tosto ho cominciato ad aprire al ministro di Dio le mie miserie, mi sentia cadere un peso dal petto, l’alito usciva più franco, sinchè mi sentii tanto leggera che mi parea di rinascere, e terminai col piangere d’ un’ allegrezza sì pura, si dolce ch’io non aveva mai provato in vita mia; nè vi saprei esprimere a parole, perchè bisogna gustarla per intenderla. Qui calza più che mai quel detto divino: Gustate e vedete quant’ è soave il Signore.
Allora don Alessandro quasi per celia disse alla Baronessa: Voi siete cacciatrice valente in vero, e non tirate a colpire lepri e conigli, ma i leoni generosi e robusti.
— Perdonate, io non saprei a che accenniate se non uscite di metafora: io parlo ciò che sento, e vorrei spiegare adequatamente tutta la consolazione che provai allorchè, prima di fare l’abiura, m’ebbi a confessare da quel benigno sacerdote che mi accolse e m’intese con tanta pazienza e carità.
— Ma voi non sapete. Baronessa, che qui il Cavaliere è ancor protestante, e lotta forte con sè medesimo.
Allora la gentildonna ricompostasi entrò in lunghi ed efficaci ragionamenti , dai quali Edmondo ebbe di gran lume e colse infinito godimento. Perchè pregato la Baro nessa che si fosse compiaciuta di riceverlo a nuovi colloquii, ed ottenutone grazioso assenso , fu più volte a vederla; ed oltre alle dolci persuasioni e conforti a parole, ricevette da lei alcuni libri, la lettura dei quali l’ebbe convinto e persuaso sì appieno, ch’egli non avea più alcun dubbio che gli rannuvolasse la mente.
Come Don Alessandro il vide stabilito nel proponimento di venire alla verace Chiesa di Cristo, acciocchè l’animo vivendo nel mezzo delle distrazioni mondane non si spargesse e dissipasse di soverchio, gli diè l’ottimo consiglio di ritirarsi alcuni giorni col pio sacerdote indicatogli dalla Baronessa per ammaestratore nei punti del vivere secondo le pratiche della Chiesa Cattolica. E acciocchè quel po’ di solitudine non inducesselo in qualche noia o malinconia, che potrebbe tornargli pericolosa, gli ebbe posto innanzi il Convento de’ Cappuccini d’Albano.
La casa de’ Cappuccini fu edificata in vetta alla costa del monte che da levante risponde sul lago d’Alba, e da ponente domina il vasto piano del Lazio insino al mare. Dietro il convento distendesi uno spianato, in capo al quale è un terrazzo sporgente che offre alla vista il cerchio del lago, le sue rive profonde vestite da un lato di viti e dall’altro da una cupa selva d’antichissimi cerri: là in capo del verde cratere sorge e si specchia nelle azzurre acque Castel Gandolfo; qui da banda sopra l’alta ripa biancheggia Palazzuola ov’era un dì la città d’Ascanio e la madre di Roma, e sovr’ esso innalza le ardue cime il monte di Giove Laziale, ove i Romani vincitori per la via trionfale saliano ad offerirgli nel tempio le opime spoglie delle vinte nazioni.
Di fianco al Convento sale un foltissimo bosco di elci, il quale adombra la pendice del monte insino alla estrema cima; fra quei solitarii recessi, e sotto quei densi rami, che si consertano incontro al sole, ogni cosa tace d’intorno; nè quel silenzio reverendo è mai turbato, se non dai soavi gorgheggi dell’usignuolo, o dal gemito delle amorose tortorelle. Entro quella fitta foresta s’aprono lunghi sentieri che con dolce erta costeggiano il dosso del monte e mettono a divoti tempietti, ne’ quali è rappresentato in istatua s. Francesco quando fra gli scogli dell’Alvernia riceve le sacrosante Stimmate, o predica agli uccelli che lo intorniano ad ascoltarle, o patteggia col lupo d’Agubio che non offenda i terrazzani, o la placida morte di quel Serafino d’amore nella chiesa della Porziuncula.
Ivi adunque fu conchiuso ch’Edmondo sarebbesi alquanto sequestrato dagli amici per attendere all’orazione, a vie meglio disporsi a quel grande atto, dal quale dipendeva la sua eterna felicità. La sera innanzi la sua partenza, tornando egli tutto solo e in pensieri da un lungo colloquio avuto col sacerdote che l’ammaestrava intorno ai Sacramenti, come fu giunto verso l’Oratorio notturno del Caravita udì uscire di là un canto lugubre; nè sapendo a quell’ora tarda che potesse essere, v’entrò curiosamente, e trovossi in un grande atrio illuminato appena da una lampanetta a vetri appannati , che non lasciava raffigurare i sembianti l’uno dell’altro. Tutto lungo le pareti vide parecchi confessionali, e intorno a quelli di molta gente che’ attendea la sua volta per confessarsi. Gli parea scernere a quel barlume certi omaccioni barbuti, certi giovinotti azzimati, certi poveri operai, i quali dopo aver faticato tutto il giorno cercavano il riposo dello spirito nella confessione.
Da quivi entrò nell’Oratorio ch’era grande assai ma con fiochissimo lume anch’esso, e dentrovi uomini inginocchiati in terra a spazio, a spazio, che cantavano il Miserere. Quell’incerto lume, quelle voci tarde profonde, quegli uomini a ginocchi e quasi prostrati, gli spiravano un santo orrore misto a una secreta dolcezza che non avea mai provata nel cuore. Poco poi vede là in cima verso l’altare avanzarsi lentamente un sacerdote involto in un gran mantello nero, il quale voltosi dai gradini, uscì in queste poche parole: Fratelli miei, nostro Signor Gesù Cristo disse colla divina sua bocca: se non farete penitenza perirete. Noi abbiamo peccato, egli è ben giusto che diamo a Dio qualche poco di soddisfazione in questa vita per non dover poi pagare sino all’ultimo quadrante nell’altra — Mentre il sacerdote dicea questo, Edmondo vide alcuni Confratelli con bianche e lunghe facciuole cadenti sul petto, i quali distribuivano un non so che agli inginocchiati: il sacerdote tacque; si spense quell’unico lumicino; rimase un buio e un silenzio mortale. Ed ecco tutto ad un tratto uno scroscio e un rinterzare di colpi che grandinavano tempestosamente coll’impeto e col frastuono della bufera. Edmondo senti raggricciarsegli indosso la pelle, e stette come uno adombrato; ma in pochi minuti finì quel tambusso, riapparve il lumicino, ed egli uscì di là sbigottito, e passò la notte in gran turbamento.
La mattina per tempissimo salì in carrozza, e pervenuto in Albano, continuò per la galleria del lago coperta dalle grandi ombre di quegli alberi secolari, e giunse a piè del Convento. Ivi dai padri Cappuccini, che ospitali e cortesissimi sono, fu accolto a somma gentilezza e condotto al suo quartierino che riusciva colle finestre sull’ameno prospetto del lago. Edmondo non sapeva saziarsi di quella vista maravigliosa, e respirava a larghe boccate quell’aria pura e leggera che gli confortava l’intimo seno e gli addoppiava la vita. Tutto lo dilettava; la limpidezza dell’acque, la serenità del cielo, la verzura de’ campi, l’amenità de’ giardini, gli avanzi maestosi della villa di Domiziano, e più basso quelli della villa di Pompeo.
Se non che dopo alcun tempo rifattosi nell’interno della sua cameretta, e cominciato a leggere le dotte controversie di Mìlner, per quella mutabilità dell’animo umano, cadde in una cupa malinconia che gli si addensava nel cuore, e riempialo di nubilosi pensieri. La disciplina notturna nell’Oratorio del Caravita gli avea sopraffatto l’immaginazione per sì forte guisa, ch’egli udiasi ogni momento nell’orecchio quel recitar lento e rauco del Miserere; vedeasi dinanzi agli occhi quel buio improvviso; sentiasi ognora d’intorno il fischio, il rombo, il fracasso di que’ flagelli, e ne spiritava come se gli scrosciassero sulle spalle. Credea che i cattolici avessero dei misteri tenebrosi, delle pratiche crudeli, dei riti pagani; e gli si rinnovellavano in petto le antiche ugge dell’idolatria delle sacre immagini, della superstizione dei digiuni, e di mille altri inganni ond’era stato imbevuto dalla puerizia contro la Chiesa Romana.
In fra queste nere cogitazioni rizzossi; ed essendo molto affannato, scese a un po’ d’ esercizio nel giardino, ove ricreatosi alquanto alla vista de’ fiori, misesi poscia per lo bosco de’ cerri, ed ivi stava contemplandone l’altezza, e i grossi tronchi scabrosi, e i lunghi rami, e l’immenso spazio che ombreggiavano intorno; perchè, passo innanzi passo, procedendo per que’ tortuosi andirivieni, trovossi in uno spiazzeito di minuta erbicina vestito, in capo al quale era una edicola con entrovi la statua di s. Francesco rapito in estasi; e lì fuori dirimpetto, a pie d’un’elce, un capitello corintio della villa di Domiziano, sul quale era seduto e pregava un vecchio religioso coperto del suo cappuccio, col mento vestito di bianchissima barba, e appoggiato sulla gruccia del suo bastone.
Questo vegliardo era d’occhi allegri, d’amabile sembiante e, benchè avesse il viso increspato di minutissime grinze, gli fioria nondimeno una serenità in fronte ch’era specchio dell’anima dentro tutta piena di Dio. Edmondo soffermossi alquanto, addolcito a quella vista, e salutato con riverenza il buon vecchio, sentì rispondersi con una voce argentina e vigorosa: Dio vi benedica, figliuol mio. Quelle parole furono un balsamo per Edmondo; e postegli a sedere vicino sopra un ceppo d’albero, il venne interrogando di varie cose intorno alle pratiche della Chiesa, alle quali il santo veglio rispose con sì persuasive ragioni che l’appagavano appieno.
Non per tanto avea sempre in cuore la spina del Caravita, e gli chiese di quella pazza usanza di flagellarsi le spalle — Non dite così, ripigliò il vecchio; pazzo è chi si reputa savio della saviezza del mondo, la quale è in tutto contraria ai divini intendimenti. L’uomo carnale ripugna al patire, perocchè ha posto il suo bene ne’ piaceri mondani, e s’egli non vi fosse altra vita, che pur questa, egli fa rebbe saviamente davvero a cavarsi i suoi gusti; e chi amasse di tribolarsi sarebbe pazzo da catena. Ma questa vita presente, figliuol mio, non è che un passaggio all’eterna; e il Figliuolo di Dio mostrocci coll’esempio che non si può pervenire alla immortale felicità se non per lo scabro sentiero della penitenza.
— Ma ora, Padre mio reverendo, s’è provato che la civiltà presente sa giugnere alla più alta perfezione per vie più piacevoli, e lascia cotesti ruvidi e aspri tormenti della carne a quegli orsacchioni di Santi del medio evo.
— Lasciate dire coteste minchionerie a Vincenzo Gioberti, il quale compatisce l’ignoranza di s. Luigi Gonzaga, che si disciplinava colle lasse de’ suoi cani, e si pungeva i fianchi colle rotelle degli sproni de’ suoi cavalieri: anzi il Gioberti arrebbegli insegnato di salire in cielo mangiando delicato, dormendo soffice, vestendo fino, guardando attento gli oggetti più lusinghieri e seducenti. Se cotesta è la ve race via del Paradiso, saprasselo adesso egli medesimo, ch’è morto: ma io per me mi tengo alla via che indicommi il Salvatore, dicendo: Che chi non combatte sè stesso, e non toglie in ispalla la sua croce non è degno di me. E appunto per attenermi al consiglio di Cristo ho lasciato da giovincello gli agi della casa paterna, ch’è nobilissima e ricca; ho vestita cotesta tonica grossolana; ho cinto cotesta fune; vo scalzo, dormo duro, m’alzo a mezzanotte, e mangio fave e baccalà, e bevo annacquato. Il che parendomi ancor poco, domandai e ottenni le missioni del Congo, ove sotto que’ soli ardenti dell’Africa vissi oltre a vent’anni evangelizzando que’ poveri negri. Nell’attraversare quegli aridi e infocati deserti ho patito fame, sete, sonno, stanchezze e pericoli d’ogni sorte; sempre in procinto d’essere dilaniato dai leoni, divorato dalle iene, ravviluppato e strozzato dai serpenti boa, che mi fischiavano intorno alla capanna. E con tutto ciò mi vergogno di me medesimo s’io mi riscontro cogli Apostoli e coi Martiri di Dio. Se la civiltà odierna avesse un altro Cristo che le promettesse la vita eterna per via di delizie, puh! potrebbe godersele; ma Christus heri et hodie, figliuol Dio! E Cristo non muta il suo Vangelo per gratificarsi i sapienti del mondo.
— Ma dunque, ripigliò Edmondo con calore, s’ha egli a picchiarsi le spalle per salvar l’anima? Io sono protestante, e già in via di rendermi cattolico: pur vi confesso, che cotesta tregenda mi fa gran paura.
— Non vi perturbate, nè vi alterate di ciò, chè potrete salvarvi eziandio senza flagellarvi le spalle; ma non però senza patire. Egli v’ha di molte sorti discipline, figliuol mio, e più dure delle scudisciate e de’ pungiglioni: il tutto sta nell’offerire a Dio le nostre pene, le nostre gravezze d’animo e di corpo; le offese degli avversari, le detrazioni, gli odii, le invidie le calunnie degli emoli: le malattie, le stanchezze; i disagi e le altre noie della vita; baciando sempre la divina e paterna mano che ci percuote, e benedicendo e magnificando la sua santissima volontà in tutto. Poi voi altri signori avete un altro mezzo molto più efficace talora che quattro picchiate di sferza, ed è l’elemosina che redime i peccati quando è fatta per amore di Cristo, che riceve conforto ne’ suoi poveri da voi tolti alle loro necessità.
Edmondo ricevette tanta consolazione dalle parole di quel santo vegliardo, che ogni giorno il venia visitando nel bosco, e intrattenessi con lui lungamente, ritraendone altissimi documenti di cristiana pietà; laonde venuto da Roma il sacerdote che ammaestrato l’aveva nel catechismo, il trovò così animato ne’ santi propositi, ch’egli non credette di dover indugiare più oltre di farlo ammettere nel grembo della Chiesa. Villeggiava per bella sorte in que’ giorni il Sommo Pontefice a Castel Gandolfo; perchè il pio sacerdote pregò uno dei Prelati del Papa, paesano d’Edmondo di voler accogliere la sua abiura: ne fu assegnato il giorno, e scritto a don Alessandro, a Carlo pittore e ad Alfredo, acciocchè fossero partecipi anch’essi di tanto gaudio del loro amico.
Intanto un dì che la Ceccherella di Trastevere attraversava con un mazzo di matassine d’ordito il ponte Sisto, s’abbattè, proprio allo svolto di via Giulia, nella Nina di piazza di Spagna. Ognuno conosce la Ceccherella, quella sgriccioletta dalla lingua parlantina che averia cinguettato sott’acqua. Al vedere l’amica gittossi indietro due ricciolini che le cadean per la faccia, e corsale incontro, gridò che la si udiva sino al palazzo Farnese: O Nina mia bella; sai? La Nunziatina si sposa. Eh! bisogna nascere sotto quella stella per essere fortunata. Io ci ho piacere ve’: io non dico …. ma …. Uh che cose s’ha da vedere! Nozze da imperatrice, Nina mia. La Lungaretta le vede di rado. Neanco la pizzicheruola , neanco la merciaia; e sì ce n’è della roba in quelle case: pur se vedesti che letto coi pomi dorati, che specchio a cornice d’intaglio; che sedie, che cassettoni a lucido e a intarsio; che biancheria fine, che frangette, che trine! in somma cose da contessa a dirittura. Un abito di seta verdepomo cangiante con certi falpalà (non ti dico celia) larghi un palmo. Non ti parlo poi dei pendenti, delle anella, della collana, e insino a un braccialetto d’oro col cammeo: sissignora, col cammeo. Tà rà là là là. Uff!
La Nina còlto quel canterello per aria, l’interruppe, dicendo; Ceccherella, tu mi narri cose che mi deliziano; poich’io ci vo’ bene a quella cara Nunziata, ch’ell’è la grazia del mondo, e per buona e gentil fanciulla l’è dessa. Ma come trovò ella cosi a un tratto da farsi cosi ricco corredo? Ha ella vinto al lotto?
— E che lotto ! Un lotto che le cascò in grembo senza ch’ella avesse consultato la cabala, nè sognato il terno, né fatte le croci colla lingua sulla Scala Santa, nè digiunato i tredici martedì di sant’Antonio. Un terno di dugento scudi sonanti, Nina mia, e per giunta un’entrata di cinquanta scudi l’anno sulla Cassa di Risparmio per secola seculoro. Ti pare? E io poveretta sempre in cenci; e quel mio disgraziato di Toto chi sa quanto gli toccherà aspettare prima di sposarmi? S’io avessi un accidente di letto mi parrebbe d’essere già sposa; poichè pel rimanente tanto e tanto si strappa: ma un letto?
— Di’ un po’ soggiunse la Nina; oh mastro Simone è egli divenuto sì denaroso a un tratto? Mi dicesti pure che anch’egli era povero in canna, e non sapea dove si battere il capo per raggruzzolare quel po’ di baiocchi per allestire la Nunziatina.
— Gli è vero; ma che vuoi? Eccoti un bel giorno un Mansionario di s. Pietro si presenta a mastro Simone, e avutolo in disparte, gli snocciola dugento scudi in tante gregorine d’oro sonanti, e dicegli: che una persona pia, conoscendo la sua Nunziatina per una giovane dabbene e modesta, le manda per l’acconcio di sposo quella bagattella: e v’aggiugneva per dote il frutto d’un capitaletto sul banco di Risparmio che sarebbe d’un cinquanta scudi l’anno, ma si vorrebbe che il matrimonio si facesse al più presto.
— E come lo sai tu? Alle volte si spacciano delle baie che isfumano al vento.
— Sollo, perchè la madre di Nunziatina lo narrò in credenza a mia madre; e più volte ne tenni parola colla Nunziatina io stessa, ed ella confermò la cosa dicendo che la crede opera di qualche generosa gentildonna di quelle che visitano lo spedale di s. Giovanni.
— Eh povera innocente! costi non è cosa di donne. Ti sovviene, Geccherella, di quella merenda nell’orto di Piscinula, e di quel signore che vennevi con mio padre, e che tu sghignazzasti perchè somigliava a non so qual ranocchiaro?
— Ma gliel feci dietro le spalle: oh non m’ha inteso di certo.
— Ebbene, sappi che quel signore è ricchissimo, d’ottimo cuore, ed è rimasto preso della modestia e dello spirito di Nunzialina. So io quel che dico … ma . . . iss, Ceccherella mia! io ci metterei questa mano, che il benefattore secreto non è che lui, tanto più ch’egli è amicissimo di don Alessandro Mansionario di s. Pietro, e sono carne e ugna fra loro.
Fatto questo po’ di comaratico insieme, le due fanciulle si divisero e la Ceccherella, ita alle sue faccende, non fu tornata a casa appena, che posto giù le matassine corse difilato alla Nunziatina, e le schiccherò tutto il racconto della Nina, festeggiandola, ballonzolandole intorno e scoppiettando le dita, e gridando: Sie, sie, gli è quel Paino dell’orto che t’ha fatto del bene. Gli vo’ chiedere anch’io un tettuccio, anche senza i pomi dorati: uh poveretta a me! volevo dirlo alla Nina, e l’ho sdimenticato; ma come la incontro. . . Eh di cotesti buoni signori ne passeggian pochi per le selci di Trastevere.
La Nunziatina aveva veduto don Alessandro quando fu alla casa di lei per chiedere di mastro Simone suo padre; ma essa non avea fatto che introdurlo, e non aveva risposto che ad alcune sue domande: nondimeno le parole della Ceccherella aveanle aperto un po’ di via nella mente, e risovvennele che nell’orto, quando cercavano quel signore per invitarlo, la Nina le avea detto ch’egli era sì umano e generoso co’ poveretti, e aiutavali volentieri. Poi diceva a sé stessa: ma che merito ho io mai da meritarmi tanta beneficenza? Quel signore non mi conosce, nè da quel giorno innanzi l’ho più veduto: di certo la Madonna gli dee aver tocco il cuore, ed io, Madonna mia cara, ve ne ringrazio, e vi supplico di spandere le vostre benedizioni sopra il mio benefattore.
In questo mezzo le pubblicazioni eransi fatte nella parrocchia della Luce dal padre Curato, e la Nunziatina riceveva i congratulamenti del vicinato, e il suo Cencio avea già messo su un po’ di casa, e faceala vedere agli amici, i quali stupiano di sì bello e ricco mobile. Avea in tutto quattro stanze, una delle quali v’era per cucinetta, un’altra per salottino, una terza più grande era la camera nuziale, e nella quarta fu rizzato il telaio della Nunziatina, perché avea due finestre luminose, che rispondeano sull’orto de’ suoi vicini, e il sol di levante la rallegrava.
Il dì delle nozze mastro Simone osservò tutti i riti di Trastevere, sia nell’andata degli sposi alla chiesa, sia nel ritorno; il sacristano ch’ebbe una buona mancia, sonava le campane con un brio che facea sguizzare tutte le fibre alle fanciulle della Lungaretta, del Drago e di Bonosa. Al desinare fu invitato il Parroco, il Rettore della Confraternita, i parenti, le paraninfe della sposa; nè in sulla fine vi mancò il ribechino ed il flauto, che poi la notte fecero la serenata agli sposi. I primi otto giorni la sposa, secondo l’ usanza del popol di Roma, non esce di casa, e abbigliata da nozze riceve le amiche e i parenti, mostrando loro i doni, e onorandoli a suo potere: la domenica appresso poi il marito conduce la sposa in carrozza o a Frascati o ad Albano, e vi passano la giornata godendo in pace le delizie della campagna.
Nella chiesetta dei Cappuccini d’Albano faceasi un’altra festa di somma esultanza alla Chiesa militante e di sublimissimo gaudio alla Chiesa trionfante ne’ cieli. Edmondo di gran mattino avea ricevuto il battesimo privatamente sub conditione, e fece poscia la sua abiura all’altar maggiore nelle mani del Prelato. Nell’atto appunto ch’Edmondo s’era inginocchiato per leggere la forma della professione di fede, entrano in chiesa Cencio e la Nunziatina, che giunti ad Albano erano saliti a vedere il lago, e prima a venerare il santissimo Sacramento. La Nunziatina, veduto quel gruppo di signori, conobbe Edmondo, il quale tutto compreso di divozione leggeva con enfasi il suo atto di Fede: e perché il Prelato stava rivolto al popolo, essa credette ch’Edmondo si facesse frate, e vi recitasse i suoi voti; ma quando poi vide don Alessandro che piangeva di consolazione e tutti gli altri commossi, ella stessa non potè rattenere il pianto.
Cencio le disse: che hai? Ed ella risposegli sottovoce: non vedi, Cencio mio? Quegli è il nostro benefattore; eccoti là quel Mansionario che venne da patrimo a recargli quelle gregorine, che fecero affrettare il nostro matrimonio: stiamo qui, Cencio, sinch’egli abbia finito. E in effetto, fatta l’abiura, uscì il Prelato colla Messa, alla quale Edmondo era per fare la sua prima Comunione, e poscia per ricevere da un Vescovo il Sacramento della confermazione.
Don Alessandro voltosi per caso verso la chiesa, ove a quell’ora era pochissima gente, vide e conobbe la Nunziatina, e ne smarrì, perchè non gli parea quello il momento da frastornare il neofito con sì improvvise e pericolose impressioni. Laonde rientrato in coro, e di là uscito sulla piazzetta, venne in chiesa, e pregò gli sposi di uscire con lui; i quali avendolo seguito, come fu di fuori si congratulò con essi delle loro nozze, e chieseli dov’erano per pranzare quel giorno; cui Cencio rispose, che all’albergo di Russia.
Allora la Nunziatina domandò, se quel signore si facea frate (e qui le spuntarono di nuovo le lagrime sugli occhi). No, disse don Alessandro, ma egli ch’era protestante, oggi è venuto nel grembo della Santa Chiesa cattolica: pregate per quel buon signore.
— Se prego! Io credo da certi indizii, ch’egli sia il mio benefattore, e lo raccomando alla Madonna ogni giorno. Dite? è poi egli proprio il mio benefattore?
— I benefattori vostri, rispose don Alessandro, sono la vostra modestia e la vostra pietà, sappiateceli conservare gelosamente. O addio, andate a vedere il lago: a Roma verrò a vedervi; e cosi detto, accompagnolli un tratto acciocché non tornassero in chiesa.
Frattanto mandò in secreto ad avvertire all’albergo di Russia che dessero ai due sposi un ottimo pranzo a suo conto; perchè tornati gli sposi dopo un lungo passeggio sul lago e sotto le gallerie, e postisi a tavola, ebbero delicatissimi cibi e finissimi vini. Cencio vedendo tanta lautezza temea che gli andrebbero parecchi scudi, e finito il pranzo, alquanto peritoso, domandò lo scotto. Il donzello rispose: Signori, tutto è pagato.
CONCLUSIONE
Il mio soggiorno nel mese di luglio fu sul colle di san Francesco, il quale sovrasta la città e il porto di Pozzuoli, ch’è la più bella marina d’Italia e direi quasi del mondo. Ogni giorno al nascer del sole il mio maggior contento si era di farmi sopra una loggetta, che si sporgea dalla mia camera sopra il golfo, e dilettavami grandemente di spaziar l’occhio intorno al gran cerchio, che move dai pilieri detti del ponte di Caligola, ed appuntasi nel capo di Miseno. Al mio lato destro veggo i ruderi dell’amenissima villa di Cicerone, ch’egli nomava l’Accademia, vicina al tempio delle Ninfe; alla mia sinistra s’ergono le maestose ruine del tempio detto di Nettuno; e più sotto la costa è tutta ingombra d’archi, di fusti di muraglie, d’acquedotti, d’anditi sotterranei e di volte delle antiche terme, le quali scendono a valle insino al tempio di Giove Serapide, che si lieva superbo sopra le sue colonne di marmo africano, e co’ suoi bagni minerali ristaura le forze e ricovera a sanità i pellegrini, ch’ivi convengono a tuffarsi in quelle acque fumanti e salutari.
Tutte le pendici di coteste collinette verdeggiano del dolce colore de’ cedri, de’ limoni, de’ mandorli, e dalle pine a ombrello inframmezzate da giardini, da vigneti e da prodicelle fiorite che si specchiano e addoppiano nel mare ivi sempre limpido e spianato come un cristallo, su cui veleggiano cento barchette pescherecce, e in cui veggonsi nuotare gruppi e schiere di fanciulli a sollazzo.
I campi Flegrei salgono con mitissima erta per le coste de’ monticelli che da un lato bagnano i piedi nel lago Lucrino, e dall’altro nel lago d’Averno, cantati da Omero e da Virgilio, ov’era la Sibilla Cumana, la quale dava gli oracoli in sulla bocca di quella paurosa caverna che ancora si vede, Spelunca alta, vastoque immanis hiatu, — Scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris. Ivi presso è il lago di Cocito e il fiume Flegetonte, la palude di Stige e l’Acherusia, che sono le acque bollenti, che poscia formarono le stufe di Nerone, e sono sì calde, che alti spiragli di quelle rupi non puossi accostare il dito.
Queste cose terribili mi vengono ascose dal Monte Nuovo surto improvvisamente l’anno 1538; ma dalla mia loggia di Pozzuoli veggo in quella vece distendersi su quelle rive i Campi Elisi, e specchiarsi nella tremolante onda marina, locos Iaetos, et amoena vireta Fortunatorum nemorum, sedesque beatas. Largior hic campos, aether et lumine vestit Purpureo, specialmente quando indora i poggi di Baia, e i pomiferi colli di Cuma. Baia co’ suoi pelaghetti, e ridotti, e seni ombrosi tiene il mezzo cerchio del golfo, e dalla sua rupe domina le vaste ruine di quelle portentose ville romane, che formarono il soggiorno dei piaceri invernali degli imperatori e de’ consoli, i quali non paghi di salire coi terrazzi, cogli archi e colle gallerie lungo i fianchi e le prode del monte, nel mare stesso ne piantavano le fondamenta, sicchè Contracta pisces aequora sentiunt Iactis in altum molibus.
A Baia scerno i nobili avanzi dei templi che appellansi di Diana, di Venere e di Mercurio; e il loco e le grandi vestigia delle immense ville di Cesare, di Lucullo, di C.Mario, di Pompeo, di Pisone, di Crasso, d’Ortensio, di Nerone, di Domiziano, di Adriano, e d’Alessandro Severo. Da Baia indi l’occhio trascorre per quelle verdissime chiome insino a Baculi , ov’è la Piscina mirabile che conservava le acque dolci da fornire i legni da guerra, che isvernavano nell’ampio e sicuro porto di Miseno: e scorgo il mare di Cuma e il porto del trombettiere d’Enea, Misenum ab ilio Dicitur, aeternumque tenet per saecula nomen; e miro in esso tuttavia gli archi e le muraglie cadenti degli arsenali. Nè qui termina l’incanto di quelle prospettive; poichè veggo sorgere dietro il capo di Miseno l’isola di Procida col suo castello, colle sue torri, colle cupole de’ suoi templi che biancheggiano luccicanti fra il verde gaio de’ suoi giardini d’agrumi; e all’isoletta di Procida fa larga e sublime cornice l’isola d’Ischia colle irte punte delle sue montagne che si perdono nell’azzurro de’ cieli.
Da cotesta mia loggia alla banda di levante scerno lescagliose rupi dell’isola di Capri, la quale in sè accoglie i prestigi della grotta azzurra coi superbi avanzi dei sontuosi palazzi di Tiberio, e mi mostra sugli aspri fianchi distesa, come i nidi delle irondini, la romita città d’Anacapri, che da quelle aeree altezze domina il mare sino al capo Circeo.
Lettor mio caro, tu sei preso di certo a una dolcissima invidia di questo mio delizioso soggiorno, e ti sembra che fra tanto riso di cielo, di terra e di mare i prischi Pelasghi ponessero a buona ragione i campi Elisei, o i voluttuosi Romani edificassero le amenissime sedi de’ loro piaceri. Ma io ti vo’dire, che non lontano da cotesto mio terrazzino sorge sullo stesso colle un carcere solitario e severo, ove gemono di molte centinaia di condannati, i quali dalle grosse sbarre che inferriano le finestre veggon le stesse marine, gli stessi poggi, lo stesso cielo. Ma credi tu che cotesti infelici li mirino coi sensi dell’occhio mio, e vi trovino quella vaghezza, quel diletto e quella giocondità ch’io provo in riguardarli? A me, che li discorro coll’animo tranquillo e coll’occhio sereno, cotesti oggetti paiono a buon diritto bellissimi; ma il prigioniero li guarda bieco e pien di livore, perchè ha il seno attossicato e l’anima in tempesta. A noi pare che avremmo a ventura il poter dimorare in sì lieto paese per tutta la nostra vita, e ne chiamiamo fortunati gli abitatori; ma il prigioniere, se potesse, fuggirebbe immantinente, siccome da luoghi sinistri, e non li potrebbe poi ricordare se non con rammarico e angoscia.
Ora, venendo al mio argomento dei costumi del popolo romano, io trovo un esatto riscontro della mia introduzione in chi li riguarda con animo riposato e sincero, e in coloro che li mirano col cuore livido e astioso. A leggere parecchi viaggiatori protestanti, e peggio ancora alcuni tristi giornali d’Italia, non vedi nel popolo di Roma che una plebe corrotta ed oppressa dal reggimento sacerdotale; e dove gli uomini savi e dabbene invidiano la sua bella sorte di crescere all’ombra del Vaticano, e sotto la paterna legge del Vicario di Cristo, que’ velenosi, o ipocritamente lo compiangono di misero ed infelice, o mordonlo per neghittoso, per vile ed anco, se Dio ci ajuti, per empio. E traggono argomento di cotesta brutta e nera calunnia del mescolare che fa talora il popolo romano la divozione di certi di festivi e solenni a Dio, coi diporti e i sollazzi, che agli occhi loro sentono ancora del paganesimo; tanto costoro son divenuti pii é delicati di coscienza! Cotesti spiritualissimi però non pongono mente che l’uomo non è una pura intelligenza come gli Angioli, ma è composto d’anima e di corpo, di mente e di sensi, di pensieri e d’affetti, e non può uscire dall’ordine di sua natura. Naturam expellas furca tamen usque recurret. E ciò è sì vero, che appena l’Italia riebbesi alquanto dalle desolazioni de’ barbari, in quei secoli di fede non celebrava mai le sagre delle sue cattedrali senza aggiugnere alle feste della Chiesa anco le Fiere, alle quali conveniano suonatori, cantori e giocolieri a rallegrar le brigate. Surti poscia verso il mille i Comuni, si festeggiava il nome de’ santi loro protettori con popolari letizie. Indi Firenze avea per la festa di s. Giambattista la corsa de’ cocchi, per s. Pietro là corsa de’ barberi, pér la Natività della Madonna le luminarie della Rificolona. Pisa per s. Ranieri avea il gioco del ponte, Siena quello delle bandiere, Verona le corse del pallio, Venezia il bucintoro, la regata delle gondole, e le piramidi sulla piazzetta di s. Pietro.
Napoli ha le sue feste nel pellegrinaggio di Montevergine e alla Madonna dell’Arco, ove il ritorno de’ pellegrini è un tripudio bizzarrissimo: Amalfi ebbe ed ha le sue, Salerno le sue, Bari, Manfredonia, Brindisi, Lecce le loro, nelle quali feste i popoli, dopo gli atti di pietà, si sollazzano lietamente: ma sovra tutti i Reggiani dell’estrema Calabria, i quali per la Natività della Madonna si recano in processione al santuario di Lei sovra il monte che guarda Scilla e Cariddi, e appresso le sacre funzioni escono in sul prato che circonda la chiesa, ed ivi dato negli stromenti menan balli, danze e carole tanto vive e gagliarde, che parecchi fra uomini e donne cascan tramazzoni per istanchezza.
Ma che dico io delle grandi e popolose città, quando noi veggiamo i piccoli villaggi celebrare le loro festicciuole assai divotamente, e terminarle tutti con giochi, pasti e gaiezze prolungate, a gran notte? Il che ci fa manifesto, che lo spirito umano informando la carne vuol concedere anco a lei la parte sua, e siccome essa non dilettasi che di cose le quali cadono sotto i sensi, così secondo sua natura partecipa dei gaudii dello spirito. E volete che i Romani soli non abbiano a entrare nel novero delle creature umane impastate di quel d’Adamo?
Di certo hanno anch’essi per santa Croce le salite della Scala Santa, e poscia se n’escono a una buona merenda di cavoli trascinati, in sulle osterie del Laterano; hanno le visite delle Sette Chiese, e a mezzo il viaggio, chi n’ha, fa di buoni pranzetti lungo la via; e’ v’è in giugno la vigilia di s. Giovanni, e la notte si passa in sullo spianato cenando i calamaietti e i polpettielli fritti, aspettando l’infiorata della mattina per comperare dalle fioraie una bella ciocca da presentarne il Precursore di Cristo: per la seconda festa di Pentecoste egli s’ha a fare la santa gita in carrozza sotto Albano alla Madonna del divino amore, e udito Messa, e fatte le divozioni, ognun compera la Rosa benedetta, se ne adorna il capo, e rimessosi in carrozza, sale ad Albano, all’Aricia, a Genzano, e godesi quella bella giornata di Maggio desinando all’ombra delle annose quercie, sulla fresca erba de’ praticelli, e sulle sponde fiorite delle fontane che irrorano i giardini delle sontuose ville de’ romani patrizi.
Bè; o che male ci vedete voi? quelli che miran le cose coll’occhio scevero di malignità commendano codesti sollazzi cittadini in occasione delle feste del Signore e de’ Santi, siccome i dolci vincoli della domestica e della parentevole carità: imperocchè le buone famiglie romane vi vanno per consueto di brigata co’ suoceri, colle mogli, co’ figliuoli , co’ parenti, e dopo aver dato laude nelle chiese a Dio, e aver disfogata la loro divozione, si pigliano un po’ di ristoro pel corpo dalle lunghe fatiche de’ loro manovali esercizi. E credetelo, ne han più bisogno de’ loro sfaccendati detrattori, i quali nuotan nell’ozio e tutta la loro faccenda si è di andare in cerca di nuovi piaceri, che sogliono esser ben altro che una cenetta all’oste, un ballonzolo a suono del cembalo, e un po’ di carrozzare nel contorno di Roma e sui poggi laziali.
— Ma non di rado tutta la divozione termina coll’affogarsi nei bicchieri, e codesti divoti n’ escon brilli, trilli, cotti e spolpati — Ehimei! Eccoci alle esagerazioni di M. About, il quale per sua gentilezza dice, che il popolo romano va bensì in chiesa, senza però credere in Dio. Il romano commetterà qualche eccesso; chi lo nega? Ma l’uomo è egli uomo soltanto in Roma? E fuor di Roma son tutti Serafini ? Si sa: quando l’ artigiano vede brillare quell’oro, o quei rubini nel bicchiere, gli sembra pure un bel colore, e lo mira amorosamente, e lo si accosta a bocca, è dapprima lo si sorseggia, e ne fa il labbruzzo, e poi quel sonante pah, che gli va tutto in dolcezza: poveretto! sono otto giorni che non ne gusta; e se quel giorno di comune letizia gli scappa un po’ la mano, s’ha egli a dire: che non ha religione, ch’è uno ipocrita, e uno spregiatore de’ Santi? Che Roma non ha fede? che Roma qua, che Roma là? Quanto calzerebbe assettato a cotesti Pacomii e a cotesti Ilarioni , che veggono il fuscello nell’occhio altrui: Bada alla tua trave!
Ahi ! — Perdonate, lettori, se ho dato uno strillo; ma egli fu un amico, il quale mi giunse improvviso da lato, e mi tirò un orecchio — Che vuoi ? oh che t’ho io fatto da darmi quella strappata?
— Perdona; gli è stato così per un vezzo amichevole. Di’ un po’ a me: che carità è ella oggimai la tua di seccare il prossimo con coteste tue cicalate romanesche? Ti par egli che corrano giorni per l’Italia così sereni e tranquilli da pascerla di baie e di cianciafruscole della Nunziatina, di Menico e di Cencio? Tu ci hai stracco; e in fondo in fondo è uno voler farsi beffe de’ nostri guai. Oh non avei tu altro argomento alle mani che codeste faggiolate senza nè sale, nè pepe?
— Io credo che voi abbiate ragione da vendere; ma se io abbia poi sì gran torto, io m’appello al vostro savio giudizio. Nell’autunno del 58 essendo io presso a dar compimento al Racconto della Contessa Matilda di Canossa, il quale è d’argomento gravissimo, e mi valse lo studio forte e continuo di tante vecchie storie e leggende per oltre a un anno, io mi sentiva il capo stanco, e mi parea bisognare d’un po’ di riposo. Perchè dissi fra me: egli si vuole por mano a un tema più agevole e men serio dell’altro. Che farò? che dirò? Mentre tenzonava meco stesso mi venne veduto, passando per ponte sant’Angelo, uno stampaio, che aveva appeso lungo un muricciuolo alle funicelle di molti disegni, in fra i quali vidi una lunga distesa dei Costumi Romani incisi all’acqua forte dal famoso Pinelli — Oh gua! dissi, quivi è un libro bello e fatto: a che stillarmi il cervello a cercare argomenti? Ciò che il Pinelli tratteggiò colla punta dello stiletto, tratteggial tu colla punta della penna. La cosa mi garba; dunque all’opera.
Ma l’amico, che m’avea tirato il polpello dell’orecchio, ripigliò dicendo: L’argomento non era da questa brutta stagione, che corre sì lagrimosa per l’ Italia e per la Chiesa di Dio.
— Credete voi, risposi, ch’io non vedessi, forse meglio che altri, la difformità della cosa? Ma io avea cominciato cotesti capitoli nella quiete della campagna, a tempo ri posato, a ore tranquille, o almeno, fra i comuni sospetti, non ancora tempestose e furenti, come si volsero poi dall’Aprile in qua. Scoppiarono guerre, e rivolture terribilissime, con tutte le conseguenze funeste che ne sogliono derivare, e tuttavia io continuai questa mia canzona, come fanno i ciechi appoggiati in sul canto de’ trivi, i quali, quando hanno incominciato a cantare l’Intemerata, e’ seguitano il canto fra il tumulto delle genti, il fracasso de’ cocchi, l’urlo de’ cani, le buglie delle baruffe, e le salmodie de’ funerali.
— Oh, ti se’ bene assomigliato ai ciecolini che cantano in sui crocicchi, perocchè proprio cotesta tua canzona calza benissimo colle nenie de’ ciechi, le quali soglion essere filatesse senza nè capo nè coda, e v’entra Pilato, e v’entra Malco, e v’entra Longino appiccicati come il tuo Edmondo ne’ Costumi Romani. Che nuovo pesce è egli? e che ci ha egli a fare co’ Trasteverini? e di che ceppo esc’egli? È inglese, è francese, è tedesco, è russo? Diascol mai!
— Uh non vi scorrubbiate poi tanto: vel misi per un’intramessa, per un capriccio, per non istuccare la gente con descrizioni continue — Ma egli vi sta a pigione — E se vi sta a pigione, pagherassela di suo, chè voi di fermo non la pagate per lui. Oggidì è andazzo di vivere a pigione in casa altrui, ma senza pagare lo stallo; e trattasi de’ più bei palazzi d’Italia. I novelli abitatori vi gongolan dentro, si crogiolano in que’ ricchi letti, stansi in panciolle su quei soffici canapè, passeggiano in contegni per quelle gallerie, per quelle sale, per quei giardini ; e tutto a uffo, senza pagar nulla, anzi facendosi pagare il disagio di vivere fra quelle magnitudini. Pur chi dice loro un ette? e se cotesto povero Edmondo ha voluto fare un poco di capolino in Trastevere, dalli al poveretto!
— Or bene. Egli è però indubitato che tu scegliesti sì fatte novelle de’ costumi romaneschi per qualche lodevole intendimento; chè tu non se’ uomo da scrivere per iscrivere, ma tiri scrivendo a far sempre qualche buono offizio ai tuoi lettori.
— E deste nel segno per appunto. Io già l’accennai più volte nel decorso dell’argomento; ma dacchè ora me ne interrogate a prova, dirovvi: che volli fare un po’ di difesa di cotesto popolo romano al cospetto d’Italia, che nol conosce gran fatto, e lo si vede il più delle volte dipinto a falsi e bugiardi colori da certe penne, che l’astiano a morte soltanto pel delitto, gravissimo agli occhi loro, di serbare salda e incontaminata la sua Fede. S’egli fosse un popolo scredente, credete voi che tanti viaggiatori, i quali scrivon di Roma il peggio che possono, morderebbonlo della sua miscredenza, della sua indivozione, della sua mislealtà, essi che non credono in Cristo, nella sua Redenzione e nella sua Chiesa? Essi che il vorrebbero tale appunto, quale spaccianlo, per istizza di non lo trovare a seconda dei lor pravi consigliamenti? Coteste lingue d’oro che hanno i più alti e meravigliosi encomii per Ginevra, e magnificano e gloriano la sua fede, la sua costumatezza, la sua pietà, non trovano vituperi adequati a riprovare l’abbominazione di Roma e del popol suo. E la cosa stesse ne’ soli protestanti, i quali meritan talora più compassione, che dispetto: ma voi trovate somiglianti calunnie sotto le penne d’uomini vili, che le vendono a prezzo, e imbrattan le carte d’ogni perfidia a scherno del vero, pronti per danaro a disdire quanto aveano asserito con ogni asseveranza, e lodare quanto avean biasimato e maladetto dapprima. Intanto chi non conosce la turpitudine di cotesti animi venderecci, legge quelle oscene bugie contra il popolo romano, e se ne travisa in capo il verace concetto. Or ho stimato opera giusta e generosa il ritrarne le sue fattezze naturali, e segnatamente di porgerlo sotto l’individuo e speciale aspetto della sua Fede.
Mentre io parlava con un certo calore queste parole, ci s’erano già accostati il mio carissimo don Giulio e don Alessandro Mansionario, i quali per avventura uscendo dal palazzo Coramboni attraversavano la piazza Rusticucci: onde che don Giulio postemi le mani verso la bocca, quasi in atto di turarmela dolcemente — Zitto là, disse, non ti vantare, amico, d’aver punto nulla ritratte le fattezze naturali del popolo romano, poichè sappi che tu se’ accagionato per converso d’averle alterate sformatamente; e v’ha chi te ne vuole a morte siccome denigratore di Roma, quasichè i signori e i cittadini romani fossero gente da trivio e da taverna. Aggiungono che tu se’ ito a razzolare, come i pattumai, le usanze ne’ vicoletti, per le vie sterrate e per le piazzuole del popoletto più minuto e plebeo, che abiti i sette Colli. Di più sappi a tua consolazione, ch’io ebbi lettere tanto stizzose a questo riguardo, le quali giurano che tu hai vituperato colle tue descrizioni e colle tue difese il popolo romano più assai che non fecero nel loro astio contro Roma la Gazzetta del Popolo di Torino e il Corriere Mercantile di Genova.
— O grosse, o nulla eh don Giulio! Udite me. Gli antichi Romani quando si difendeano contro gli accusatori , volgeansi alla Curia Ostilia, ai Rostri, alla rupe Tarpea , e li chiamavano in testimonio della giustizia della loro causa: io invece chiamo a udirmi e a testimoniare per me l’obelisco di piazza s. Pietro, sotto la cui ombra dico ora le mie difese. Primieramente io non dissi di parlare che del popolo; se avessi voluto parlare del Patriziato romano, avrei commendato a cielo la sua nobiltà, la sua grandezza, la sua magnificenza, che non ha pari in Italia, e avrei predicato a gran voce la sua liberalità verso i poveri, e più di tutto la sua Fede Cattolica, nella quale i Principi e le Matrone romane sono segnalatissimi, nè niuno oserebbe di contraddirmi.
Se poi avessi vòlto il ragionamento intorno ai Cittadini, avrei avuto il più vasto campo a descrivere la loro urbanità , la loro piacevolezza, la loro cortesia e gentilezza invero eminenti; e s’io avessi detto, che in fatto d’ingegni, di studii, d’ogni più alta dottrina sacra e profana, in cultura di lettere antiche e moderne e in isquisitezza d’ogni più gentil ramo delle arti belle, non v’è città, non dico italiana, ma forse di tutta Europa, che possa reggere al paragone di Roma, non mi crederei d’averle dato un vanto, che mi acquistasse nota di adulatore o di lusinghiere. Arrogi la viva fede e la soda pietà specialissime di tante ottime famiglie cittadine, ch’io dipinsi ad accesi colori sino dal primo esordio di cotesta mia trattazione. Nella classe cittadina v’è la sua corruzione come per tutto altrove; v’ha i suoi scredenti, i suoi razionalisti, i suoi dogmatizzanti ogni pessimo errore e i suoi dilettanti di congiure e di sedizioni, chi vorrà negarvelo? Ma il pieno della cittadinanza romana, o vogliate credervelo o non vogliate, conserva salda e inviolabile quella Fede che l’Apostolo Paolo dicea commendarsi da tutto il mondo.
A riguardo poi del popolo romano, che solo ho tolto a descrivere, che ci trovate voi detto da me a suo incarico? Dapprima ho esaltato a buona ragione la sua Fede e la sua Religione, e ve l’ho provato con due lunghi capitoli, ne’quali denunziai a tutta Italia, ch’io non ho detto il centesimo degli esempi e delle pratiche della sua pietà: bisogna essere stato in Roma una ventina d’anni per formarsi un’idea adeguata di cotesto popolo singolare, il quale, in mezzo ai suoi difetti, ha doti meravigliose di nobiltà, di grandezza, d’eccellenza, di generosità d’ornamento, di costumi, di ricchezza d’ingegno.
— Sì sì, a tuo grado, ripigliò don Giulio; ma dicono tutti a una lingua, che tu l’hai fatto superbo, iracondo, vendicativo, accoltellatore, con altre brutte magagne che sapeano del barbaro e del selvaggio, e appuntano qui don Alessandro nostro, che t’abbia dato di mano e di spalla per diseppellire certe volgari costumanze, le quali dimostrano nel popolo romano una fame inesplebile di sollazzi e di gozzoviglie.
Don Alessandro a queste parole si mutò in viso; e disgroppate le mani, che teneva al solito dietro le reni, scagliò il braccio diritto col pugno chiuso e coll’indice disteso, a maniera degli oratori; e guardato fisso in volto a don Giulio, esclamò eon voce sonora: Di’ a costoro in mio nome, che se vogliono trovare un popolo senza difetti lo si cerchino in paradiso, che in terra nol troveranno: quando forse non veggano cotesta fenice appollaiata bellamente in Ginevra, nelle valli de’ Valdesi e tra i Fratelli Moravi, o fra i Quaqueri ; perocché cotesti dipintori delle virtù de’ popoli non sanno rinvenirle che nelle comunanze protestanti; e più i popoli son cattolici, e più essi li veggon corrotti e accomodatissimi ad ogni pravità più nefanda.
Che il popolo romano sia di natura sua risentito e subito all’ira io nol vi vo’ contendere, poichè gli corre tuttavia nelle vene il sangue latino, e con esso quell’alto vigor di spiriti alteri e generosi, che sempre non sa temperare, e talora lo spronano alla vendetta: ma s’egli pecca per impeto, non pecca mai di tradimento e di viltà, e ripara poi grandemente il suo fallo coll’agevolezza e magnanimità del perdono. Io poi ho detto più volte, che ora, mercè l’opera indefessa del clero romano, il popol di Roma cresce più mite, costumato ed urbano che mai; così non ci mettesse la trista zampa il demonio per mezzo d’altri apostoli corrompitori d’ogni bene sotto il titolo di civiltà, di garbatezza sociale, di progresso indefinito, di libertà d’intelletto e di cuore, che affascina eziandio le menti della plebe ignara delle astuzie infernali de’ nemici di Cristo e della Chiesa.
Nel rimanente il popolo romano ama per certo gli spettacoli ed i sollazzi, come ogn’altro popolo del mondo; ma non vi si abbandona per modo ch’egli divelga per essi la Fede che altamente ha radicato nell’animo cristiano per eccellenza. Volete voi vedere come i Romani godono le feste popolari? Per assolvermi di molte dimostrazioni in un sol fatto, io non voglio citarvi, che quello tanto illustre avvenuto quest’anno al cospetto di tante migliaia di forestieri cattolici, scismatici e protestanti, che li riempì d’inestimabile meraviglia.
Era l’ultimo giorno di carnovale, che quest’anno, essendosi dopo dieci anni permesso le maschere, fu più splendido, giulivo, bizzarro e chiassoso che mai. Le maschere aveano le più ridicole e pazze forme, ed eran numerosissime. Già la famosa luminaria dei moccoletti sul Corso avea reso le maschere più baldanzose, più ghiribizzose e pazze. Suonò l’ora di notte; si spensero i moccoli, e a torrenti per le vie traverse del Corso s’accalcavano per ritornare alle case loro e ai loro ritrovi. Per una di quelle vie più larghe e più popolose, nel maggior impeto del tripudio, ecco passare il Santissimo Viatico, il quale tornava da un infermo della parrocchia di sant’Agostino. A quella vista la folla immensa si strappa la maschera, si gitta in adorazione a ginocchi, risponde alla recitazione de’ salmi, nè si leva indi, sinebè l’augustissimo Sacramento non abbia vòlto il canto e sia fuori della vista. Molti di quelli che diconsi in bauta (la quale è un mezzo mascherino, e la persona veste una mantiglia nera), toltasi la larva dal viso, seguitarono composti e divoti la processione, ed entrarono in sant’Agostino a pregar per l’ infermo e a ricevere la benedizione di Cristo in Sacramento.
Eh, amici! Oh ditemi, per amor vostro, è ella fede cotesta e pietà di buona ragione? Si stampò questo avvenimento come cosa singolarissima sopra i giornali, e il mondo ne rimase stupito. Ma per conoscere appieno la tempera della Fede romana, bisognerebbe usare famigliarmele nell’interno delle pareti domestiche; vedere le pratiche di pietà così naturale in ciascuno; assister gli infermi; confortar li moribondi; udire con che fiducia le madri consegnano alla divina Provvidenza i loro figliuoli che rimangono derelitti. Anche giorni sono io assisteva una giovane sposa inferma al Ponte a quattro Capi: la malattia incalzava, le forze venian meno, tre figliuoletti le piangevano intorno al letto; essa, bellissima e di venticinqu’anni, se li guardava e colloquiava con essi, animandoli a sperare ogni aiuto dalla Madonna; l’accennava là alla parete, innanzi a cui ardeva un lumicino; e le si volgea cogli occhi e le parlava come figliuola a madre, dicendo: Eh, Mamma, non me li abbandonerete, n’è vero? Son vostri, ve gli ho sempre offerti, ora ve li dono; custoditeli, nutriteli Voi.
Io vi tornai verso la sera; e trovo presso l’inferma una giovane che la pettinava accuratamente e le ungeva i capelli, che lunghi e biondi e copiosissimi erano — Ti par egli, Angelina, diss’io, d’attendere a queste vanità ora che sei vicina a morire? — Ah, padre mio, vi pare! Dio me ne guardi, rispose: quest’amica mi ravvia i capelli perché ora, prima ch’io muoia, me li taglia, ch’io gli ho già venduti a un parrucchiere per uno scudo, e così i miei figliuoletti avranno un po’ di pane per qualche giorno: dopo ci penserà la Madonna — E così detto, l’amica le tagliò la treccia, e da me confortata, prima della mezza notte rese la sua bell’anima a Dio.
O don Giulio, va, e di’ a’ nostri censori: che assai più vale in un popolo cristiano un po’ di ruvidità con molta fede, che poca fede con molta gentilezza. Ho detto.
FINE