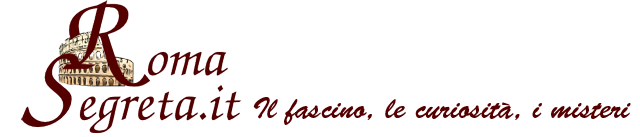Mastro Titta, soprannome di Giovanni Battista Bugatti, nacque a Senigallia il 6 marzo 1779 e morì a Roma il 18 giugno 1869. Ufficialmente il suo mestiere era quello di verniciatore di ombrelli, ma in realtà era il boia dello Stato Pontificio, il “maestro di giustizie” (da cui il termine Mastro, mentre Titta è un diminutivo del suo nome). Noto anche come “er Boja de Roma”, iniziò la sua carriera di incaricato delle esecuzioni delle condanne a morte il 22 marzo 1796 e fino al 17 agosto 1864 (ovvero fin quando andò in pensione, con un vitalizio mensile di 30 scudi, sostituito dal suo aiutante Vincenzo Balducci) raggiunse la quota di 514 nomi di giustiziati, anche se sul taccuino che Bugatti trascrisse meticolosamente ne furono annotati 516: dal conto vengono sottratti due condannati, uno perché fucilato e l’altro perché impiccato e squartato dall’aiutante. Da questo taccuino, nel 1891, l’editore Edoardo Perino prese spunto per pubblicare, a dispense, le memorie del carnefice in chiave romanzata dal titolo “Mastro Titta, il boia di Roma: Memorie di un carnefice scritte da lui stesso”: si ritiene che lo scrittore fosse Ernesto Mezzabotta, ma ufficialmente l’autore restò sconosciuto. Nelle province dello Stato Pontificio, ma soprattutto a Roma, il termine Mastro Titta divenne sinonimo di boia, tanto per indicare i molti che lo precedettero quanto i pochi che lo seguirono. Mastro Titta non era certamente amato dai suoi concittadini, per cui viveva in una sorta di domicilio forzato all’interno della cinta vaticana, sulla riva destra del Tevere, al numero 2 di vicolo del Campanile, anzi gli era addirittura vietato, per prudenza, recarsi nel centro della città, dall’altro lato del Tevere (donde il proverbio romano “Boia nun passa ponte“, a significare “ciascuno se ne stia al proprio posto“). Ma siccome a Roma le esecuzioni capitali pubbliche decretate dal Papa Re, soprattutto quelle “esemplari” per il popolo, non avvenivano nel borgo papalino, ma sull’altra sponda del Tevere (piazza del Popolo, piazza di Ponte, Campo de’ Fiori o via dei Cerchi), in eccezione al divieto il Bugatti doveva attraversare ponte (ovvero ponte S.Angelo) per andare a prestare i suoi servigi: ciò diede origine all’altro modo di dire romano “Mastro Titta passa ponte“, a significare che quel giorno era in programma l’esecuzione di una sentenza capitale. Prima di ogni esecuzione Mastro Titta si confessava e si comunicava, poi indossava il mantello rosso (nella foto in alto sotto il titolo) e si recava a compiere l’opera; quando mazzolava, impiccava, squartava o decapitava, il boia operava con uguale abilità e spesso andava a svolgere la sua attività anche nelle province.

Fino al 1870, ai tempi in cui la città era governata dal Papa Re come una monarchia assoluta, le pubbliche esecuzioni erano uno degli spettacoli preferiti dal popolino (nella foto 1 notare la gran folla presente all’esecuzione di Monti e Tognetti in via dei Cerchi), che non solo trovava questa pratica ripugnante di proprio gradimento, ma addirittura portava i figli maschi ad assistere allo spettacolo per mostrare loro ogni dettaglio della cerimonia: proprio nel momento in cui veniva giù la lama (…e la testa) o quando, in caso di impiccagione, il condannato rimaneva appeso, era consuetudine dare loro uno sganassone (cioè uno schiaffo), come strumento educativo e tangibile ricordo di ciò che sarebbe potuto loro accadere il giorno che si fossero messi nei guai con la giustizia. Dinanzi a tali spettacoli si radunava non soltanto il popolo ma anche poeti e scrittori: Giuseppe Gioachino Belli immortalò un’esecuzione in un famoso sonetto chiamato “Er dilettante de Ponte”, mentre due celebri autori inglesi lasciarono una descrizione molto dettagliata. Il 19 maggio 1817 George Gordon Byron si trovava a piazza del Popolo mentre tre condannati venivano decapitati (…per omicidj e grassazioni, scrisse Mastro Titta nel suo taccuino) ed il poeta narrò questa esperienza in una lettera indirizzata al suo editore John Murray. “La cerimonia, compresi i preti con la maschera, i carnefici mezzi nudi, i criminali bendati, il Cristo nero e il suo stendardo, il patibolo, le truppe, la lenta processione, il rapido rumore secco e il pesante cadere dell’ascia, lo schizzo del sangue e l’apparenza spettrale delle teste esposte, è nel suo insieme più impressionante del volgare rozzo e sudicio new drop (in pratica l’impiccagione) e dell’agonia da cane inflitta alle vittime delle sentenze inglesi». Un ricordo ancor più dettagliato lo lasciò Charles Dickens durante il viaggio che compì in Italia fra il luglio 1844 ed il giugno dell’anno successivo. Nella giornata di sabato 8 marzo 1845, mentre era di passaggio a Roma, assistette ad una esecuzione in via dei Cerchi effettuata da Mastro Titta, che commentò nel suo libro Pictures of Italy (“Lettere dall’Italia”, 1846). Dickens così racconta: “Un sabato mattina (l’otto marzo), qui un uomo venne decapitato. Nove o dieci mesi prima, aveva rapinato per strada una contessa bavarese diretta in pellegrinaggio a Roma , da sola e a piedi, ovviamente, mentre compiva quell’atto pietoso, si dice, per la quarta volta. La vide cambiare una moneta d’oro a Viterbo, dove egli viveva; la seguì; le offrì la propria compagnia lungo il viaggio per quaranta miglia o più, con l’infido pretesto di proteggerla; la assalì, portando a compimento il suo inesorabile piano nella campagna, a brevissima distanza da Roma, presso ciò che viene denominata (senza esserlo) la Tomba di Nerone; la derubò; e la percosse a morte con lo stesso suo bastone da pellegrino. Era sposato da poco, e regalò alcuni dei beni della vittima alla moglie, dicendole che li aveva comprati ad una fiera. Ella, tuttavia, che aveva visto la contessa-pellegrina attraversare la loro città, riconobbe alcune chincaglierie che le appartenevano. Suo marito allora le raccontò ciò che aveva commesso. Ella, in confessione, lo riferì ad un sacerdote; e l’uomo fu catturato, entro quattro giorni dopo aver commesso il crimine…. Dopo un breve lasso di tempo, alcuni monaci dalla detta chiesa furono visti avvicinarsi al patibolo; e sopra le loro teste, avanzando lentamente e tristemente, l’effige di Cristo in croce, bardato di nero. Questa fu trasportata attorno alla base del patibolo, fin sul davanti, e girata verso il criminale affinché potesse vederla fino all’ultimo. Era a malapena giunta a destinazione, quando costui apparve sulla sommità del patibolo, scalzo; le mani legate; e col collo della camicia tagliati fin quasi alle spalle. Un giovane uomo, circa ventisei anni, di robusta costituzione, e ben proporzionato. Pallido il viso; baffetti scuri e capelli bruni. Apparentemente, aveva rifiutato di confessarsi senza prima fargli incontrare la moglie; così era stata inviata una scorta a prenderla, ciò che aveva cagionato il ritardo. Si inginocchiò subito, sotto la lama. Il collo, posizionato in un foro, realizzato all’uopo in un ceppo orizzontale, fu serrato da un simile ceppo situato superiormente; proprio come in una gogna. Subito sotto di lui era una borsa di cuoio. E in questa la sua testa rotolò all’istante. Il boia la teneva per i capelli, camminando tutt’intorno al patibolo, mostrandola alla gente, prima ancora di potersi render conto che, con un secco rumore, la lama era pesantemente scesa. Quando ebbe fatto il giro dei quattro lati del patibolo, fu fissata in cima a un palo sul davanti, una piccola chiazza bianca e nera, che la lunga via poteva scrutare, e su cui le mosche potevano posarsi. Gli occhi erano rivolti in alto, come se avesse distolto lo sguardo della borsa di cuoio, e avesse guardato verso il crocifisso. Ogni colore e sfumatura vitale l’aveva, in quel momento, abbandonato. Era grigia, fredda, livida, cerea. Così era anche il corpo…. Il corpo fu trasportato via a tempo debito, fu ripulita la lama, smontato il patibolo, e smantellato l’intero odioso apparato. Il boia: un fuorilegge EX OFFICIO (quale ironia sulla Giustizia!) che per la vita non osa traversare il Ponte di S.Angelo se non per svolgere il proprio lavoro: si ritirò nella sua tana, e lo spettacolo poté dirsi concluso.…”. Come osserva Dickens nella sua cronaca, in caso di decapitazione la testa veniva mostrata immediatamente alla folla dai quattro lati del patibolo, prima di essere lasciata in bella mostra per qualche tempo, di solito infilzata alla cima di un palo (ciò che in tempi anteriori si usava fare, per tempi assai più lunghi, sui due lati di ponte S.Angelo). Pur professando uno dei mestieri più orribili, Mastro Titta faceva il suo dovere con distacco e professionalità, tanto che a volte era uso offrire ai condannati un’ultima presa di tabacco o un sorso di vino, quasi a volerli rassicurare sulla sua professionalità. Le tecniche comprendevano l’impiccagione, il mazzolamento (cioè l’uccisione con un preciso colpo di mazza), la decapitazione a mezzo ghigliottina (prima della Rivoluzione Francese si usava un semplice colpo d’ascia) e persino lo squartamento; quest’ultima era una pena aggiuntiva, comminata ai rei di crimini particolarmente efferati, come l’omicidio di un prelato, e veniva inflitta dopo l’uccisione, al corpo ormai privo di vita, con successiva affissione dei quarti smembrati ai quattro angoli del patibolo.

L’unico ricordo rimasto di Mastro Titta, oltre alla fama leggendaria, è il mantello scarlatto (in dettaglio nella foto 2) che il boia indossava durante le esecuzioni, oggi in mostra al Museo Criminologico. Il Museo custodisce anche il coltello del carnefice di Roma (nella foto 3), con il manico di bronzo, a tortiglione, con sovrapposta una testa di leone, con la quale si eseguiva la condanna alla mutilazione, riservata solitamente agli indigenti che non avevano i mezzi per pagare forti multe, che poteva prevedere l’asportazione di occhi, il taglio di orecchie e nasi o, per i ladri colti in fragranza, il taglio della mano sinistra la prima volta e, in caso di recidiva, della mano destra.

La straordinaria notorietà che assunse la sua persona fece sì che venne inserito addirittura in una commedia musicale, quella di Garinei e Giovannini, “Rugantino”, interpretato dal grande Aldo Fabrizi nella prima e seconda edizione (1962 e 1978), da Maurizio Mattioli nelle edizioni del 1998, 2001, 2004 e 2010, infine da Vincenzo Failla nell’ultima edizione, quella del 2013. Dall’opera “Mastro Titta, il boia di Roma: Memorie di un carnefice scritte da lui stesso” riportiamo ora un breve passo di quella descritta come la “prima opera”: “Esordii nella mia carriera di giustiziere di Sua Santità, impiccando e squartando a Foligno Nicola Gentilucci, un giovinotto che, tratto dalla gelosia, aveva ucciso prima un prete e il suo cocchiere, poi, costretto a buttarsi alla macchia, grassato due frati. Giunto a Foligno incominciai a conoscere le prime difficoltà del mestiere: non trovai alcuno che volesse vendermi il legname necessario per rizzare la forca e dovetti andar la notte a sfondare la porta d’un magazzino per provvedermelo. Ma non per questo mi scoraggiai e in quattr’ore di lavoro assiduo ebbi preparata la brava forca e le quattro scale che mi servivano. Nicola Gentilucci frattanto, a due ore di notte, dopo avergli rasata la barba e datogli a vestire una candida camicia di bucato e un paio di calzoni nuovi, venne condotto coi polsi stretti da leggere manette, nella gran sala comunale, poiché volevasi dare la massima solennità all’esecuzione, stante la gravità del suo delitto, superiore a qualsiasi altro, trattandosi dell’uccisione di un curato e di due frati. La compagnia dei Penitenti Bianchi in abito di cerimonia, col cappuccio calato sul volto, schierata in due file, dalla porta all’estremità opposta l’attendeva. In faccia alla porta era stato collocato un grande crocifisso con due confrati ai lati, e una schiera di religiosi, invitati a confortare il paziente. Il bargello e gli sbirri che lo conducevano, giunti alla porta della sala, bussarono e questa venne aperta. Quella scena commosse vivamente il Gentilucci, nondimeno entrò. Non appena ebbe fatti pochi passi il balio, aiutante del cancelliere, che ne porta gli emblemi, gli presentò una carta dicendogli: “Nicola Gentilucci, io ti cito a morte per domattina”. Il complimento poco gentile impressionò il condannato per modo che si lasciò sfuggire di mano la carta, e sarebbe caduto egli stesso svenuto, se non lo avessero sorretto il confessore e i confortatori, i quali lo condussero poi in una sala vicina, dove, sdraiato su di un materasso posto per terra, lo lasciarono dormire. Due ore innanzi lo spuntare del giorno susseguente lo svegliarono per fargli ascoltare la messa: il confessore gli parlò e gli impartì l’assoluzione e l’indulgenza in articulo mortis che il papa soleva concedere in tali circostanze. Confessato e comunicato, i confortatori gli apprestarono l’asciolvere. Gentilucci mangiò, bevve e si trovò alquanto rinfrancato d’animo. Nondimeno il confessore lo confortò ancora, assicurandolo che egli stava per avviarsi al cielo. Il condannato avrebbe forse desiderato di differire d’un altro mezzo secolo il viaggio, ma assicurato che non avrebbe che differita la sua felicità, si preparò a farlo allegramente. Mi presentai in quel mentre e togliendomi il cappello ossequiosamente offersi una moneta al Gentilucci, come di rito, perché facesse celebrare una messa per la sua anima. Quindi, ricopertomi il capo, gli legai le mani e le braccia in modo che non potesse fare alcun movimento tenendone i capi nelle mie mani per di dietro. La Confraternita della Morte aperse il corteo. I confrati indossavano il loro saio ed avevano il viso coperto. Essi salmodiavano in tetro tono il Miserere. Venivano poi i Penitenti Azzurri, ultimi i Penitenti Bianchi ai quali era serbato il posto d’onore: cantavano pur essi nel medesimo tono il salmo stesso, seguendo gli uni agli altri, per non interrompersi, di guisa che quando gli uni cantavano gli altri tacevano. Dopo le confraternite v’erano i bargelli delle città vicine e gli sbirri in grande uniforme, e a questi teneva dietro il paziente, condotto pei capi della fune da me stesso, – umile ma pur raggiante in tanta gloria – circondato dai confortatori e dal confessore. Giunto sulla spianata ove doveva aver luogo l’esecuzione, Nicola Gentilucci fu fatto avvicinare ad un piccolo altare eretto di fronte alla forca e quivi recitò un’ultima preghiera. Poi, rialzatosi, lo condussi verso il patibolo a reni volte, perché non lo vedesse e fatto salire su una delle scale, mentre io ascendevo per un’altra vicinissima. Giunto alla richiesta altezza, passai intorno al collo del paziente due corde, già previamente attaccate alla forca, una più grossa e più lenta, detta la corda di soccorso, la quale doveva servire se mai s’avesse a rompere la più piccola, detta mortale, perché è questa che effettivamente strozza il delinquente. Il confessore e i confortatori intanto, saliti sulle due scale laterali, gli prodigavano le loro consolanti parole. Gli altri confortatori in ginocchio recitavano ad alta voce il Pater noster e l’Ave Maria e il Gentilucci rispondeva. Ma appena ebbe pronunziato l’ultimo Amen, con un colpo magistrale lo lanciai nel vuoto e gli saltai sulle spalle, strangolandolo perfettamente e facendo eseguire alla salma del paziente parecchie eleganti piroette. La folla restò ammirata dal contegno severo, coraggioso e forte di Nicola Gentilucci, non meno che della veramente straordinaria destrezza con cui avevo compiuto quella prima esecuzione. Staccato il cadavere, gli spiccai innanzitutto la testa dal busto e infilzata sulla punta d’una lancia la rizzai sulla sommità del patibolo. Quindi con un accetta gli spaccai il petto e l’addome, divisi il corpo in quattro parti, con franchezza e precisione, come avrebbe potuto fare il più esperto macellaio, li appesi in mostra intorno al patibolo, dando prova così di un sangue freddo veramente eccezionale e quale si richiedeva a un esecutore, perché le sue giustizie riuscissero per davvero esemplari“.
Nella sezione Roma nella Letteratura abbiamo pubblicato l’intera opera
“Mastro Titta, il boia di Roma: Memorie di un carnefice scritte da lui stesso”.