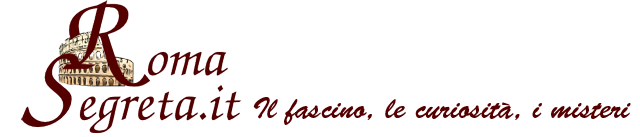La via prende il nome dalla chiesa di S.Ambrogio de Maxima (nella foto sopra), edificata, secondo la tradizione, sulle rovine della casa paterna di S.Ambrogio, vescovo e patrono di Milano. Una conferma alla tradizione sembra derivare dal Liber Pontificalis che la indica come monasterium S.Mariae quod appellatur Ambrosii, mentre il Catalogo di Torino la chiama monasterium S.Mariae de Maxima. La chiesa ebbe anche altri appellativi: nel secolo XIV era denominata S.Stefano de Maxima, poi fu detta anche S.Maria in Formosa e nel Catalogo di Pio IV S.Antonio della Massima. Sembra ormai opinione comune che il toponimo de Maxima sia da mettere in relazione alla Cloaca Maxima, ma la non breve distanza di quest’ultima dalla chiesa lascia più di qualche dubbio sull’esattezza dell’attribuzione. Appare invece più probabile che il toponimo Maxima possa derivare dalla Porticus Maximae, la lunga strada porticata che ricopriva la Via Tecta (in latino tecta significa “coperta”), con un percorso ripetuto grosso modo dalle odierne vie del Portico di Ottavia, di S.Maria del Pianto, dei Giubbonari, dei Cappellari, dei Banchi Vecchi e del Banco di S.Spirito, collegando il Teatro di Marcello con il Ponte Elio: rimasta in uso durante tutto il Medioevo, la strada, nel suo tratto iniziale, transitava nelle immediate vicinanze della chiesa.

Al civico 3 della via è situato il portale del convento (nella foto 1) sopra il quale vi è la scritta PATERNA S.AMBROSII DOMUS, ovvero “Casa paterna di S.Ambrogio”, che non può essere una conferma della veridicità della tradizione perché la targa fu apposta dai Benedettini soltanto nel 1861. Una conferma invece potrebbe derivare da un’altra tradizione secondo la quale nel 313 Papa Liberio avrebbe qui consacrato monaca la sorella di S.Ambrogio, S.Marcellina, la quale, in seguito, avrebbe officiato la chiesa insieme ad una sua comunità religiosa. Successivamente la chiesa fu affidata alle Benedettine che vi dimorarono fino al 1860, anno in cui furono espulse per ordine della Santa Sede in quanto ree di “culto illecito” nei confronti della badessa Maria Agnese Firrao, che era stata reputata “falsa mistica” ed allontanata dal convento nel 1816: da allora chiesa e convento furono affidati ai Benedettini di Subiaco.

Nel XVII secolo la chiesa fu ricostruita per volontà della badessa Olympia de Torres e di suo fratello, il cardinale Ludovico, lavori ai quali sembra abbiano partecipato anche artisti di alto livello come Orazio Torriani, Giovan Battista Mola e Carlo Maderno. L’iscrizione, posta sopra il portale di accesso al civico 5 della via (nella foto 2), inquadrato dalla bellissima cornice marmorea così recita:
MONIALES HUIUS ECCLESIAE B VIRGINI MARIAE
AC S.AMBROSIO DE MAXIMA DICATAE
ORDINIS S.BENEDICTI
LIBERALITATE OLYMPIAE DE TORRES ABBATISSAE
EREXERUNT AN DOM MDCXXII
ovvero “Le monache di questa chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria ed a S.Ambrogio de Maxima, per generosità della badessa Olympia de Torres dell’Ordine di S.Benedetto, eressero nell’Anno del Signore 1622”.

Varcato l’ingresso troviamo un secondo cancello in ferro (parzialmente visibile nella foto sotto il titolo) che immette in un cortile sul quale prospetta la semplice facciata della chiesa ed una fontana a parete (nella foto 3), costituita da due piccole nicchie laterali ed una più grande centrale, raffigurata con elementi rocciosi a mo’ di grotta, sopra la quale vi è collocata una statua acefala (senza testa) raffigurante una Madonna, adorna ai lati di un motivo a nastro con cascata di fiori. Molto bella la vasca, costituita da un sarcofago romano in marmo che presenta alle estremità due leoni in rilievo.

L’interno (nella foto 4) presenta una pianta a croce latina e due cappelle laterali per lato. L’altare maggiore, progettato da Giovanni Maria Morandi agli inizi del Settecento, è ornato da quattro colonne ioniche in marmo nero e la pala d’altare contiene un moderno dipinto di Ambrogio Fumagalli raffigurante S.Ambrogio che resuscita la figlia di una povera donna. Sopra la pala si trova un dipinto più piccolo di autore anonimo del XVII secolo raffigurante la Sacra Famiglia. Sotto l’altare si trovano le reliquie di S.Policarpo, uno dei primi martiri orientali.